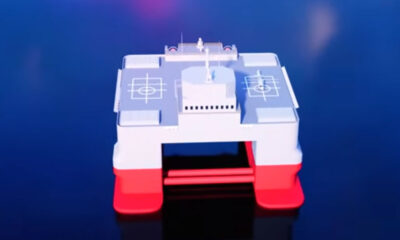Pensiero
Mafia e anarchici, tutti pazzi per il 41 bis

È davvero singolare questa coincidenza: acchiappano il vertice percepito di Cosa Nostra, e pochi giorni dopo ecco che contro il 41 bis – divenuto d’un tratto tema da prima pagina – cominciano a parlare gli anarchici.
Perché, nelle temutissime manifestazioni di cui abbiamo veduto le immagini in questi giorni, non possiamo aver notato striscioni che non erano solo contro il 41 bis al terrorista Alfredo Cospito, erano contro al 41 bis in generale.
In realtà, la notizia prescinde da questa passione improvvisa per l’articolo dell’ordinamento penitenziario italiano voluto dal marito della giovane parlamentare piddina Lia Quartapelle, cioè il vecchio craxiano Claudio Martelli.
Vogliamo dire: la notizia è che sono tornati gli anarchici. Cioè: gli anarchici esistono. Scusate ma a questo punto mica era scontato.
Per quanto sia confuso e fastidiosamente puerile, potete aver presente a cosa aspirano gli anarchici: una libertà assoluta, la mancanza totale di autorità, la disintegrazione dello Stato al fine di non ricostruirne più alcuno.
Ecco, negli ultimi due anni gli anarchici, come tutti noi, sono stati confinati privandoli di qualsiasi libertà, sono stati schiacciati da autorità violente e dementi, sono stati sottoposti allo Stato nella sua forma più soverchiante e coercitiva: il biennio pandemico, impossibile non riconoscerlo, ha significato tutto questo.
Per cui ci aspettavamo che se c’era un momento giusto per esprimere la rabbia anarchica, un punto della storia del Paese e dell’Europa e del mondo in cui avremmo visto gli anarchisti uscire e agire, beh, certo sarebbe stato durante l’ora della sottomissione COVID. E invece, niente. Non siamo in grado di dirlo con certezza, ma di anarchici, alle manifestazioni dei sabati contro il green pass (in Italia e in ogni altro Paese), praticamente non ne abbiamo visti.
Ma come, non si chiamano proprio «anarco-insurrezionalisti»? Così su Wikipedia definiscono il Cospito. Ma quindi non era quello il momento in cui far scattare la loro agognata «insurrezione»? A quanto pare no: ricorderete che i giornali ci parlavano invece delle piazze no-vax «fasciste», accusa ripetuta in Italia come in Francia, in Canada, in Germania, ovunque.
Poi però ecco che – puf! – gli «anarchici» saltano fuori ora. Fanno manifestazioni. Inneggiano a Cospito con graffiti e azioni perfino in altri Paesi. Gli anarchici sono stati, come dire, «attivati».
Uso questa parola perché è quella che qualche smaliziato commentatore americano ha iniziato ad utilizzare per i recenti fatti di Atlanta, in Georgia. In pratica, gli «antifa» – una sigla che morfologicamente non è in nulla dissimile dagli «anarchici» – ha fatto una sua protesta con assalto ad un hotel, vetrine spaccate, macchina della polizia incendiata. Tucker Carlson, in diretta TV davanti a milioni di telespettatori, ha avanzato con estrema sicumera la sua teoria: gli «antifa», ha detto, sono stati «attivati». Così come lo erano stati nel 2020, nelle proteste Black Lives Matter, una piccola «rivoluzione colorata» negli stessi USA volta a detronizzare Trump, dice Carlson.
Poi, in effetti, defenestrato il ciuffo biondo con l’elezione più grottescamente controversa della storia, BLM e gli antifa sono spariti. Per anni. Fino alla rivolta di Atlanta, e a quella che stavano per intentare per l’orrendo omicidio da parte della polizia del ragazzo di colore Tyler Nichols: il disastro, stile Los Angeles messa ferro ignique nel 1992 (dopo l’assoluzione dei poliziotti protagonisti del pestaggio del cittadino nero Rodney King), era pronto a partire… ma tutto è stato rinviato, perché i cinque poliziotti presunti assassini sono tutti afroamericani. Per quanto giornali e grandi testate TV abbiano detto che la colpa è comunque della white supremacy, la supremazia bianca, i cui valori di violenza contro i neri sarebbero stati introiettati dagli stessi poliziotti di colore, stavolta era troppo pure per gli antifa. Una menzogna così immensa difficile che reggesse…
Al di là della cronaca e delle sue venature metapolitiche, ci interessa questo pensiero: le proteste dei casseur anarcoidi come eventi di gruppi «attivati» per un fine completamente politico. Al termine della loro azione distruttiva, apparentemente caotica, c’è qualcuno che ne beneficia – una parte politica anche evidente. Nel caso americano, è chiaramente il Partito Democratico USA, che voleva far sloggiare il Trump, e ora si batte per impedire l’ulteriore candidatura nel 2024 del senescente Joe Biden.
E nel caso italiano?
Prima di parlarne, vorremmo andare con la memoria al 2001, a Genova, al G8. Alcuni lettori sono troppo giovani per ricordarlo, o magari non erano ancora nati. Altri si ricorderanno benissimo. Calarono sul capoluogo ligure «anarchici» di ogni sorta, alcuni davvero con tutti i crismi da original brand: ecco la bandiera nera dell’Anarchia, un residuo ottecentesco che si pensava sepolto a causa dell’interferenza poi prodotta dai vessili fascisti parimenti scurissimi.
Invece, eccoti i Black Bloc: non un centimetro di pelle visibile, tuta militare nera, casco nero, maschera antigas nera. Circolavano a Genova facendo perfino marcette con stendardo e tamburo. Produssero una distruzione senza precedenti, «aprendo» (è il loro gergo) quartieri, rendendo intere aree della città delle TAZ, zone temporaneamente autonome, spazi dove non esiste più l’autorità costituta, come da teoria del loro maître à penser, il filosofo filopedofilo Hakim Bey.
Da dove venivano i Black Bloc? Quelli più improvvisati sicuramente vedevano tanti italiani. Quelli un po’ meno magari dalla Francia: il Corriere fece un’intervista ad un «compagno» francese che conosceva bene il ragazzo della foto-simbolo, il ragazzo col passamontagna sull’auto ribaltata: anche qui, organizzazione non precisissima, non si andava molto al di là dello spaccavetrine vagamente riflessivo.
Ho ricordi del fatto che si disse che molte «tute nere» provenissero dalla Germania e alcuni… dall’Oregon. Ecco, l’Oregon riguardo agli anarchici ha tutta una sua tradizione, tanto che la cittadina di Eugene è ritenuta una sorta di piccola capitale dell’anarchismo. Se fosse vero che a Genova fossero arrivati questi anarchici del Pacifico americano, ebbene… chi gli ha pagato il biglietto intercontinentale? Chi ha dato loro gli «strumenti» della guerriglia G8, che certo non hanno imbarcato come bagaglio all’aeroporto?
Possiamo rispondere se capiamo chi ha davvero beneficiato della catastrofe di quel G8. Dopo Genova, qualunque forma di resistenza istituzionale alla globalizzazione è stata spazzata via. Ogni discorso critico nei confronti del piano globale (rammentate: erano i giorni in cui la Cina entrava nel WTO, cioè il momento in cui si decretò la fine della classe media dell’Occidente e la deindustrializzazione della quale stiamo vedendo in questi giorni il colpo di grazia con la follia dei costi energetici) veniva degradato al livello dei no-global in t-shirt, e quindi, non considerato.
Ecco perché nessun Paese è riuscito davvero a resistere al mondialismo slatentizzato – nemmeno chi, come la Francia di Chirac, pareva, per sussulto gollista, forse averne mezza voglia.
Conoscete il procedimento, di sapore tutto hegeliano: metti la tesi, crei l’antitesi, ed eccoti la sintesi – che è quella che si voleva.
Sapete poi che c’è questa teoria che circola, quella della dottrina Rumsfeld-Cebrowski: con il nuovo secolo, il potere profondo statunitense aveva realizzato che per rimanere prima potenza mondiale, Washington doveva garantire a sé e secondariamente agli alleati lo sfruttamento delle risorse naturali dei Paesi poveri. Poche settimane dopo i fatti di Genova, in quel memorabile 2001, vi fu l’attacco alle Torri Gemelle, e di fatto gli USA iniziarono un’immane guerra alla periferia petrolifera del pianeta…
E quindi, i disordini anarchici… manovrati dal Deep State mondialista americano? È una tesi estrema che non possiamo sposare del tutto: noi ci limitiamo a suggerire dei lettori dei puntini, le linee per far emergere il disegno le traccino loro.
Per questo vogliamo rimandare all’articolo del sito più letto degli ultimi giorni, quello sull’altrettanto stramba coincidenza castelvetranese: il luogo in cui il massimo potere USA si raccolse durante la Seconda Guerra coincide con la cittadina dove il massimo latitante della mafia pareva vivere con una certa libertà. A Castelvetrano si trovarono il presidente Roosevelt, il generale Patton, il generale Eisenhower (che divenne, poi, anche lui presidente). Anni dopo, ecco la curiosa libertà con cui Messina Denaro vive lì, con gli abiti firmati, l’auto, la chemio, perfino – disse una fonte di Report anni fa – qualche misteriosa capatina ad un Istituto scientifico del Centro Nazionale delle Ricerche.
Sappiamo che il grande sponsor della mafia italiano può essere l’ente che cagionava la «sovranità limitata» (espressione di impudicizia che un tempo si poteva usare tranquillamente) del nostro Paese: gli Stati Uniti d’America con i suoi tentacoli profondi, quelli che ci scatenarono addosso Lucky Luciano, quelli che forse nutrirono Salvatore Giuliano, quelli che protessero chissà quanti boss, intoccabili perché connessi ai loro capimafia italoamericani, alleati preziosi in tante operazioni indicibili, per esempio la guerra contro Fidel Castro.
E se ci pensiamo, i boss della mafia non è che venivano presi a mazzi, prima di Riina. Magari, questo capomafia così «rurale», aveva esagerato anche per i suoi sponsor. Mica si può andar in giro mettendo bombe contro i giudici e contro i monumenti italiani. Che il padrone abbia, a quel punto, mollato? Non possiamo saperlo, ma abbiamo in mente la notizia riemersa di recente, ossia della «mancata perquisizione del covo di Riina» dopo il raid della mitica Squadra Catturandi.
Che poi, a quanto si può ricostruire, le bombe e tutta la storia intricata della trattativa Stato-mafia (palude sulla quale non ci addentreremo), verteva proprio sul 41 bis: secondo le versioni emerse dai pentiti, era quello il pallino principale della mafia, porre fine ai 41 bis di Martelli.
La cosa, fermatevi a pensarci, dice moltissimo su origine e natura della mafia. Cosa Nostra controlla la Sicilia, nel senso che può disporre della vita e della morte di ogni cittadino, può bombardare il giudice e la sua scorta, può sciogliere il bambino nell’acido, può strangolare una donna incinta, come si dice abbia fatto Messina Denaro. Tuttavia, pur disponendo di questo potere illimitato, la mafia non chiede di sostituirsi allo Stato: domanda solo uno sconto di pena. Tutto qua.
È un paradosso: il mafioso, che è legibus solutus, «sciolto dalle leggi», chiede che sia cambiata… la legge.
La faccenda mi ha sempre sconvolto: ma come, tutto quel potere, la possanza militare, la segretezza, il codice d’onore, il rispetto totale e financo il di tanta popolazione intimorita e non, la potenza di uccidere chiunque e di attaccare qualsiasi istituzione, i miliardi che girano, e poi, quello che chiedi, non è un reset dello Stato, non è la sua sostituzione, non è il riconoscimento statuale definitivo nella comunità globale (cosa verso cui andava spedita, ad esempio, l’ISIS), non è nemmeno la scalata ufficiale all’interno dello Stato (cosa che tentò di fare Pablo Escobar), ma il semplice quieto vivere nell’ombra, con l’esclusione del carcere duro nel caso ti brinchino.
No, io questo 41 bis non lo ho mai capito. È così importante per i picciotti perché forse minaccia la comunicazione nella gerarchia mafiosa? Perché i boss così non possono comunicare con l’esterno? O forse è perché la sua prospettiva spaventa i mafiosi e li trasforma in pentiti, come pare sia accaduto negli USA, dove si dice che vi fosse, sia pur disatteso, un ordine di non trafficare droga, perché portando con sé questo reato 25 anni di galera, una volta beccati si finiva per forza per tradire il mandamento?
Non possiamo sapere neanche questo. Ma abbiamo imparato che questo 41 bis proprio ai mafiosi non piaceva. E quindi ci sale una paura: non è che quei vecchi sponsor della mammasantissima, in questo showdown oncologico terminale, abbiano accordato all’ultimo dei mohicani una fine senza l’articolo penale maledetto?
Se avete seguito questo articolo fantasy – perché di questo si tratta, caro lettore, e lo sai – potete immaginare che lo stesso potere che protegge nelle decadi Castelvetrano è in grado, senza tanta fatica, di far passare una legislazione precisa a Roma. Del resto, ribadiamo, si chiama impudicamente «sovranità limitata».
E quindi, non è che vogliono abolire il 41 bis dipingendolo di questo colore nero-anarchico, invece che delle tinte imbarazzanti dei vespri mafiosi?
Non è che il possibile smontaggio del 41 bis, per il quale ci sarebbe magari un accordo, lo farebbero passare per l’anarchico, anche se la vera base di una decisione è chiaramente un’altra?
Abbiamo raccontato su Renovatio 21 del patto tra mafia e potere occulto americano, magari nella persone della «madre della CIA» James Jesus Angleton. È possibile che una promessa fatta 70 anni fa sia in qualche modo – per onore, per ricatto, per chissà cos’altro – stia ancora in piedi, mostrandoci ora i suoi effetti crepuscolari?
Lo ripetiamo: non è diverso dal patto, sempre riverito con praticamente nessun tentennamento, del Grande Lago Amaro, quando Roosevelt (sempre lui) incontrò nel 1945 il Re Saud e garantì che gli USA avrebbero protetto la famiglia saudita (non la popolazione del Paese: il casato wahabita regnante) in cambio dell’uso del petrodollaro.
Ora, come sa il nostro lettore, anche il patto del Grande Lago Amaro sembra essersi sfilacciato, i sauditi vendono petrolio in yuan ai cinesi, e vogliono entrare nei BRICS.
È il disfacimento del mondo unipolare, quello annunziato da Putin nel suo discorso di Monaco del 2017, e poi ribadito e agito oggi con l’operazione militare speciale in Ucraina.
È il tramonto degli USA, nella cui macchina infernale magari qualcuno ricorda ancora che pacta sunt servanda. E quindi ecco, orde di persone che non c’entrano nulla con la mafia, scagliarsi contro il 41 bis. Eccoti gli anarchici. Eccoti i fricchettoni, con le loro fisime «umanitarie» di buonismo ebete. Eccoti avanzo hippy para-no-greenpassaro. Eccoti, magari, qualche politico che va in apprensione. Eccoti, possibilmente a breve, qualche prete, magari il papa. Tutti pazzi per il 41 bis.
Il motivo potrebbe essere più radicato di quel che credono tutti loro. Ma chiaramente tutto quello che avete letto è pura speculazione fantasiosa, complottista fino alla vergogna, insomma pura fiction, creata con il puro intento di intrattenervi.
No?
Roberto Dal Bosco
Pensiero
«Preghiera» pagana a Zeus ed Apollo recitata durante cerimonia di accensione della torcia olimpica. Quanti sacrifici umani verranno fatti, poi, con l’aborto-doping?
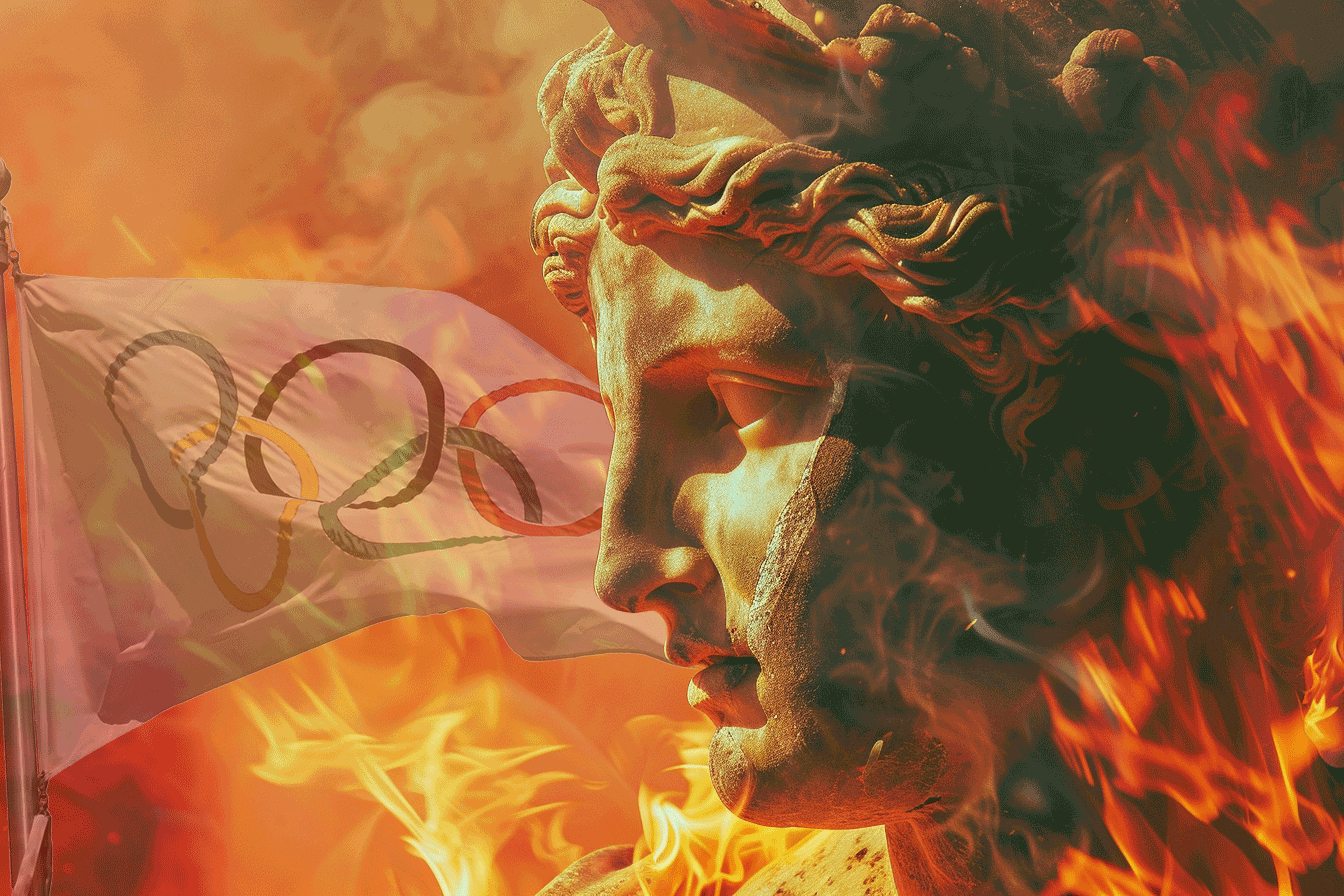
All’inizio di questo mese, il rituale dell’accensione della torcia olimpica – di fatto la prima cerimonia dei Giochi Olimpici – si è tenuta ad Olimpia, in Grecia, presso l’antico tempio di Era, la moglie di Zeus, padre degli dei greci detti, appunto, olimpici. Lo riporta LifeSite.
Accompagnata da uno stuolo di vestali per qualche ragione tutte bianche, l’attrice greca Mary Mina ha interpretato il ruolo di «alta sacerdotessa» che aveva funzione, tra le altre cose, di offrire una «preghiera» agli dèi olimpici.
«Apollo, dio del sole e dell’idea della luce, invia i tuoi raggi e accendi la sacra fiaccola per la città ospite», cioè Parigi. «E tu, Zeus, dona la pace a tutti i popoli della terra e incorona i vincitori della corsa sacra».
🗣️ “Apollo, God of sun, and the idea of light, send your rays and light the sacred torch for the hospitable city of Paris. And you, Zeus, give peace to all peoples on earth and wreath the winners of the Sacred Race.”#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/FHMEmJ134U
— The Olympic Games (@Olympics) April 16, 2024
Sostieni Renovatio 21
Il Comitato Olimpico Ellenico organizza l’evento, che ha una durata di circa 30 minuti, ed elenca sul suo sito il resto dell’«Invocazione ad Apollo».
Silenzio sacro
Risuonino il cielo, la terra, il mare e i venti.
Le montagne tacciono.
I suoni e i cinguettii degli uccelli cessano.
Per Febo, il Re portatore di Luce ci terrà compagnia.
Apollo Dio del sole e dell’idea della luce
manda i tuoi raggi e accendi la sacra fiaccola
per l’ospitale città di…
E tu Zeus dona la pace a tutti i popoli della terra e
incorona i vincitori
della Razza Sacra
Il gruppo spiega che la prima cerimonia di accensione della torcia ebbe luogo nel 1936 con «l’alta sacerdotessa Koula Pratsika, considerata una pioniera della danza classica in Grecia e fu la prima coreografa della cerimonia di accensione». La Pratsika nell’ambito dei celeberrimi Giochi di Berlino – quelli dello Hitler e di Jesse Owens, e di Leni Riefenstahl – e che da allora si è svolta più o meno prima di ogni Olimpiade.
La coreografa Artemis Ignatiou dirige lo spettacolo dal 2008. Originaria della Grecia, ha precedentemente interpretato il ruolo di «alta sacerdotessa» ed è stata coinvolta nella produzione dagli anni Novanta.
È, ammetterà anche il lettore, molto molto curioso: la preghiera ai dei dell’Ellade rispunta per lo Sport, quando invece, l’invocazione che nei secoli si è pronunziata per la medicina – il giuramento di Ippocrate – è oramai quasi del tutto sparito in tutto il mondo – e mica lo vediamo solo in Israele, lo abbiamo visto anche sotto casa durante il COVID. I motivi, li sapete: quelle frasi sul fatto che il medico non darà sostanze abortive, né cagionerà la morte del paziente… Siamo lontani anni luce da ciò che oggi deve fare il dottore, e cioè servire la Necrocultura, estendendo la morte ovunque si possa.
È bene ricordare anche che il mondo moderno ora esige un altro culto pagano greco, quello alla dèa preolimpica (cioè, ctonia) Gaia, che tramite le elucubrazioni dell’ambientalismo è divenuta la Terra stessa, intesa come unico essere vivente minacciato dalla presenza umana. Del resto, Gaia apparteneva alla stirpe dei titani, come Crono, il dio che divorava i suoi figli…
Ma torniamo al fuoco pagano dei Giuochi. Il sito olimpico ricorda che i giochi iniziarono nel 776 a.C. e continuarono fino al 393 d.C. quando l’imperatore cristiano Teodosio I li abolì. «Le sue cerimonie di apertura sembrano quasi sempre incorporare temi massonici o globalisti» scrive LifeSite. «I giochi di quest’anno sono stati annunciati come le prime Olimpiadi “della parità di genere”. Ciò significa che uomini e donne avranno una rappresentanza 50-50 nella competizione. Detto in altro modo, ci saranno tanti atleti maschi quante sono le atlete. Questo è stato presentato come un importante segno di “progresso”».
Alla cerimonia di accensione della torcia, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha sottolineato che i giochi di quest’anno saranno «più giovani, più inclusivi, più urbani, più sostenibili». Si riferiva al fatto che sarà allestita una «Pride House» pro-LGBT per «sostenitori, atleti e alleati LGBTI+».
«I Giochi sono una celebrazione della diversità», afferma il sito ufficiale delle Olimpiadi. «In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, Parigi 2024 ribadisce il suo impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione», riferendosi eufemisticamente a qualsiasi opposizione all’omosessualità o al transgenderismo e aggiungendo che la «Pride House» ha lo scopo di «celebrare» le «minoranze» LGBT e il loro «orgoglio».
LifeSiteNews ci tiene a ricordare che «come i precedenti Giochi Olimpici, Parigi 2024 sarà probabilmente una cloaca di impurità. (…) la fornicazione è dilagante e nel Villaggio Olimpico dove soggiornano gli atleti vengono distribuiti contraccettivi gratuiti».
Riguardo al sesso al villaggio olimpico, chi ha partecipato da atleta ad un’Olimpiade in genere torna con racconti impressionanti – dionisiaci, erotici, del resto sempre di dèi greci si tratta, Dioniso, Eros, e mettiamoci pure dentro pure la poetessa greca Saffo, che dea non è, ma popolare di certo lo deve essere presso certe giocatrici di basket, ad esempio, e neanche solo quelle.
Del resto, metti quantità di giovani sani (in teoria: da Tokyo sappiamo quanti ne ha rovinati, financo sportivamente, l’mRNA) tutti insieme nello stesso luogo, e cosa vuoi che succeda? Sappiamo che la cosa capita anche alla Giornate Mondiale della Gioventù organizzate dai papati moderni, al termine delle quali trovano a terra tra la spazzatura, oltre che le ostie consacrate, anche preservativi usati da giovani e previdenti papaboys.
La questione, semmai, è capire che l’abominio pagano dello sport olimpico potrebbe essere andato molto oltre le semplici fornicazioni degli atleti: da anni si parla sommessamente del fenomeno dell’aborto-doping. Funziona così: per giovarsi della biochimica ormonale fantastica offerta dalla gravidanza e migliorare quindi le proprie prestazioni sportive, le atlete si fanno ingravidare per poi uccidere il figlio e godere del beneficio organico e muscolare della gravidanza.
Praticamente: vero e proprio doping, senza alcuno steroide sintetico – quindi perfettamente legale. Specie, immaginiamo, nelle Olimpiadi delle «pari opportunità».
«Ora che i test antidroga sono di routine, la gravidanza sta diventando il modo preferito per ottenere un vantaggio sulla concorrenza» avvertiva ancora nel 2013 Mona Passiganno, direttrice di un gruppo pro-life texano. In quell’anno emerse anche la storia di un atleta russo che avrebbe raccontato a un giornalista che già negli anni Settanta, alle ginnaste di appena 14 anni veniva ordinato di dormire con i loro allenatori per rimanere incinte e poi abortire. La procedura sarebbe così conosciuta da arrivare persino anche sui libri di testo: un libro di testo online di fisiologia del dipartimento di Fisiologia Medica dell’Università di Copenaghen sembra averne ancora traccia.
«Le atlete di punta – proprio dopo il momento in cui hanno dato alla luce il loro primo figlio – hanno stabilito diversi record mondiali» scrive il testo danese di fisiologia sportiva. «Naturalmente, questo è accettabile come evento naturale e non intenzionale. Tuttavia, in alcuni Paesi le atlete rimangono incinte per 2-3 mesi, al fine di migliorare le loro prestazioni subito dopo l’aborto».
Aiuta Renovatio 21
Altro che preghiera ad Apollo: questo è un sacrificio umano, un atto propiziatorio tramite l’uccisione della propria prole al dio pagano della prestanza fisica, della vittoria sportiva, della ricca sponsorizzazione, dell’ego incoronato etc.
E quindi: quanti sacrifici umani agli dèi antichi e moderni verranno consumati per i Giochi parigini?
Va ricordato l’aborto nel mondo sportivo non è una novità, una importante multinazionale di vestiario, negli anni, è stata accusata di aver fatto pressioni affinché le proprie atlete sponsorizzate abortissero, anche se non è chiaro se semplicemente per continuare a sfruttarne le prestazioni o per ottenerne anche i benefici corporei del doping feticida.
Diciamo pure che la strage olimpica occulta dei bambini delle atlete non potrebbe essere l’unico accento di morte da aspettarsi a Giochi di Parigi. Come noto, Macron ha fatto capire di temere per l’incolumità della sua Olimpiade, arrivando a chiedere, anche grottescamente, una «tregua» dei conflitti in corso – lui che, contro l’opinione degli omologhi europei e dello stesso popolo francese, paventa truppe NATO in Ucraina, e che secondo alcuno già sarebbero state spedite ad Odessa.
Abbiamo visto, nel frattempo, come qualcuno degli organizzatori olimpici si stia lamentando del fatto che per il nuoto la Senna sembra non andare bene: è stata rilevato troppo Escherichia Coli, cioè troppa materia fecale. Parigi è baciata da un fiume escrementizio, e vuole che gli atleti di tutto il globo vi si tuffino.
Questa immagine, del fiume di cacca in cui obbligano la gente ad immergersi, racconta bene il senso occulto dell’Olimpiade.
Tuffatevi anche voi nell’acqua marrone: dietro l’Olimpiade non c’è solo l’afflato neopagano e massonico (con le logge che da sempre rivendicano la consonanza con i principi olimpici), potrebbe esserci un’ondata di morte vera e propria.
Giochi di morte: lo Stato moderno pare volerceli infliggere a tutti i costi.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Pensiero
Foreign Fighter USA dal fronte ucraino trovato armato in Piazza San Pietro. Perché?

Sostieni Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Aiuta Renovatio 21
Sostieni Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Pensiero
La giovenca rossa dell’anticristo è arrivata a Gerusalemme

Ieri si è avuta la notizia, che i grandi media non sono in grado di intercettare.
Gruppi sionisti del Monte del Tempio di Gerusalemme hanno annunciato che il 22 aprile sarà effettuato lo sgozzamento della giovenca rossa, un loro rito messianico per la fine dei tempi.
Secondo quanto riportato, sarebbe stata sottoposta alla polizia israeliana una richiesta ufficiale per permettere di portare nella spianata delle moschee un altare e dei coltelli per macellare mucche dal pelo fulvo.
ALERT 🚨 – The fanatical Zionists from Temple Mount Org have announced that April 22nd is their day to slaughter the much-vaunted #RedHeifer in Jerusalem to realise their version of the End Times messianic prophecy… https://t.co/HLo9nYbGvi pic.twitter.com/JYfs5dHORg
— Patrick Henningsen (@21WIRE) April 12, 2024
Sostieni Renovatio 21
Il rito fa parte del processo della ricostruzione del Tempio ebraico, distrutto nel 70 d.C., la cui ricostruzione porterà all’apparizione del Messia degli Ebrei, che molti cristiani considerano l’anticristo.
Questo, tuttavia, ai vari cristiani evangelici fondamentalisti americani va più che bene, perché in questo modo si accelererà la seconda venuta di Cristo stesso, che arriverà come predetto del Libro della Rivelazione dopo i sette anni di tribolazione – e cioè un conflitto mondiale, la distruzione di tutti gli ebrei che rifiutano di convertirsi, la rapture (idea fondamentalista americana di un subitaneo «rapimento» in cielo di parte della popolazione durante la guerra apocalittica) e alla fine del mondo.
È, in tutto e per tutto, l’Armageddon. E in questo caso è pure chiamare l’apocalisse così, con una parola ebraica.
Gli ebrei ritengono invece che il Tempio ricostruito porterà il loro Messia e, dal Tempio, gli ebrei governeranno cristiani e musulmani. Naturalmente, per fare questo, il luogo più sacro dell’Islam dopo La Mecca e Medina, la Moschea di Al-Aqsa, deve essere raso al suolo.
Armageddonisti ebrei e cristiani da vario tempo stavano collaborando nel trasporto di cinque «giovenche rosse» speciali e «senza macchia» dal ranch del cristiano sionista Byron Stinson in Texas in Israele più di un anno fa, dove hanno acquistato un terreno sul Monte degli Ulivi, il luogo speciale per il macello previsto tra una settimana.
La scelta del mese di aprile si basa sul fatto che le giovenche raggiungono l’età prescritta per la cerimonia. A quel punto, una o più possono essere macellate e poi bruciate, con le loro ceneri mescolate con acqua.
Questo affinché una squadra speciale, che dovrà iniziare la costruzione del Terzo Tempio, possa bagnarsi nella miscela ed essere adeguatamente purificata per il proprio compito.
Stiamo dando una versione semplificata: la realtà è molto più contorta. La chiave è un’interpretazione forzata di un passaggio del Libro dei Numeri dell’Antico Testamento, dove si parla del ruolo di una «giovenca rossa» nel purificare le mani di coloro che hanno toccato i morti.
«Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: “Questa è una disposizione della legge che il Signore ha prescritta: Ordina agli Israeliti che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote Eleazaro, che la condurrà fuori del campo e la farà immolare in sua presenza. Il sacerdote Eleazaro prenderà con il dito il sangue della giovenca e ne farà sette volte l’aspersione davanti alla tenda del convegno; poi si brucerà la giovenca sotto i suoi occhi; se ne brucerà la pelle, la carne e il sangue con gli escrementi. Il sacerdote prenderà legno di cedro, issòpo, colore scarlatto e getterà tutto nel fuoco che consuma la giovenca. Poi il sacerdote laverà le sue vesti e farà un bagno al suo corpo nell’acqua; quindi rientrerà nel campo e il sacerdote rimarrà in stato d’immondezza fino alla sera. Colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti nell’acqua, farà un bagno al suo corpo nell’acqua e sarà immondo fino alla sera. Un uomo mondo raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori del campo in luogo mondo, dove saranno conservate per la comunità degli Israeliti per l’acqua di purificazione: è un rito espiatorio. Colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Questa sarà una legge perenne per gli Israeliti e per lo straniero che soggiornerà presso di loro». (Num 19, 1-10)
Questa purificazione sarebbe fondamentale per il sacerdozio ebraico e il culto sacrificale. Il Jerusalem Post scrive: «ai giorni nostri, si presume che tutti gli ebrei, inclusi i kohanim [sacerdoti o discendenti dei sacerdoti, ndr], siano impuri a causa dell’impurità impartita da un cadavere. Mentre nella vita quotidiana dei giorni nostri questo status non ha molto effetto pratico, a chi è impuro con questo tipo di impurità è vietato entrare nel Tempio».
È la questione del kosher: l’ebraismo è ossessionato dalla contaminazione, da cui, secondo cui la tendenza a separare – il giudeo dal gentile, il latte della carne bovina, la donna mestruata dal resto della comunità.
Un’altra pubblicazione dello Stato Ebraico, Israel365News, spiega quindi che «la mancanza di una giovenca rossa ha lasciato tutto Israele ritualmente impuro e incapace di eseguire adeguatamente molti altri comandamenti».
Questo è un problema, perché la cerimonia deve essere completata da un sacerdote che sia lui stesso ritualmente puro. Rabbi Azaria Ariel, il direttore della ricerca del Temple Institute, spiega che il sacerdote «deve essere puro per eseguire il rituale e preparare le ceneri. Ad esempio, non può nascere in un ospedale. Abbiamo alcuni sacerdoti così».
«Cerchiamo sacerdoti che siano stati attenti a questa questione di significato, allontanandosi dai cadaveri dei cimiteri e degli ospedali. Devono avere una chiara tradizione familiare che discenda dai preti. In realtà di uomini così ce ne sono molti, moltissimi. Deve anche avere un’età in cui può macellare la mucca di almeno 15 anni e non è stato in ospedale fino a quel momento».
(Sugli ospedali come luoghi di morte, ci troviamo bizzarramente d’accordo col rabbino, ma questo è un altro discorso).
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Tuttavia, il rabbino Ariel ha anche affermato che, nel frattempo, è ancora possibile entrare nel Monte del Tempio e persino offrire alcuni sacrifici in uno stato di impurità rituale. Al contempo, il rabbino Ariele precisa che questa cerimonia «non attiva l’obbligo di costruire il Terzo Tempio» e «la costruzione del tempio non dipende dalle Giovenche Rosse».
«Noi non facciamo il rituale della giovenca rossa affinché il Messia venga affinché Dio faccia qualcosa del genere o qualcosa del genere» ha assicurato il rabbino.
Il rito di purificazione potrebbe seguire altre logiche di giudaizzazione pure della vita civile – e militare – dello Stato Ebraico.
Kassy Akiva, una videogionalista ebrea del Daily Wire, la grande organizzazione di informazione del sionista Ben Shapiro, del Daily Wire ha raccontato su Twitter che «le ceneri vengono utilizzate per creare una miscela che viene utilizzata nel processo di purificazione per accedere al cortile interno del Monte del Tempio. Gli usi pratici oggi consentirebbero agli agenti di polizia di purificarsi prima di entrare in quell’area per motivi di sicurezza invece di essere costretti ad entrare in quell’area per garantire la sicurezza senza prima purificarsi. Sebbene ciò sia consentito dalla lettera della legge ebraica, tutti concordano sul fatto che sarebbe meglio purificarsi prima di entrare».
Also to be precise: the red heifer isn't technically a sacrifice. It is slaughtered and burned on the Mt. of Olives but not on an altar. The ashes are used to make a mixture that is used in the purification process for entering the inner courtyard of the Temple Mount. Practical…
— Kassy Akiva (@KassyDillon) April 4, 2024
Aiuta Renovatio 21
In pratica, si potrebbe trattare di estendere la religione sulla società ebraica anche più secolare. Con il presente governo israeliano, il più religioso, il più messianico della storia, non poteva che essere così. È il governo dove si giustificano gli sputi ai cristiani a Gerusalemme («tradizioni», rivendica il ministro: certo), è il governo dei convegni con balli scatenati dei coloni pronti a scendere su Gaza, è il governo che non ha problemi a parlare di nuclearizzazione dei palestinesi – e degli iraniani – dopo aver usato una parola biblica, amalek, che riporta alla possibilità di annientamento di interi popoli. Genocidio: ma con radici religiose. (Dov’è che avevamo già sentito questa storia?)
In realtà, «cinque giovenche perfettamente rosse» – mucche che non hanno ancora partorito, mucche «vergini» – erano arrivate in Israele già nel settembre 2022.
All’epoca reagirono subito gli organi di stampa di Hamas a rispondere, definendolo un tentativo di «giudaizzare le sante moschee» e sostenendo che «Al-Aqsa è in pericolo».
Le giovenche sono state portate da Boneh Israel («Costruire Israele»), un’organizzazione israelo-americana composta da ebrei e cristiani. Le giovenche sono state trovate e allevate da Byron Stinson, sedicente «giudeo-cristiano» e consigliere dell’organizzazione. Un video sul sito web di Boneh Israel lo definisce «letteralmente il ragazzo che ha portato quelle giovenche rosse in Israele».
«Queste giovenche rosse possono portare la pace nel mondo! La Bibbia ci insegna che la chiave per costruire il Terzo Tempio (la Casa di Preghiera per Tutte le Nazioni) è purificarci con la giovenca rossa a Gerusalemme» scrive il sito.
Lo Stinson, come nota LifeSite, ha anche chiarito che ritiene che la cerimonia della giovenca sia un primo e necessario passo per ricostruire il Tempio, e la collega persino all’emergere di un governo mondiale:
«I rabbini sono così emozionati perché, come noi sparsi nelle Nazioni, tutti possono sentire l’avvicinarsi di un governo unico mondiale. Puoi sentire l’avvicinarsi di questo momento in cui qualcosa deve cambiare. E tutti lo sentono e ciò che cercano disperatamente è la venuta del Messia. Sanno che questo è il primo passo per poter costruire il tempio. Non puoi purificare le persone che lavoreranno nel tempio finché non avrai effettivamente quest’acqua di purificazione che proviene dalla cenere delle giovenche rosse».
«Credo che la risposta di ogni cristiano dovrebbe essere quella di sostenere la costruzione del Tempio»
Il Jerusalem Post ha anche affermato che a settembre le giovenche sono state accolte cerimonialmente all’aeroporto israeliano Ben-Gurion da diversi rabbini del Temple Institute, tra cui lo stesso rabbino Azaria Ariel e il direttore generale del ministero del Patrimonio e di Gerusalemme, Netanel Isaac.
Il Temple Institute è stato fondato dal padre di Ariel (Rabbi Yisrael Ariel) e Rabbi Azaria Ariel guida il suo dipartimento di ricerca. Il sito web dell’Istituto afferma che mentre alcune cerimonie del Tempio sono possibili in uno stato di impurità rituale, la giovenca rossa è necessaria per il completo ripristino messianico.
«Il completo rinnovamento di tutti gli aspetti del servizio del Sacro Tempio e il risveglio della completa purezza rituale tra gli ebrei dipendono dalla preparazione della giovenca rossa (…) La preparazione della giovenca rossa è una precondizione per la reintegrazione del servizio completo nel Sacro Tempio».
Il sito riporta inoltre favorevolmente l’insegnamento su questo argomento del rabbino Moshe ben Maimon – conosciuto come Mosè Maimonide (1135-1204) o «Rambam» – filosofo talmudista tra i maggiori nella storia dell’ebraismo, estremamente influente nel XII secolo. Egli collegò l’arrivo della successiva giovenca rossa con la venuta del Messia, cioè quello che gli ebrei chiamano il «mashiach» o «moshiach».
«Nove giovenche rosse furono offerte dal momento in cui fu loro comandato di adempiere a questa mitzvah [il compimento di uno dei comandamenti della legge ebraica, ndr] fino al momento in cui il Tempio fu distrutto una seconda volta. La prima è stata portata da Mosè, il nostro maestro. La seconda è stata portato da Esdra. Altre sette furono offerte fino alla distruzione del Secondo Tempio. E la decima sarà portata dal re mashiach; possa essere rapidamente rivelato. Amen, così possa essere la volontà di Dio» (Maimonide, Shefter Shoftim («Il Libro dei Giudici», capitolo 11).
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Secondo Maimonide, un’impresa fondamentale di questo presunto Messia, che costituirà peraltro una delle prove conclusive della sua affermazione, è che costui ricostruirà il Tempio di Gerusalemme.
È facile capire che se qualcuno vi dice che non esiste alcun legame tra la consegna delle giovenche rosse e la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme – e quindi la venuta del presunto messia degli ebrei – vi sta gettando fumo negli occhi, vi sta ingannando – gaslighting, dicono ora in America. Operano per l’apocalisse, ma fischiettosamente. I complottisti siete voi, che maliziosamente vedete troppe cose dietro un innocente, zufolante sacrificio veterotestamentario di mucche rosse sul Monte degli Ulivi. Avete visto troppe volte il primo Indiana Jones, con il rito ebraico che scatena quel massacro massivo orripilante. Eccerto.
Prima di parlare del significato che tutto questo ha per i cristiani, soffermiamoci a ricordare cosa significa il Terzo Tempio per i musulmani. La moschea di Al-Aqsa, si trova proprio lì. Lo sappiamo bene perché in questi anni abbiamo visto la quantità di botte che in tante occasioni le forze israeliane hanno rifiutato ai musulmani lì per – in teoria – pregare, cosa che peraltro è consentita solo a loro.
Qualcuno ricorderà anche la passeggiata che sulla spianata delle moschee compì l’allora premier israeliano Ariel Sharon nel 2000, l’atto da cui partì la seconda Intifada. Ricordiamo brevemente cosa accadde in seguito: Sharon divenne relativamente più «morbido» verso i palestinesi, formò un partito suo scindendo il Likud. Nel 2005 – esattamente come era successo anni prima a Ytzhak Rabin– finì al centro di una Pulsa DiNura, una cerimonia di maledizione cabalistica performata da una quantità di rabbini, pure ripresa da una TV locale. Se mesi dopo a Sharon venne un colpo, e restò anni in coma fino al 2014. Se vi impressionate, ripetiamo, è perché avete negli occhi I predatori dell’arca perduta.
Sostieni Renovatio 21
Si tratta di un luogo definito come terzo più sacro di tutto l’Islam. I musulmani ritengono che Maometto fu portato sul luogo del Tempio in rovina di Gerusalemme su un cavallo magico; e che legò il suo cavallo al Muro Occidentale e da lì salì al cielo e incontrò i vari profeti. Non si tratta solo di palestinesi: tutto l’Islam potrebbe reagire qualora Al-Aqsa fosse toccata.
Del resto, cerchiamo di comprendere: Israele, oltre che uno Stato etnonazionalista, può definirsi uno Stato religioso. Hamas, il nemico dello Stato Ebraico, è pure un’organizzazione religiosa – in particolare, una gemmazione locale del gruppo protofondamentalista dei Fratelli Musulmani. L’Iran – che poche ore fa ha attaccato frontalmente Israele con i suoi droni – è una Repubblica Teocratica, uno Stato fondato, rifondato su principi religiosi.
Insomma, al di là di quello che possono dirvi gli alfieri della «geopolitica laica» (quelli che vi raccontano di interessi economici, petrolio, voti dei pensionati ebrei in Florida) si tratta di una questione di religione: tutti gli attori in gioco sono enti religiosi.
In ballo c’è una guerra di religione: e quindi, come non vedere il peso assoluto della macellazione rituale della giovenca rossa?
In realtà, pochi in Italia ne stanno parlando. Non si sono addentrati i blog più complottisti, e neanche i canali Telegram pronti a rilanciare qualsiasi bufala dopaminica («re carlo è morto», «Putin si è schierato con l’Iran) per ciucciare un po’ della vostra attenzione.
Eppure, la questione religiosa dovrebbe interessare anche noi. Perché, anche se rimossi dall’equazione, siamo anche noi spinti nella catastrofe di Gerusalemme – in quanto cristiani, non potrebbe che essere così.
Si torna alla vecchia questione sottolineata più volte da Renovatio 21: c’è lo Stato Ebraico, c’è lo Stato Islamico (ce ne sono diversi), tuttavia non c’è, e non può esserci, lo Stato Cristiano – è rimosso dal discorso, non può essere nemmeno nominato. Il dogma, ad ogni latitudine occidentale e non solo, è quello dello Stato «laico», che sappiamo bene significa uno Stato retto su principi massonici – cioè su una religione ulteriore che tenta da secoli di cancellare il cristianesimo.
È stato riportato che a spingere il progetto di ricostruzione del Tempio di Salome vi sarebbe una loggia massonica britannica, la Quator Coronati. Tuttavia non è questo che vogliamo sottolineare: vogliamo dire come, ancora una volta, i cristiani pare non siano nemmeno considerati nell’equazione. Sono stati estromessi, eliminati dal discorso.
È una realtà portata a galla dal solito Tucker Carlson, che in settimana ha intervistato un pastore evangelico palestinese, mettendo in risalto il paradosso assoluto per cui – come in Iraq, come in Siria – i danari mandati dagli USA in Medio Oriente, su pressioni di lobby protestanti, finiscano per uccidere i cristiani stessi.
Questo è uno degli effetti, solo apparentemente paradossali, del messianismo sionista installato nel fondamentalismo cristiano americano: pur accelerare la fine dei tempi, aiutano la persecuzione, passano sopra il cadavere dei cristiani del Medio Oriente, finanziando ed armando Israele, che nel frattempo avanza leggi anti-conversione per proibire il proselitismo cristiano, negli ultimi mesi ha fatto registrare attacchi ai cristiani senza precedenti.
Non si tratta di frange: come riportato da Renovatio 21, anche lo speaker della Camera USA, il sempre più controverso Mike Johnson, è del gruppo, con vari legami con gruppi del sionismo messianico.
Aiuta Renovatio 21
I cattolici non stanno prendendo la cosa sul serio, anche nella storia teologi e padri della Chiesa – vengono citati San Girolamo, Sant’Ambrogio, San Gregorio Magno, San Efraim, San Giovanni Crisostomo, Sant’Ireneo di Lione – hanno stabilito che l’anticristo potrebbe essere una figura simile.
Il gesuita Francisco Suárez (1548-1617), nella sua opera De Antichristo, scrive che «c’è uno che gli ebrei aspettano e uno che tutti accoglieranno. Gli altri che pretendevano di essere il Messia non sono stati ricevuti da tutti gli ebrei, ma solo da alcuni».
L’anticristo, dice la scrittura, ingannerà il mondo intero, convincerà persino gli eletti. Per questo si ritiene che guiderà un Nuovo Ordine Mondiale, dove la fede sarà perseguitata, e l’umanità vivrà i suoi tempi ultimi.
Questo è il pensiero cristiano, al quale nessuno sembra voler far caso.
Se poi vi chiedete perché, ricordatevi di San Pio X, e di Bergoglio. Nel 1903 papa Sarto, come abbiamo ricordato più volte, ricevette il fondatore del sionismo Theodor Herzl, e gli negò qualsiasi aiuto.
«Noi non possiamo favorire questo movimento. Non potremo impedire agli ebrei di andare a Gerusalemme, ma non possiamo mai favorirlo. La terra di Gerusalemme se non era sempre santa, è stata santificata per la vita di Jesu Cristo (…) Io come capo della chiesa non posso dirle altra cosa. Gli Ebrei non hanno riconosciuto nostro Signore, perciò non possiamo riconoscere il popolo ebreo» scrive Herzl nei suoi diari.
Facciamo un salto temporale: 110 anni dopo, vediamo le immagini, girate durante il suo viaggio in Terra Santa, di papa Bergoglio, accompagnato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu (quello oggi definito «macellaio» e «genocida») mentre si reca a rendere omaggio alla tomba di Herzl. Nemmeno un rabbino: un «laico» etnonazionalista ebreo che, peraltro, si era rifiutato di baciare la mano del santo papa predecessore ed inginocchiarsi, come da protocollo vaticano.
Il mondo è rovesciato. Il mondo è stato rovesciato. Sì.
La chiesa post-conciliare quindi lavora per il sacrificio della giovenca rossa?
La Roma infiltrata dal Male vuole la manifestazione dell’anticristo, per poterlo adorare ed intronare?
Domande che vale la pena di farsi, nelle ore in cui lo spettro di una guerra atomica si fa sempre più concreto – ecco il vero sacrificio a cui mira il Male, ecco il vero Olocausto.
La cancellazione dell’umanità, l’annientamento dell’Imago Dei: stiamo parlando, davvero, di questo.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Pensiero2 settimane fa
Pensiero2 settimane faLa giovenca rossa dell’anticristo è arrivata a Gerusalemme
-



 Cervello1 settimana fa
Cervello1 settimana fa«La proteina spike è un’arma biologica contro il cervello». Il COVID come guerra alla mente umana, riprogrammata in «modalità zombie»
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori della 15ª settimana 2024
-



 Salute6 giorni fa
Salute6 giorni faI malori della 16ª settimana 2024
-



 Pensiero1 settimana fa
Pensiero1 settimana faForeign Fighter USA dal fronte ucraino trovato armato in Piazza San Pietro. Perché?
-



 Animali2 settimane fa
Animali2 settimane fa«Cicala-geddon»: in arrivo trilioni di cicale zombie ipersessuali e forse «trans» infettate da funghi-malattie veneree
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane faSinodo 2024, grandi manovre in favore dell’ordinazione delle donne
-



 Vaccini2 settimane fa
Vaccini2 settimane faVaccino mRNA sviluppato in 100 giorni, professore di medicina avverte: «possibile solo ignorando i diritti umani»