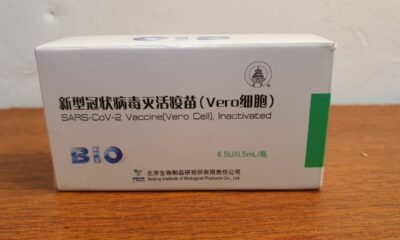Arte
William Friedkin, le crudeltà omosessuali e la paura che i vescovi hanno di Satana

È morto William Friedkin, regista che sarà rammentato dai posteri per L’esorcista (1973). Noi, tuttavia, non vogliamo ricordarlo per quello – o meglio, non solo per quello.
Chiariamoci: L’esorcista è un capolavoro, o forse perfino qualcosa di più: un’opera che è riuscita a captare e risvegliare nella società significati indicibili, altissimi, e che è riuscita a parlare alle generazioni. Mi viene in mente che ne vidi una versione restaurata forse nel tardo 1999 al cinema Excelsior – un’enorme sala a più piani che stava in un antico palazzo nobiliare in Galleria del Corso a Milano, ora sostituita da un centro commerciale che vende macarons, profumini e vestiario per fashion victim e turisti.
Il cinema era strapieno, e, paradosso, il film davvero terrificante: vederlo proiettato su grande schermo dava una sensazione totalmente differente rispetto al vederlo in VHS (all’epoca c’erano quelle: le videocassette con i nastri magnetici). Non so dire se facesse più paura o meno, ma la condivisione collettiva della visione portava l’esperienza da un’altra parte: era un rito, forse un vero esorcismo, fatto alla pluralità degli esseri umani, alla società, in qualche modo unita ancora dalla paura del preternaturale e dalla promessa della sua liberazione.
I subliminali con il volto del dominio, le apparizioni dell’effigie del demone Pazuzu, perfino il ralenti dei cani che combattono nel deserto iracheno, assumevano quella sera con la sala piena un significato ulteriore…
Con me c’era Michela, che de L’esorcista era una patita sfegatata, tanto che rivendicava il fatto di aver visto il film appena uscito in sala… dal ventre di sua madre (credo che mi abbia detto davvero una cosa così: è nata quell’anno). Il culto totale di Michela per il film mi lasciava in prima battuta perplesso: cattolica non lo era (no, e non lo ero neanche io), non so fino a che punto credesse alle storie di possessione, forse era una fan dell’horror, ma limitatamente. Per il capolavoro di Friedkin, andava fuori di testa: sapeva, e ripeteva le battute del demonio e degli esorcisti a memoria, come quella sulle attività della madre di Padre Carras all’inferno (che qui non ripeterò) o l’espressione «volgare esibizione di potenza» (in originale, «vulgar display of power»), che divenne il titolo di un fortunato album di una band metal americana, i Pantera – forse non portò tutta quella fortuna, però, visto che una sera un tizio salì sul palco armato e sparò loro uccidendo il chitarrista.
No, subito non capivo perché gli piacesse così tanto il film. Ne parlava in continuazione, chiamandolo famigliarmente L’esorciccio, come la parodia con Ciccio Ingrassia e Lino Banfi (che, a leggere la trama, tra bambini stupratori e talismani sotterrati nei campi – ricorda qualcosa al lettore di Renovatio 21? – può fare anche più paura dell’originale).
Poi, piano piano, compresi che quello che la catturava era qualcosa di spirituale ed estetico al contempo: era la perfezione che quella pellicola indubbiamente aveva nel raccontare il mistero, nel mostrare un abisso che sta accanto a noi, un livello ulteriore dell’esistenza dipinto in modo impareggiabile.
Io non posso che condividere. E come me, ci sono milioni di persone, di tutte le classi socioeconomiche e socioculturali e sociopolitiche, che vi hanno visto dentro un significato profondissimo, e tutto personale.
Un regista para-sessuale ora celeberrimo a livello internazionale (noto perché i suoi film, per usare le sue parole e la sua zeppola «fzpingono zul pedaleh della fprofvocaziòneh»), mi disse, oramai un quarto di secolo fa, che il suono del demonio era ottenuto girando al contrario l’audio dello sgozzamento di un maiale. Non so verificare se ciò sia vero, tuttavia il tono indicava non solo quanto voleva esibire le sue conoscenze cinefile («volgare esibizione di potenza», appunto), ma anche quanto, alla fine, prendesse sul serio il film, ne riconoscesse la portata misterica.
«L’esorcista è un film realista» mi disse un decennio dopo un ragazzo cattolico carismatico – nel senso cattolico di stile pentecostale, zona Medjugorje. Mentre meditavo sul concetto di un neorealismo cinematografico soprannaturale, lui raddoppiava: «anzi no, è un film che dei posseduti dà un’immagine anche troppo contenuta».
Sulla questione dell’Esorcista e delle vere possessioni diaboliche torneremo più sotto. Prima vorremo far presente qualcosa che probabilmente nessun’altra testata ricorderà nei coccodrilli su Friedkin: la sua disamina, lucida e compiuta anzitempo, del lato interiore del mondo omosessuale.
Prima del grande successo, il regista di Chicago aveva girato un piccolo film d’interni, un kammerspiel in terrazza, se si può dire, chiamato Festa per il compleanno del caro amico Harold (1970), tratto da una commedia teatrale del drammaturgo gay Mart Crowley.
Il film racconta della festa che Michael, un gay, organizza per celebrare il compleanno del suo amico Harold. L’evento ospita vari membri dell’alta società intellettuale omosessuale di New York. Inaspettatamente, tuttavia, alla festa si presenta Alan, un suo vecchio compagno di università e unico partecipante eterosessuale alla festa.
La presenza di Alan provoca un cambiamento nell’atmosfera della festa, trasformandola in una sorta di sessione di analisi collettiva. Questo fa emergere sentimenti tossici e risentimenti tra i presenti, portando il gruppo a un drammatico e distruttivo gioco di rivelazioni reciproche. Alla fine del processo, ognuno scopre di essere più solo di quanto pensasse – definitivamente non gaio.
Non sappiamo se la mitica scena dello «schiantatope» nel film dei fratelli Vanzina Vacanze in America (1984) sia ispirata all’opera di Friedkin – una scena che lo stesso attore scaligero Jerry Calà ora ritiene sarebbe impossibile da girare, in quanto potenzialmente da ritenere omofoba.
Tuttavia sappiamo, per testimonianze, che il gioco delle crudeltà all’interno di un festino gay non sia qualcosa di lontano dalla realtà. Si tratta, anzi, di qualcosa comunemente accettato sotto l’etichetta dell’«acidità» di questo o di quel personaggio, di cui Friedkin nel film dà varie declinazioni: nella festicciola del film, come in quelle della realtà, c’è il gay cattolico, il gay effeminato, il gay arredatore di interni, la coppia gay con qualche difficoltà a mantenere la monogamia.
Bisogna riconoscere che a 53 anni dall’uscita della pellicola e a centinaia se non migliaia di film omosessuali usciti (scritti, diretti, prodotti, consumati da omosessuali) questo tema praticamente è stato toccato – et pour cause, visto che il senso di sconforto che comunica tende a negare la parola stessa gay.
Il film all’epoca non fu ricevuto male dalla critica, ma è accusato ancora oggi dalla comunità LGBT di ritrarre l’omosessualità con tinte pessimistiche inaccettabili.
In pratica, vedere oggi Festa per il compleanno del caro amico Harold, dopo milioni di ore di omopropaganda da Philadelphia ad ogni singola serie Netflix, potrebbe essere perfino un’esperienza liberatrice, un atto rivoluzionario. Del tipo: «ma tu lo sapevi che anche i gay sono tristi?».
Per qualche motivo, Friedkin (che ricordiamo ebbe in moglie, ad un certo punto, Jeanne Moreau) tornò a fare film controversi sui gay – pure utilizzando uno dei più grandi artisti della storia della celluloide, Alfredo James Pacino detto Al.
Cruising (1980), venne dopo l’immenso successo de L’esorcista, e quindi si può considerare un film che il cineasta davvero avesse in cuore di fare. Il film parla degli sforzi di un poliziotto, interpretato da Pacino, per infiltrarsi nel mondo dei gay nuovaiorchesi, dove stava operando uno spietato serial killer. La pellicola ha alla base un romanzo omonimo scritto da Gerald Walker, un giornalista del New York Times, che riprendeva a sua volta un insieme di articoli su una serie di omicidi irrisolti nella scena gay della Grande Mela – in pratica, siamo dalle parti di «ispirato ad una storia vera».
La parola cruising ha un doppio senso: in inglese indica sua la pattuglia compiuta dai poliziotti, che l’atto tipico del mondo omosessuale di circolare per una località in cerca di un partner sessuale casuale magari del tutto anonimo.
Nella pellicola c’è abbondanza di scene con uomini che ballano con costumi di cuoio, e Pacino che fa le mossette, anche se interiormente è divorato dall’ossessione di trovare l’assassino seriale e, lo capiamo grazie alla grandissima arte dall’attore neoeboraceno, dalla paura che gli incutono quei territori ignoti.
Quando uscì il film nel 1980 la società era molto cambiata rispetto al 1970 del Compleanno dell’amico Harold: gruppi dei «diritti gay» reagirono con proteste che erano iniziate perfino durante le riprese nel 1979. I gay furono esortati a interrompere le riprese e le aziende di proprietà di persone gay avrebbero dovuto impedire ai lavoratori del film di accedere ai loro locali.
Manifestanti omosessuali tentarono di interferire con le riprese puntando gli specchi dai tetti per rovinare l’illuminazione delle scene, fischietti e trombe d’aria vicino ai luoghi e suonando musica ad alto volume. Un migliaio di manifestanti marciò attraverso l’East Village chiedendo alla città di ritirare il sostegno al film (bei tempi: oggi, abbiamo visto, marciano dicendo «stiamo venendo a prendere i vostri figli»).
A causa delle continue proteste, l’audio del film fu in gran parte sovrainciso e ridoppiato per rimuovere il rumore causato dai manifestanti fuori campo.
Tuttavia, anche qui, pare chiaro che Friedkin stava toccando un nervo scoperto, un altro tema che oggi potrebbe suonare completamente tabù: il mondo gay può essere spaventoso e oscuro – del resto, è quello delle dark room, e se non sapete cosa siano non inquineremo la vostra mente spiegandovelo.
Chi ha visto il film non può evitare di pensarci quando, magare lungo gli argini dei fiumi o in altri luoghi di potenziale cruising, vengono trovati omosessuali morti.
Friedkin passò dalle cattiverie tra amici omosessuali del Compleanno dell’amico Harold al racconto di atrocità tetre e insondabili, di violenze maligne che vediamo in Cruising. Il pensiero di quel film potrebbe essere riaffiorato quando in Italia scoppiò l’agghiacciante caso di Luca Varani, il ragazzo ventenne torturato e ucciso da due personaggi delle notti gay romane, in quello che il procuratore generale della Cassazione descrisse poi come «un abisso umano» (la vicenda non poteva che ricordare anche il film di Hitchcock Nodo alla gola, a sua volta ispirato ad una storia vera con un omicidio di un 14enne consumatosi nel 1924, che coinvolgeva due ragazzi sulla cui omosessualità si è discusso).
A questo punto diventa chiaro che sì, l’epiteto «regista del Male», per Friedkin può starci. Tuttavia, per capire meglio dobbiamo tornare all’esorcista, o meglio al documentario che ne fu conseguenza 40 anni dopo.
Di fatto, c’è da ritenere che Friedkin, di origine ebraica, non sapesse moltissimo della possessione diabolica. Era guidato, più che altro, da William Peter Blatty, lo scrittore allevato dai gesuiti a Georgetown (realtà dipinta lucidamente nel film) che per scrivere il romanzo da cui trassero la pellicola si era con probabilità a lungo consultato con dei veri esorcisti, per poi riadattare anche qui una storia vera, l’esorcismo di un ragazzino avvenuto, a quanto pare, nel 1949 nella vicina Cottage County, un Maryland.
È difficile, credo, che il regista si stesse rendendo conto anche dell’importanza di piazzare nella storia una accenno di attacco alla tavoletta Ouija, della cui strana storia e dei cui pericoli Renovatio 21 ha scritto varie volte.
Tutte le storie per cui Friedkin sarebbe un iniziato che avrebbe messo nel film roba occulta – come suggeriscono certi blog complottari USA o il regista internazionale con la zeppola di cui sopra – sono in realtà fandonie, proiezioni dovute alla perfezione religiosa del film.
Ho trovato conferma di questo pensiero nell’ultimo documentario di Friedkin, tecnicamente il suo penultimo film (l’ultimo, The Caine Mutiny Court-Martial, sarà proiettato postumo al Festival di Venezia tra qualche giorno). Sto parlando di The Devil and Father Amorth.
A metà anni 2010, Friedkin decise che, pur essendo riconosciuto come un’autorità in fatto di esorcismo a causa del film che aveva diretto, era venuto il momento di vederne uno davvero. Così contattò il decano dell’esorcistato mondiale, l’indimenticato padre Gabriele Amorth (1925-2016), fondatore dell’Associazione internazionale degli esorcisti (AIE), che aveva forse qualcosa come 160.000 esorcismi alle spalle.
Padre Amorth è ben conosciuto in Italia: ospitate nei talk show, interviste, e poi la presenza su Radio Maria, dove la sua trasmissione con telefonate dal pubblico era spesso spiazzante: «prontooooh?» diceva lui, mentre dall’altra parte spesso vi era una voce che si esprimeva con ogni accento regionale italiano possibile, spesso per chiedere preghiere per un parente posseduto, che era talvolta possibile sentire rantolare in sottofondo, come avveniva in altre registrazioni audio di incontri di Amorth che l’emittente mariana mandava in onda.
Amorth era ritenuto come forse il più potente, esperto esorcista del mondo, tuttavia ammetteva che professionalmente era «un bambino» nei confronti del controverso vescovo zambiano Emmanuel Milingo (lo scrivente lo vide in azione, e conferma l’altissimo livello di quello che possiamo definire «talento esorcistico» del monsignore di Lusaka, con scene di possessione che, sulle prime, ad un corpo maschile anche giovane provocano reazioni somatiche non dissimili a quelle di quando ci si immerge nell’acqua fredda).
Friedkin ottenne quindi da Amorth, che era assai generoso mediaticamente, di seguirlo durante il nono esorcismo di una signora di Alatri, conosciuta come «Cristina».
Il film fu presentato all’edizione 2017 della Mostra del Cinema di Venezia. La critica lo demolì come «amatoriale». È vero. Girato con camerelle digitali tenute a braccio, forsanche dallo stesso Friedkin, l’opera è lontana anni luce dall’arte altissima de L’esorcista. Come se, incontrato un esorcista vero, Friedkin avesse perso lo stile, e fosse regredito a una sorta di forma di espressione audiovisiva infantile: il regista, truccato e col capello tinto e pettinato, si fa inquadrare per spiegare la storia, artifizio da ritenersi impossibile per un cineasta di quel livello, mentre la narrazione diventa sempre più ondivaga, mentre mostra esorcismi in grandangolo, dove padre Amorth mostra la stessa indifferenza verso i versi del maligno di cui dicevamo più sopra parlando delle trasmissioni di Radio Maria. Ab assuetis, non fit passio, mi viene da pensare: quando uno è abituato alle manifestazioni del demonio, non è che si spaventa più.
Nel punto che dovrebbe essere il climax della storia, Friedkin confessa di non avere immagini dell’accaduto: una ragazza degli esorcismi dà appuntamento a lui e a un suo assistente in un assolato Paesino dell’entroterra laziale, per poi, a quanto racconta il regista, divenire isterica, e cercare assieme al fidanzato di ricattare gli americani. Tale evento lo sconvolge al punto che ne parla come fosse un degno corollario del viaggio nel preternaturale compiuto una volta entrato in contatto con padre Amorth.
Il quale padre Amorth si vede alla fine del film mentre, entrando con un deambulatore in un ascensore, guarda l’obiettivo e fa marameo. Friedkin, fuori campo, dice che è una delle persone più incredibili mai incontrate. La sensazione di ingenuità, di dilettantismo, di infantilismo assale lo spettatore cattolico che magari oltre a L’esorcista ha visto anche qualche esorcismo vero.
Ad ogni modo, è un’altra scena del documentario che lascia il segno.
È l’intervista all’arcivescovo di Los Angeles Robert Barron, che è un ragazzotto con i pantaloni e il clergyman che lì per lì irradia un’espressione di genuina serenità. Monsignor Barron, parlando in quello che sembra un ambiente del giardino della diocesi con Friedkin, ammette che sì, ci sono cose che non possiamo capire, «c’è una dimensione di questo mondo che è strana e fuori dalla nostra capacità di controllo» e blah blah…
Poi, ad un certo punto, pressato da Friedkin che gli parla di Satana e delle possessioni, l’arcivescovo fa ammissioni sorprendenti.
«Parlando con il diavolo… hey… persone come padre Amorth possono farlo, io non potrei mai osare di farlo, non sono a quel livello spirituale… io penso che sia davvero una cosa pericolosa».
Eh?
Un arcivescovo, un discendente degli apostoli, un seguace diretto, quindi, del sommo esorcista, un alto gerarca di quei cristiani che arrivati a Roma scacciavano i demoni pagando poi la propria fede con il martirio… non si sente di fare quel lavoro?
Sì, abbiamo capito bene. È e lo stesso Friedkin che a quel punto della conversazione lo interrompe, pure puntandogli il dito: «che cosa hai detto?»
«Io non lo farei» risponde l’arcivescovo.
«Cosa non faresti?» chiede ancora Friedkin colpito.
«Parlare con il diavolo» precisa il monsignore.
«Come in un esorcismo?»
«Io penso che non sarei in grado… penso che non vorrei farlo.»
«Perché no?»
«Penso che sia un territorio pericoloso… devi essere davvero, davvero santo». Qui l’arcivescovo usa la parola «holy», che confonde un po’, perché si può tradurre più che altro con «sacro». Ora il prelato ha lo sguardo del cane bastonato, il sorrisotto yankee è sparito.
«È nelle scritture!» esclama Friedkin. «Gesù esorcizzava i demoni!»
«Lo so, lo so. Assolutamente. Ecco perché la Chiesa è attenta e sceglie persone molto sante».
«E tu non lo sei?» domanda il regista.
«Non credo di essere pronto per questo» risponde monsignor Barron cercando di recuperare lo smile. «Io avrei paura».
Rileggete. Lasciate che la cosa affondi nella vostra mente: un vescovo ha paura di Satana. E non lo vorrebbe incontrare, nemmeno per fare il suo lavoro, che è salvare le anime, e curare il suo gregge.
«Quanto più in alto puoi essere rispetto all’essere un vescovo» sbotta il cineasta sconvolto. L’arcivescovo di Los Angeles accenna ad una breve risata.
«Wait a minute… » continua Friedkin gesticolando con le mani, come se cercasse di razionalizzare quanto ha appena sentito. «Non sto scherzando, sono davvero impressionato da quello che hai detto.»
«Devi trovare qualcuno che sia ad un alto livello del team spirituale… è un affare rischioso, entrare in contatto ravvicinato con il diavolo…» cerca di giustificarsi Barron.
«Perché?»
«Perché è il demonio.»
«Ma tu hai il potere di Gesù!». Davanti a simili risposte dell’arcivescovo, l’ebreo Friedkin parla oramai come un fervente cattolico, uno di quei credenti tutti di un pezzo.
«Sì ce l’ho sicuramente… ma la Chiesa vuole qualcuno che sia personalmente santo per usare quel potere, in modo più efficace».
Lì per lì, possiamo solo pensare che sia falso, che l’arcivescovo si stia inventando tutta questa storia del «sacro esorcista» per giustificare la sua paura. Non ci risulta che nell’esorcistato ci sia una selezione effettuata con «santometri» o altre tecnologie cattoliche sconosciute. La santometria esorcistica davvero ci mancava.
L’intervista, nel dolore dello spettatore cattolico, va avanti.
«Quindi credi che sia possibile, per il demone, di entrare dentro di te…?» chiede il regista.
«Sicuramente è possibile» risponde Monsignor Barron, i cui occhi, in primo piano, a questo punto possono trasmettere tutta la paura che pure ammette.
Qui c’è da alzarsi ed applaudire il cineasta fino a spellarsi le mani. Friedkin riesce a dare una testimonianza spirituale del cattolicesimo moderno che è, a dir poco, inarrivabile. E non l’ha fatto con le luci perfette de L’esorcista, ma con questa breve conversazione, filmata male, con un arcivescovo.
Ecco finalmente una scena di vero realismo da Friedkin: non gli spruzzi di vomito verde della posseduta, ma l’ammissione del fatto che un discendente degli Apostoli, oggi, teme il demonio.
Questa è la chiesa postconciliare. Non crede al soprannaturale, figuriamoci al preternaturale. Talvolta non è nemmeno che non ci crede: immersa nei suoi pantaloni casual, semplicemente non ci ha mai pensato. E quando ci pensa, perché ad un certo punto la realtà del Male può arrivare anche loro, ne hanno paura. Scappano, si imboscano, inventano scuse.
Che il Male lo combattano altri. Che questo lavoro lo facciano i professionisti. Noi abbiamo altro da fare. Organizzare eventi, curarci dei migranti…
Se questi sono i generali dell’esercito che dovrebbe difenderci dall’Inferno, se questo è il nostro katechon, siamo finiti.
C’è, tuttavia, montata con arguzia accanto alla solare scena con l’arcivescovo, un’altra intervista. A parlare è un uomo dimesso, vecchio, con un’espressione esausta. Ha i capelli arruffati e rughe immense che gli solcano la fronte, la barba un po’ lunga, la schiena ricurva.
Gli occhi di quest’uomo tuttavia sono incredibili, indimenticabili: in realtà, il suo sguardo spiega l’intera sua figura. Non sappiamo descriverli: sono occhi di un uomo che ha sofferto, ho forse occhi di un uomo che ha visto cose inimmaginabili.
Si tratta di Jeffrey Burton Russell, uno storico del Medioevo europeo noto per il suo lavoro riguardo al demonio nelle varie ere dell’umanità, dal primo cristianesimo al mondo moderno passando per l’età di mezzo.
Russell è ripreso su uno sfondo nero, e a differenza del monsignore sembra ascoltare bene le domande, in totale silenzio, per poi rispondere senza frasi fatte.
«Io credo che un potere transumano del Male esista» dice lo studioso. Friedkin gli chiede se ha mai pensato che tutto il lavoro che ha fatto (i quattro libri principali si chiamato Satan, Lucifer, Mephistopheles e Prince of Darkness) lo abbiano per caso esposto alla possessione.
Lo storico risponde che l’anno che finì di scrivere Il principe delle tenebre ebbe un attacco di grave depressione… non so se fosse possessione… so solo che le persone non si concentrano sul diavolo… io l’ho fatto e forse non lo farei un’altra volta… non pensano abbastanza al lato maligno».
Questa piccola testimonianza, all’interno del documentario, porta nel cuore del cattolico una grande speranza. Sì, ci sono persone che, a differenza dei vescovi, ancora credono nell’esistenza del Male, nei suoi attacchi. Persone che sanno con cosa si ha a che fare, e che non si imboscano dietro alla politica da ONG pietosa per evitare la principale guerra dell’universo, quella del Bene contro il Male.
È poco, è pochissimo: davanti alla catastrofe episcopale, dobbiamo accontentarci che esista un intellettuale depresso che dice di credere al maligno? No, ma la fede sulla Terra, da qualche parte deve rimanere conservata. Qualsiasi luogo, specie se lontano dalle diocesi, oggi va bene.
Di certo, non possiamo fidarci di qualcuno perché vescovo, come noi cristiani avevamo già visto durante le persecuzioni del IV secolo: famiglie intere accettavano il martirio pur di non bruciare il granello di incenso all’Imperatore, mentre alcuni vescovi invece tradivano la fede per salvarsi la vita e magari lo stipendio.
La parola «traditore» viene da qui: da quei vescovi che consegnavano – cioè, tradivano – le scritture alle autorità pagane affinché le bruciassero, nel tentativo di eradicare la fede in Gesù.
Anche quella persecuzione, anche quell’immane progetto politico del diavolo, fallì. Con la persecuzione dell’ora presente, così simile a quella del IV secolo, ammettiamo che non sappiamo ancora come andrà a finire.
Rimane che il vero film horror, la vera pellicola diabolica non è L’esorcista. È la chiesa dopo il Concilio Vaticano II.
Roberto Dal Bosco
Immagine screenshot da YouTube, riprodotta in osservanza dell’articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, poiché trattasi di «riassunto, […] citazione o […] riproduzione di brani o di parti di opera […]» utilizzati «per uso di critica o di discussione»
Arte
La Russia di Alessandro I e la disfatta di Napoleone, una lezione attuale

Renovatio 21 ripubblica questo articolo comparso su Ricognizioni.
Ideatore della società filosofico-religiosa nella città di San Pietroburgo e della rivista «Novyj Put» (che tradotto significa «La via nuova»), padre riconosciuto del Simbolismo russo, Dmitrij Sergeevic Merežkovskij è stato uno dei più interessanti scrittori russi della prima metà del ‘900. Esule a Parigi dopo la Rivoluzione d’Ottobre, dove visse e morì nel 1941, spirito profondamente religioso passato anche per la massoneria durante il periodo zarista, viene finalmente tradotto e pubblicato in Italia dall’editore Iduna.
Lo Zar Alessandro I (pagine 450, euro 25) è un’avvincente biografia in forma di romanzo dello Zar che sfidò Napoleone, una figura leggendaria e romantica, uno dei più affascinanti personaggi della dinastia dei Romanov.
Il libro è stato curato da Paolo Mathlouthi, studioso di cultura identitaria, che per le case editrici Oaks, Iduna, Bietti ha curato già diversi volumi in cui ha indagato il complesso rapporto tra letteratura e ideologia lungo gli accidentati percorsi del Novecento, attraverso una serie di caustici ritratti dedicati alle intelligenze scomode del Secolo Breve. Ricognizioni lo ha intervistato.
Sostieni Renovatio 21
Paolo Mathlouthi, lei ha definito questo romanzo un’opera germogliata dalla fantasia titanica ed immaginifica di Merežkovskij. Cosa significa?
In una celeberrima intervista rilasciata nel 1977 ad Alberto Arbasino che, per spirito di contraddizione, lo incalzava sul tema del realismo, ipnotico mantra di quella che allora si chiamava cultura militante, Jorge Luis Borges rispondeva lapidario che la letteratura o è fantastica oppure, semplicemente, non è. «Il realismo – precisava – è solo un episodio. Nessuno scrittore ha mai sognato di essere un proprio contemporaneo. La letteratura ha avuto origine con la cosmogonia, con la mitologia, con i racconti di Dèi e di mostri».
La scellerata idea, oggi tanto in voga, che la scrittura serva a monitorare la realtà, con le sue contraddizioni e i suoi rivolgimenti effimeri è una stortura, una demonia connaturata al mondo moderno. Merezkovskij si muove nello stesso orizzonte culturale e simbolico tracciato da Borges. Sa che è la Musa a dischiudere il terzo occhio del Poeta e ad alimentare il sacro fuoco dell’ispirazione. Scrivere è per lui una pratica umana che ha una strettissima correlazione con il divino, è il riverbero dell’infinito sul finito come avrebbe detto Kant, il solo modo concesso ai mortali per intravedere Dio.
Erigere cattedrali di luce per illuminare l’oscurità, spargere dei draghi il seme, «gettare le proprie arcate oltre il mondo dei sogni» secondo l’ammonimento di Ernst Junger: questo sembra essere il compito gravido di presagi che lo scrittore russo intende assegnare al periglioso esercizio della scrittura. Opporre alle umbratili illusioni del divenire la granitica perennità dell’archetipo, attingere alle radici del Mito per far sì che l’Eterno Ritorno possa compiersi di nuovo, a dispetto del tempo e delle sue forme cangianti.
Merezkovskij si è formato nell’ambito della religiosità ascetica e manichea propria della setta ortodossa dei cosiddetti Vecchi Credenti, la stessa alla quale appartiene Aleksandr Dugin. Una spiritualità, la sua, fortemente condizionata dal tema dell’atavico scontro tra la Luce e le Tenebre. Quello descritto da Merezkovskij nei suoi romanzi è un universo organico, un mosaico vivente alimentato da una legge deterministica che, come un respiro, tende alla circolarità. Un anelito alla perfezione, riletto in chiave millenaristica, destinato tuttavia a rimanere inappagato poiché la vita, nella sua componente biologica calata nel divenire, è schiava di un rigido dualismo manicheo non passibile di risoluzione.
L’esistenza, per Merezkovskij, è dominata dalla polarità, dal conflitto inestinguibile tra due verità sempre equivalenti e tuttavia contrarie: quella celeste e quella terrena, ovvero la verità dello spirito e quella della carne, Cristo e l’Anticristo. La prima si manifesta come eterno slancio a elevarsi verso Dio rinunciando a se stessi, la seconda, al contrario, è un impulso irrefrenabile in senso inverso teso all’affermazione parossistica del propria volontà individuale.
Queste due forze cosmiche, dalla cui costante interazione scaturisce il corretto ordine delle cose, sono in lotta tra loro senza che mai l’una possa prevalere sull’altra.
Cielo e terra, vita e morte, libertà e ordine, Dio e Lucifero, l’uomo e le antinomie della Storia, l’Apocalisse e la funzione salvifica della Russia: come in uno scrigno, ecco racchiusi tutti i motivi fondanti del Simbolismo russo, gli stessi che il lettore non avrà difficoltà a rintracciare nella vita dell’illustre protagonista di questa biografia.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Chi era veramente Alessandro I?
La formazione liberale ricevuta in gioventù dal precettore ginevrino Frédéric Cesar Laharpe, messogli accanto dalla nonna Caterina II perché lo istruisca sull’uso di mondo, diffonde tra i membri della corte, sempre propensi alla cospiratoria maldicenza, la convinzione che Alessandro sia un debole, troppo innamorato di Voltaire e Rousseau per potersi occupare dell’Impero con il necessario pugno di ferro.
Mai giudizio è stato più malriposto. Se la Russia non è crollata sotto l’urto della Grande Armée lo si deve innanzitutto alle insospettabili attitudini al comando rivelate dallo Zar di fronte al pericolo incombente. I suoi dignitari hanno in tutta evidenza sottovaluto la lezione di cui Alessandro I ha fatto tesoro durante gli anni trascorsi nella tenuta di Gatcina dove il padre Paolo I, inviso alla Zarina che lo tiene lontano dagli affari di governo, impone al figlio una rigida educazione di tipo prussiano: la vita di caserma con i suoi rigori e le sue privazioni, le marce forzate e la pratica delle armi fortificano il principe nel corpo e gli offrono l’opportunità di riflettere sulla reale natura del ruolo che la Provvidenza lo ha chiamato a ricoprire.
Matura in lui, lentamente ma inesorabilmente, la consapevolezza che le funamboliche astrazioni dei filosofi illuministi sono argomenti da salotto, utilissimi per intrattenere con arguzia le dame ma assai poco attinenti all’esercizio del potere e alle prerogative della maestà. La Svizzera e l’Inghilterra sono lontanissime da Carskoe Selo e per fronteggiare la minaccia rappresentata da Napoleone e impedire che l’Impero si frantumi in mille pezzi, allora come oggi alla Russia non serve un Marco Aurelio, ma un Diocleziano.
Dopo la vittoria a Bordino contro le truppe di Napoleone, non ebbe indugi nel dare alle fiamme Mosca, la città sacra dell’Ortodossia sede del Patriarcato, la Terza Roma erede diretta di Bisanzio dove gli Zar ricevono da tempo immemorabile la loro solenne investitura, pur di tagliare i rifornimenti all’ odiato avversario e consegnarlo così all’ inesorabile stretta del generale inverno. Un gesto impressionante…
Senza dubbio. Merezkovsij fa propria una visione della vita degli uomini e dei loro modi (Spengler avrebbe parlato più propriamente di «morfologia della Civiltà») segnata in maniera indelebile dall’idea della predestinazione. Un amor fati che si traduce giocoforza in un titanismo eroico tale per cui spetta solo alle grandi individualità il compito di «portare la croce» testimoniando, con il proprio operato, il compimento nel tempo del disegno escatologico in cui si estrinseca la Teodicea.
Per lo scrittore russo lo Zar è il Demiurgo, appartiene, come l’Imperatore Giuliano protagonista di un’altra sua biografia, alla stirpe degli Dèi terreni, che operano nel mondo avendo l’Eternità come orizzonte. Nella weltanschauung elaborata da Merezkovskij solo ai santi e agli eroi è concesso il gravoso privilegio di essere l’essenza di memorie future: aut Caesar, aut nihil, come avrebbe detto il Borgia. Ai giganti si confanno gesti impressionanti.
Aiuta Renovatio 21
Lei ha visto una similitudine tra l’aggressione napoleonica alla Russia di Alessandro a quanto sta avvenendo oggi…
Lo scrittore francese Sylvain Tesson, in quel bellissimo diario sulle orme del còrso in ritirata che è Beresina. In sidecar con Napoleone (edito in Italia da Sellerio) ha scritto che «davanti ai palazzi in fiamme e al cielo color sangue Napoleone comprese di aver sottovalutato la furia sacrificale dei Russi, l’irriducibile oltranzismo degli slavi». Questa frase lapidaria suona oggi alle nostre orecchie quasi come una profezia.
Quando l’urgenza del momento lo richiede, il loro fatalismo arcaico, l’innato senso del tragico, la capacità di immolare tutte le proprie forze nel rogo dell’istante, senza alcuna preoccupazione per ciò che accadrà, rendono i Russi impermeabili a qualunque privazione, una muraglia umana anonima e invalicabile, la stessa contro la quale, un secolo e mezzo più tardi, anche Adolf Hitler, giunto alle porte di Stalingrado, avrebbe visto infrangersi le proprie mire espansionistiche. Identico tipo umano, stesso nemico, medesimo risultato. Una duplice lezione della quale, come testimoniano le cronache belliche di questi mesi, i moderni epigoni di Napoleone, ormai ridotti sulla difensiva e prossimi alla disfatta nonostante l’impressionante mole di uomini e mezzi impiegata, non sembrano aver fatto tesoro.
«Ogni passo che il nemico compie verso la Russia lo avvicina maggiormente all’Abisso. Mosca rinascerà dalle sue ceneri e il sentimento della vendetta sarà la fonte della nostra gloria e della nostra grandezza». Sono parole impressionanti quelle di Merežkovskij.
A voler essere pignoli questa frase non è stata pronunciata da Merezkovskij, ma da Alessandro I in persona, a colloquio con il Generale Kutuzov poco prima del rogo fatale. Dostoevskij ci ricorda che «il cuore dell’anima russa è intessuto di tenebra». Quanto più intensa è la luce, tanto più lugubri sono le ombre che essa proietta sul muro. Ai nemici della Russia consiglio caldamente di rileggere queste parole ogni sera prima di coricarsi…
A quali scrittori si sentirebbe di accostare Merežkovskij?
L’editoria di casa nostra, non perdonando allo scrittore russo il fatto di aver salutato con favore, negli anni del suo esilio parigino, il passaggio delle divisioni della Wehrmacht lungo gli Champs Elysées, ha riservato alle sue opere una posizione marginale, ma in Russia Merezkovskij è considerato un nume tutelare, che campeggia nel pantheon del genio nazionale accanto a Tolstoj e al mai sufficientemente citato Dostoevskij che a lui sono legati, come i lettori avranno modo di scoprire, da profonda, intima consanguineità.
Paolo Gulisano
Articolo previamente apparso su Ricognizioni.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine: Adolph Northen, La ritirata di Napoleone da Mosca (1851)
Immagine di pubblico dominio CCo via Wikimedia
Arte
Microsoft vuole bandire le donne formose dai videogiuochi?

Sostieni Renovatio 21
Di recente è emerso che esistono società di consulenza che portano le case produttrici di videogiochi a inserire elementi politicamente corretti nelle loro storie: più personaggi non-bianchi, gay, trans, più lotta agli stereotipi maschili – un vasto programma nel mondo dell’intrattenimento giovanile. In un recente videogioco sono arrivati a dipingere una criminale parafemminista uccidere Batman. L’incredibile sviluppo, lesivo non solo delle passioni dei fan ma propriamente del valore dell’IP (la proprietà intellettuale; i personaggi di film, fumetti e videogiochi questo sono, in termini legali ed economici) è stato letto come una dichiarazione di guerra del sentire comune, con l’esecuzione del Batmanno come chiaro emblema del patriarcato e della concezione del crimine come qualcosa da punire. Sorveglia e punire: non l’agenda portata avanti negli USA dai procuratori distrettuali eletti con finanziamenti di George Soros, nelle cui città, oramai zombificate, ora governa il caos sanguinario e il disordine più tossico.tesla cybertruck is just ps1 lara croft boobs pic.twitter.com/W6BXuGzMRq
— scene celebrity (@whackkat) May 12, 2021
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Arte
No al Jazz. Sì al Dark Jazz

In un mattino qualsiasi dello scorso anno scoprii l’esistenza della musica Dark Jazz, e mi piacque.
Intendiamoci: ritengo di per sé il jazz una musica incomprensibile, a tratti censurabile. Sono pronto già ora a scrivere un disegno di legge per impedire la nerditudine jazzistica qualora espressa in pubblico: avete presente, quei tizi che si mettono a tamburellare sillabando a parole ritmi indefinibili «da-pu-dapudada-puda-da-pu-da-pu», e non capisci se stanno mimando il piano, il sassofono, la chitarra, la batteria, il contrabbasso. A loro interessa solo fare «da-be-du-pu-dapudadeda-pudade-da-pu-da-pu-de», percuotendo qualsiasi superficie a portata, anche e soprattutto in assenza di musica di sottofondo.
A costoro non deve essere portato nessun rispetto, a costoro va usato il pugno di ferro di una legge con pene severissime per ogni «da-pu-dadepudada-depudade-dade-pude-da-pu-de-pu-dada» emesso in pubblico, e un pensiero andrebbe fatto anche per un divieto nelle case private.
I jazzomani sono un problema sociale che la Repubblica Italiana ha ignorato per troppo tempo. Sappiamo, anzi, che essi dilagavano anche sotto il fascismo, e uno degli untori della jazzomania italica fu il filosofo destroide Giulio Evola (1898-1974), che oggi non vogliam chiamare Julius, e ci chiediamo perché per tutti questi anni lo abbiano fatto gli altri.
Sostieni Renovatio 21
A questo punto un disclaimer, ché non salti fuori qualcuno che accusi di incoerenza: tanti anni fa partecipai, producendo videoproiezioni, ad uno dei grandi festival di Jazz siti in Italia, il cui direttore è l’amico compagno di giovanili scorribande eurasiatiche, in ispecie in Ucraina e Crimea, quando ancora era ucraina (ma le scritte NO NATO già v’erano). Proiettai immagini durante un omaggio a Piero Piccioni in un prestigiosissimo teatro del Nord; l’anno successivo invece lavorai alle proiezioni per un omaggio a Roman Polanski suonato dal polacco Marcin Wasilewski – è fu un concerto estivo stupendo, struggente, emozionante.
Ciò detto, basta col jazz. Basta soprattutto con i suoi appassionati e la loro aria di superiorità morale stile lettore di Repubblica in era berlusconiana.
Basta con quelli capaci di parlarti per ore di Carlo Parker, Duca Ellington, Miles Davis, Dizzy Gillespy – senza darti nemmeno il tempo di intervenire per protestare che di tutto l’esercito di geni afroamericani a te non te ne frega niente.
A costoro vorremmo poter ricordare l’immortale scena di Collateral (2004), dove al tizio saputo che racconta con boria flemmatica un retroscena della storia del Jazz, il brizzolato killer interpretato da Tom Cruise pianta una serie di pallottole in fronte.
Vabbè, così è un po’ esagerato. Però ebbasta. Eddai. No Jazz. No «da-pu-dabe-dedu-pude-dapudadeda-dapude-da-pu-da-pu-dadeda».
Purtuttavia, siamo pronti a riconoscere che va ammessa l’attenuante per chi il jazz lo suona: il musicista jazzo, va riconosciuto, sa suonare, anzi, ha di solito pure studiato, e non poco. Anzi a questo punto osanniamo anche il capolavoro cinematografico Whiplash (2024) per aver raccontato in modo magistrale i dolori che questi artisti devono affrontare.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
È quindi con estrema sorpresa che, quel giorno dello scorso anno, abbiamo ricevuto dall’algoritmo di YouTube (lo stesso che censura i video di Renovatio 21, pure quelli privati) il suggerimento di ascoltare questa misteriosa compilation di Dark Jazz.
Potete farlo anche voi. Noi ne siamo rimasti affascinati parecchio.
Sentite le atmosfere? Sì, sembrano antiche, ti pare di essere in un film noir del primo Novecento, o forse no – i noir hollywoodiani non mettevano il jazz – sei nella percezione del Noir che si aveva negli anni Novanta, come in un film di Davide Lynch, ma più definito, anche se sempre altamente inquietante, ambiguo, agrodolce. Il fantasma di Badalamenti, il compositore non il capo-mafia, aleggia su tutto.
O forse, si tratta solo di un riflesso presente, un riflesso di noi? Si tratta degli anni 2020, che guardano agli anni Novanta, che andavano indietro di mezzo secolo?
Non lo sappiam, ma ci gusta, e anche molto.
Abbiamo così compreso che si tratta di un genere, anche se non ancora catalogato ufficialmente. Altri nomi possono essere usati per la categoria, come «Doom Jazz», «Jazz Noir», persino «Horror Jazz»…
Aiuta Renovatio 21
Per orientarsi, bisogna compulsare i forum, dove altri come me hanno notato l’esistenza del genere, e cercano suggerimenti.
Consigliano, ad esempio, il Zombies Never Die Blues dei Bohren & der Club of Gore, un gruppo tedesco della Ruhr fondato nel 1988 che, partito dal Metal e dall’Hardcore, è considerato il capostipite del genere.
Salta fuori in gruppo che si chiama Free Nelson Mandoomjazz.
Sostieni Renovatio 21
Da segnalare assolutamente il Lovecraft Sextet, con la loro musica dedicata all’«orrore cosmico» di cui scriveva il solitario autore di Providence che inventò Chtulhu.
Kilimanjaro Dark Jazz Ensamble, Non Violent Communication, Asunta e Hal Willner sono gli altri grandi nomi citati per il genere. E ancora, i russi Povarovo, i neoeboraceni Tartar Lamb, i tedeschi Radare e Taumel, gli italiani Senketsu No Night Club, Macelleria Mobile di Mezzanotte e Detour Doom Project, i progetti che raccolgono australiani, italiani e messicani come Last Call at Nightowls.
Insomma tanta roba da ascoltare, specie quando si sta facendo dell’altro.
C’è sempre tempo per ricredersi su una cosa. Tuttavia, sul jazz in generale, resto sulle mie posizioni: subito una legge per proibire il jazzomanismo, ma con un emendamento per salvare il Dark Jazzo.
No?
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori della 16ª settimana 2024
-



 Pensiero2 settimane fa
Pensiero2 settimane faForeign Fighter USA dal fronte ucraino trovato armato in Piazza San Pietro. Perché?
-



 Vaccini1 settimana fa
Vaccini1 settimana faLanciati i vaccini RNA monodose contro COVID e influenza per i bambini. I critici: «livelli di follia senza precedenti»
-



 Autismo2 settimane fa
Autismo2 settimane faAutismo, 28enne olandese sarà uccisa con il suicidio assistito: i medici la ritengono che «incurabile»
-



 Cina1 settimana fa
Cina1 settimana faTongTong, la «ragazzina» creata con l’Intelligenza Artificiale per la Cina senza figli
-

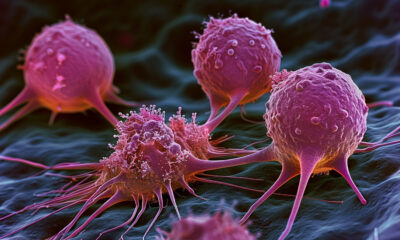

 Cancro1 settimana fa
Cancro1 settimana faVaccino mRNA, «aumenti significativi» delle morti per cancro dopo la terza dose: studio giapponese
-



 Pensiero7 giorni fa
Pensiero7 giorni fa«Preghiera» pagana a Zeus ed Apollo recitata durante cerimonia di accensione della torcia olimpica. Quanti sacrifici umani verranno fatti, poi, con l’aborto-doping?
-



 Droni1 settimana fa
Droni1 settimana faI droni israeliani attirano i palestinesi con audio di bambini che piangono e poi gli sparano