Arte
Zerocalcare, il pericolo mortale di «Strappare lungo i bordi»
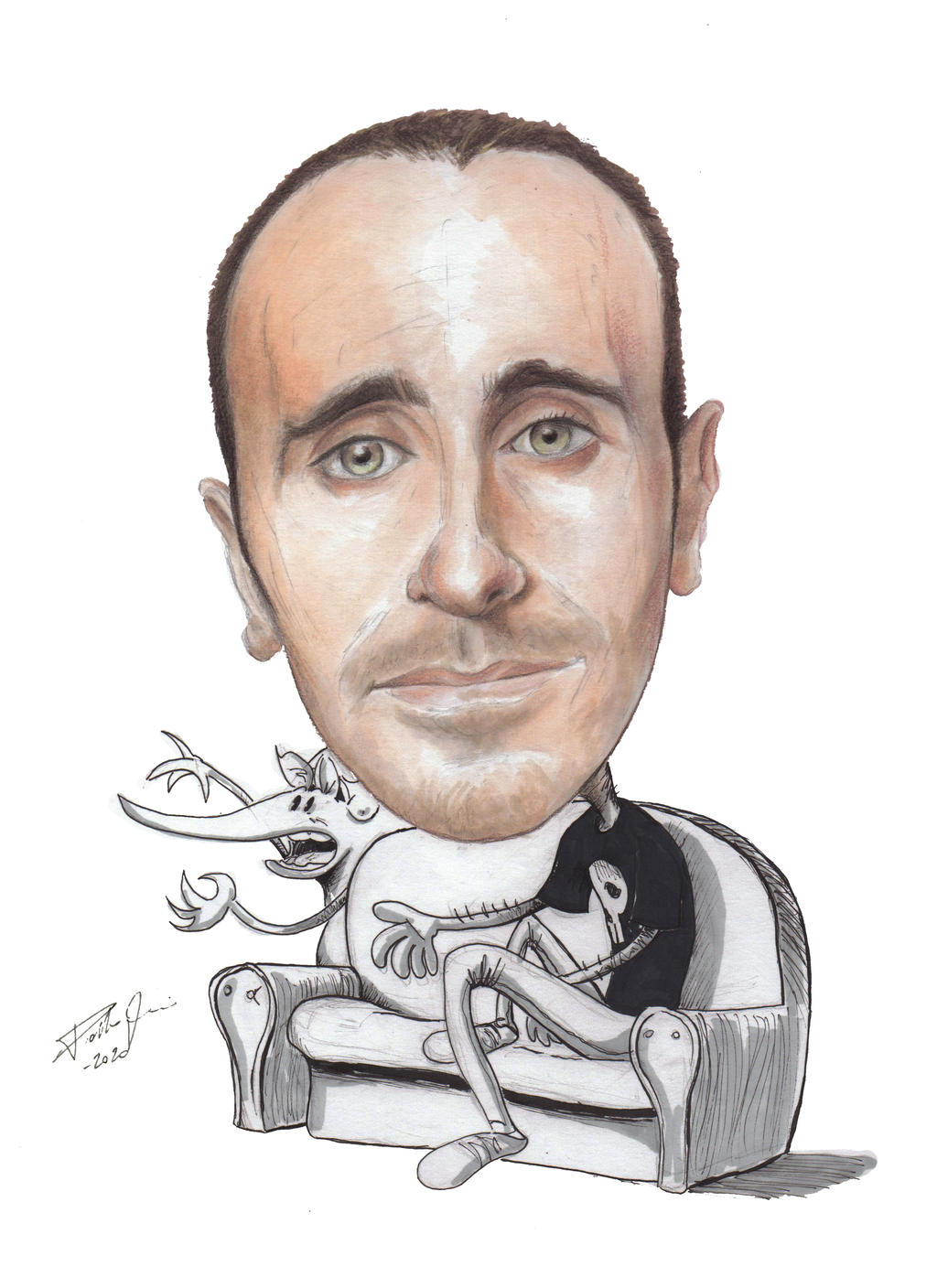
L’evento audiovisivo dell’anno è con probabilità – dopo Squid Game – Strappare lungo i bordi, opera di animazione Netflix in sei episodi firmata dall’oramai celeberrimo Zerocalcare.
Zerocalcare è un romano nato nel 1984. All’anagrafe si chiama in realtà Michele Rech, ponendosi quindi nel solco degli artisti romani che coprono un nome nordico con uno pseudonimo, come nel caso del grande Franco Lechner (1931-1987), in arte Bombolo, o la recentissimamente scomparsa Lina Wertmüller (1928-2021), il cui nome per esteso era Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich (in pratica aveva un nome lungo quanto gli improbabili titoli delle sue pellicole).
Zerocalcare è senza dubbio il più grande artista della sua generazione per quanto riguarda il fumetto e ora anche il cinema di animazione. Il suo è un successo davvero autentico: viene davvero dal basso, da un passaparola furioso dei suoi sostenitori (un insieme molto trasversale) che forse pure precede, o può ignorare, i social media.
Zerocalcare è senza dubbio il più grande artista della sua generazione per quanto riguarda il fumetto e ora anche il cinema di animazione
Viene dai centri sociali, un mondo che da decenni ha perso la sua spinta. La cosa è pienamente avvertibile nella sua opera, dove si dedica per lo più riferimenti della cultura popolare trasmessa dalla TV (Guerre Stellari, I Cavalieri dello Zodiaco, Game of Thrones, I Simpson, Ken il Guerriero), che con ogni evidenza vince per profondità e persistenza sulle mitologie gosciste.
La sparizione dell’anima dell’universo un tempo detto «antagonista» è stata drammaticamente visibile durante la pandemia, dove i ribelli libertari non hanno fiatato mentre si installava nelle loro città un vero Stato di polizia che ogni giorno che passa diventa sempre più distopico (botte dai celerini, libertà di parola proibita, pass digitali). Di fatto, del tema della pandemia in Strappare lungo i bordi non c’è traccia alcuna: il «centrosocialismo», con evidenza, non disponeva della capacità di calcolo per una cosa del genere, né la volontà di antagonizzare davvero il potere costituito quando esso mostra il suo vero volto.
Ad ogni modo, la serie è di altissima fattura. La sfida di trasporre in immagini in movimento la caratteristica principale dei fumetti dell’autore – ossia la visualizzazione immediata di tutti i pensieri del protagonista – è riuscita in pieno, forse in modo ancora più divertente rispetto alla carta. Si ride e si ghigna ad ogni piè sospinto.
Certo, un paio di cose stonano, forse in maniera imperdonabile. Della sigla simil-Riccardo Fogli ci chiediamo tuttora la significazione, ed è mandata in onda, apparentemente senza ironia, pure una canzone di Ron. Poi, la presenza, anche solo in voce, di Mastrandrea… Ma perché? Perché?
Del tema della pandemia in Strappare lungo i bordi non c’è traccia alcuna: il «centrosocialismo», con evidenza, non disponeva della capacità di calcolo per una cosa del genere, né la volontà di antagonizzare davvero il potere costituito quando esso mostra il suo vero volto
La serie ha fatto scattare un paio di polemiche sui giornali mainstream. La prima, la più stupida, era sul persistente uso del romanesco. La seconda invece riguardava una questione di modelli umani.
La seconda, lanciata dall’ex parlamentare radicale Daniele Capezzone, ora giornalista del quotidiano non allineato La Verità, «Voi con Zerocalcare, noi con Clint Eastwood. A ciascuno il suo, e ciascuno contento: chi con la lagna e il disagio come dimensione esistenziale; chi invece con la lotta, la sfida, l’affermazione dell’individuo contro ogni potere». Lo Zerocalcare risponde: «A me me fa volà che DANIELECAPEZZONE se sente come CLINT EASTWOOD». Non sappiamo bene se ci sua qualche allusione che non capiamo. Tra gli utenti di Twitter, scroscianti applausi.
A me me fa volà che DANIELECAPEZZONE se sente come CLINT EASTWOOD https://t.co/5tLk2jyyFD
— zerocalcare (@zerocalcare) December 3, 2021
Nella storia, a Biella i genitori della ragazza suicida hanno allestito per la «cerimonia funebre» la sua palestra di Boxe
Tuttavia vorremo qui parlare di qualcosa di più serio.
Gli episodi sono essenzialmente costruiti su due livelli, che peraltro non si incollano benissimo fra loro: da una parte una serie di gag sul micromondo del ragazzo, con discorsi che vanno dalla sporcizia del bagno degli uomini alla sporcizia del suo divano, passando per il dolore di deludere la propria maestra alle elementari.
A questi segmenti, divertenti e autoconclusivi, è agglutinata la storia principale, che (SPOILER) è il viaggio, anche questo di minimalismo disperato, da Roma a Biella per andare al «funerale» di un’amica, potenzialmente una morosa, morta suicida.
E in questo frangente che si pongono, per chi ha presente di cosa si sta parlando, dei problemi di non poco conto.
Riteniamo questa cosa – le esequie di un suicida celebrate in qualsiasi forma, nella palestra di un centro sociale o in una cattedrale della fu religione cattolica – un pericolo estremo per la società, un rischio mortale e concreto per tante persone
Un giornale romano lo ha intervistato titolando «È una storia autobiografica, tranne il suicidio». Dice che il personaggio di Alice, la ragazza suicida al centro dell’intreccio, è immaginario. Noi tuttavia ricordiamo un suo fumetto, uno dei primi, che cercava di elaborare la morte di un’amica anoressica. Non sappiamo se si trattai di quello. «Non avevo voglia di raccontare una persona specifica per non lederne la privacy. Evidentemente, però, nella vita mi sono trovato a vivere delle situazioni molto simili» chiosa.
Nella storia, a Biella i genitori della ragazza hanno allestito per la «cerimonia funebre» la sua palestra di Boxe, che sembra uno di quei luoghi che, come da moda recente (a sinistra ma non solo), vengono «okkupati» per questioni sportive.
La suicida, viene detto orgogliosamente al microfono, non era una vittima. Il protagonista si interroga sulla mancata solennità della situazione.
Vengono fatti ascoltare gli audio della ragazza con i bambini per cui faceva la volontaria. Canzoni. Ricordi. È una festicciola, anche affollata, in onore di quella che si è uccisa.
Se c’è una cosa detta giusta dall’OMS è che il suicidio è contagioso. Il suicidio infetta chi gli sta intorno. Il suicidio può propagarsi come una vera epidemia
Il suicidio non viene condannato, da nessuno. Per qualche minuto, qualche domanda viene posta. Ma in fondo, pare di capire da altri discorsi che vengono fatti tra gli amici, è una sua scelta. Così come quella di aver voglia di fare sesso, o di mangiare del gelato a tarda notte, o di provare un’esperienza «lella», cioè lesbica.
Ha deciso di andarsene, punto. Non dobbiamo stare qui a chiederci il motivo. Celebriamone, tutti insieme, l’esistenza – compresa forse anche quest’ultima scelta. Si ricava questa impressione. E dobbiamo essere sinceri, è quella che si ha da qualsiasi funerale conciliare fatto ad un morto suicida.
Riteniamo questa cosa – le esequie di un suicida celebrate in qualsiasi forma, nella palestra di un centro sociale o in una cattedrale della fu religione cattolica – un pericolo estremo per la società, un rischio mortale e concreto per tante persone.
Non stiamo parlando a caso. Perché se c’è una cosa detta giusta dall’OMS è che il suicidio è contagioso. Il suicidio infetta chi gli sta intorno. Il suicidio può propagarsi come una vera epidemia.
Se il semplice «parlare» di un suicidio come fatto di cronaca fa aumentare i suicidi, giustificare un morto suicida, che effetto può avere? E fare della sua morte una celebrazione?.
Ma non è solo l’OMS. Questa semplice verità, e cioè che il suicidio può contagiare, è conosciuta, in teoria, perfino dall’Ordine dei Giornalisti, che sul suicidio mette in piedi corsi deontologici:
«Le norme deontologiche indicano chiaramente le cautele con cui devono essere esposti questi casi per non provocare dei fenomeni di emulazione: ci sono dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che dimostrano in modo chiaro che parlare dei suicidi fa aumentare il numero delle persone che decidono di togliersi la vita».
Se il semplice «parlare» di un suicidio come fatto di cronaca fa aumentare i suicidi, giustificare un morto suicida, che effetto può avere? E fare della sua morte una celebrazione festosa?
Ne parlo perché ho potuto testimoniare in prima persona il fenomeno: i suicidi si possono presentare sotto forma di cluster, di «grappoli» devastanti. Ne avevo scritto su un vecchio articolo pubblicato anni fa su Renovatio 21, «La vita senza il dolore». Ciò che vi scrivevo è ancora vivissimo dentro di me.
Organizzarono un funerale in chiesa per A. e io sapevo che era la cosa sbagliata, per il semplice fatto che la mia sensibilità tradizionale mi porta a sapere che, prima del Concilio Vaticano II, i funerali dei suicidi, saggiamente, non venivano celebrati. O almeno, non si facevano messe pubbliche
C’è stato un anno in cui nel giro di poco tempo ho visto morire per suicidio una sequela di amici e conoscenti. Fu sconvolgente: sparivano uno dopo l’altro. Alcuni casi in teoria non erano collegabili fra loro. Altri, invece, sì.
Iniziò A., e fu straziante. Ricordo la telefonata a tarda sera degli amici, che chiamavano dalla camera mortuaria. «Cosa?». «A. non c’è più». Ti si spalanca davanti il vuoto. Il vuoto poi comincia a vorticare. Perché? Lo sai perché. Forse non lo sai. E poi potevi fare qualcosa, potevi vederlo più spesso, anche se non c’era mai l’occasione, ormai. Ma no, non potevi fare nulla. Ecco, adesso vuol dire che a Natale quest’anno non lo rivedrai? Vuol dire che non ti farà una di quelle sue telefonate con la sua parlata irresistibile? Ma come è possibile? Poi, per tutta la notte, sentimenti indefinibili. Nei giorni successivi, pure.
Organizzarono un funerale in chiesa per A. e io sapevo che era la cosa sbagliata, per il semplice fatto che la mia sensibilità tradizionale mi porta a sapere che, prima del Concilio Vaticano II, i funerali dei suicidi, saggiamente, non venivano celebrati. O almeno, non si facevano messe pubbliche.
Ma la Chiesa, con il Concilio, è cambiata: l’Inferno è stato di fatto «svuotato». Quindi i peccati, compresi i suicidi, non potevano che aumentare a dismisura: cosa ti ferma, davanti all’errore, se non c’è il timore della punizione tremenda? Questa è la chiesa che rifiuto, e che combatterò sempre, e che accuso anche di tutte queste morti, che sono milioni.
Non fu solo quello il motivo per cui decisi, con dolore, di non partecipare. Avevo appreso che gli amici intendevano fare uno show completo: letture belle, e poi via con l’ascolto delle musiche preferite di A., che era un cultore, con tanto di spiegazione dal pubblico di altro amico musicofilo. Scelsi di stare lontanissimo da tutto questo: andai ad una conferenza in Centro Italia, di quelle dove si parla delle devastazioni del Concilio Vaticano II, e ricordai, con un accenno anonimo, A., vittima di un mondo dove la religione non ti racconta più cosa è il Bene, e che dono infinito sia la vita umana. Trovai lì un sacerdote tradizionista, un grande prete che riuscì a capire la situazione. Chiesi di dire una messa per l’anima di A., pensando così di aver chiuso nel modo giusto la storia.
La questione, tuttavia, non riguarda questi cartoni animati. È l’aria che essi respirano, che respiriamo tutti. È la Necrocultura. È la legge della realtà del secolo, è il sistema operativo del mondo moderno: tutto deve tendere alla distruzione dell’essere umano, alla sua umiliazione alla sua dannazione
E invece, mi sbagliavo terribilmente.
Poco dopo, sarebbe stata la volta di R.
Con R., che conoscevo meno, c’era una relazione famigliare. Lui si definiva come un cugino acquisito, e chiamava scherzosamente mia sorella «cugi». Mi telefonarono di pomeriggio, mentre lavoravo. Mi fu impossibile continuare qualsiasi attività. Mi fu impossibile, parimenti, non pensare ad A., non risentire tutto quel dolore, ora maggiorato, divenuto ancora più irrazionale.
Poi la realizzazione. R. era andato ai «funerali» musicali di A. Come non pensare che, nella mente di qualcuno che ospita l’oscuro pensiero, possa scattare quel clic: se me ne vado sarò ricordato dai miei amici tutti uniti, felici, messi insieme dalle cose che ci piacciono, da un senso di affetto collettivo quasi liberatorio, catartico. La mia festa più bella – senza di me. Clic.
È chiaro che sono solo le mie stupide ipotesi. Non ho il potere di conoscere cosa c’era dentro all’anima in quel momento. Tuttavia, sulla contagiosità del suicidio, come ammesso dall’OMS e pure in teoria dalla deontologia dei giornalisti, ci sono elementi concreti.
Potete capire, quindi, perché posso ritenere pericolosa la serie di Zerocalcare. Il funerale bordo ring mi hanno ricordato A. e R. E il nulla infinito che se li è portati via, e che, senza che qualcuno faccia qualcosa, continua ad avanzare disintegrando il nostro mondo e portandosi dietro tante anime.
La situazione attuale: la Cultura della Morte è uscita allo scoperto e ci ha circondato e imprigionato
La questione, tuttavia, non riguarda questi cartoni animati. È l’aria che essi respirano, che respiriamo tutti. È la Necrocultura. È la legge della realtà del secolo, è il sistema operativo del mondo moderno: tutto deve tendere alla distruzione dell’essere umano, alla sua umiliazione alla sua dannazione.
Chi doveva difenderci, non è sparito: si è messo dalla parte dei demoni.
«L’Ordine dei giornalisti e l’OMS, ho detto all’inizio, quanto meno sulla carta si preoccupano del carattere contagioso del suicidio; la Chiesa di oggi invece no» scrivevo tre anni fa.
Potete, se volte, leggere il pezzo dedicato alla serie mandato in stampa dal giornale dei vescovi, Avvenire. La questione è totalmente ignorata (così come una microsequenza con un Armadillo prete che celebra dicendo volgarità: non sappiamo se un tempo sarebbe stata ritenuta legale). Ai cattolici di oggi, cosa interessa? Di fatto, cosa li divide dai centri sociali e dai loro «riti» improbabili?
«Perché la Chiesa di oggi è davvero un ente stupido quanto assassino» sbraitavo nel vecchio articolo. «Perché la Chiesa di oggi è il vero problema, il vero nemico dell’Umanità e del Dio della Vita».
Terminavo con un discorso filosofico sul dolore che integra la vita, da bisogna voler celebrare tutta intera, perché la vita è qualcosa di superiore al dolore e al piacere, è ciò che li contiene, e che, nella sua forza divina, va avanti anche senza di essi.
Tanti altri, da quando è iniziata questa storia, sono morti. Questo è un fatto che abbiamo accettato. Solo, ricordiamoci di non celebrarlo. Ricordiamoci di combatterlo.
Blah blah. Tutto giusto, per carità. Ma guardo alla situazione attuale: la Cultura della Morte è uscita allo scoperto e ci ha circondato e imprigionato.
In questi due anni, resistere alla lusinga della tenebra per molti è diventato difficile. Lo sappiamo dalle statistiche. L’impianto dello Stato globale pandemico ha avuto questo effetto, e forse era nei programmi. Di certo, qui la gerarchia cattolica ha dato una grossa mano, mostrandosi programmaticamente impotente verso un organismo acellulare che ha chiuso i suoi templi e cancellato i suoi riti – oltre ad aver introdotto un sacramento nuovo, quello della siringa mRNA.
Tanti altri, da quando è iniziata questa storia, sono morti. Questo è un fatto che abbiamo accettato.
Solo, ricordiamoci di non celebrarlo. Ricordiamoci di combatterlo.
Roberto Dal Bosco
Immagine di Peterbandle85 via Deviantart pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-ND 3.0)
Arte
La Russia di Alessandro I e la disfatta di Napoleone, una lezione attuale

Renovatio 21 ripubblica questo articolo comparso su Ricognizioni.
Ideatore della società filosofico-religiosa nella città di San Pietroburgo e della rivista «Novyj Put» (che tradotto significa «La via nuova»), padre riconosciuto del Simbolismo russo, Dmitrij Sergeevic Merežkovskij è stato uno dei più interessanti scrittori russi della prima metà del ‘900. Esule a Parigi dopo la Rivoluzione d’Ottobre, dove visse e morì nel 1941, spirito profondamente religioso passato anche per la massoneria durante il periodo zarista, viene finalmente tradotto e pubblicato in Italia dall’editore Iduna.
Lo Zar Alessandro I (pagine 450, euro 25) è un’avvincente biografia in forma di romanzo dello Zar che sfidò Napoleone, una figura leggendaria e romantica, uno dei più affascinanti personaggi della dinastia dei Romanov.
Il libro è stato curato da Paolo Mathlouthi, studioso di cultura identitaria, che per le case editrici Oaks, Iduna, Bietti ha curato già diversi volumi in cui ha indagato il complesso rapporto tra letteratura e ideologia lungo gli accidentati percorsi del Novecento, attraverso una serie di caustici ritratti dedicati alle intelligenze scomode del Secolo Breve. Ricognizioni lo ha intervistato.
Sostieni Renovatio 21
Paolo Mathlouthi, lei ha definito questo romanzo un’opera germogliata dalla fantasia titanica ed immaginifica di Merežkovskij. Cosa significa?
In una celeberrima intervista rilasciata nel 1977 ad Alberto Arbasino che, per spirito di contraddizione, lo incalzava sul tema del realismo, ipnotico mantra di quella che allora si chiamava cultura militante, Jorge Luis Borges rispondeva lapidario che la letteratura o è fantastica oppure, semplicemente, non è. «Il realismo – precisava – è solo un episodio. Nessuno scrittore ha mai sognato di essere un proprio contemporaneo. La letteratura ha avuto origine con la cosmogonia, con la mitologia, con i racconti di Dèi e di mostri».
La scellerata idea, oggi tanto in voga, che la scrittura serva a monitorare la realtà, con le sue contraddizioni e i suoi rivolgimenti effimeri è una stortura, una demonia connaturata al mondo moderno. Merezkovskij si muove nello stesso orizzonte culturale e simbolico tracciato da Borges. Sa che è la Musa a dischiudere il terzo occhio del Poeta e ad alimentare il sacro fuoco dell’ispirazione. Scrivere è per lui una pratica umana che ha una strettissima correlazione con il divino, è il riverbero dell’infinito sul finito come avrebbe detto Kant, il solo modo concesso ai mortali per intravedere Dio.
Erigere cattedrali di luce per illuminare l’oscurità, spargere dei draghi il seme, «gettare le proprie arcate oltre il mondo dei sogni» secondo l’ammonimento di Ernst Junger: questo sembra essere il compito gravido di presagi che lo scrittore russo intende assegnare al periglioso esercizio della scrittura. Opporre alle umbratili illusioni del divenire la granitica perennità dell’archetipo, attingere alle radici del Mito per far sì che l’Eterno Ritorno possa compiersi di nuovo, a dispetto del tempo e delle sue forme cangianti.
Merezkovskij si è formato nell’ambito della religiosità ascetica e manichea propria della setta ortodossa dei cosiddetti Vecchi Credenti, la stessa alla quale appartiene Aleksandr Dugin. Una spiritualità, la sua, fortemente condizionata dal tema dell’atavico scontro tra la Luce e le Tenebre. Quello descritto da Merezkovskij nei suoi romanzi è un universo organico, un mosaico vivente alimentato da una legge deterministica che, come un respiro, tende alla circolarità. Un anelito alla perfezione, riletto in chiave millenaristica, destinato tuttavia a rimanere inappagato poiché la vita, nella sua componente biologica calata nel divenire, è schiava di un rigido dualismo manicheo non passibile di risoluzione.
L’esistenza, per Merezkovskij, è dominata dalla polarità, dal conflitto inestinguibile tra due verità sempre equivalenti e tuttavia contrarie: quella celeste e quella terrena, ovvero la verità dello spirito e quella della carne, Cristo e l’Anticristo. La prima si manifesta come eterno slancio a elevarsi verso Dio rinunciando a se stessi, la seconda, al contrario, è un impulso irrefrenabile in senso inverso teso all’affermazione parossistica del propria volontà individuale.
Queste due forze cosmiche, dalla cui costante interazione scaturisce il corretto ordine delle cose, sono in lotta tra loro senza che mai l’una possa prevalere sull’altra.
Cielo e terra, vita e morte, libertà e ordine, Dio e Lucifero, l’uomo e le antinomie della Storia, l’Apocalisse e la funzione salvifica della Russia: come in uno scrigno, ecco racchiusi tutti i motivi fondanti del Simbolismo russo, gli stessi che il lettore non avrà difficoltà a rintracciare nella vita dell’illustre protagonista di questa biografia.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Chi era veramente Alessandro I?
La formazione liberale ricevuta in gioventù dal precettore ginevrino Frédéric Cesar Laharpe, messogli accanto dalla nonna Caterina II perché lo istruisca sull’uso di mondo, diffonde tra i membri della corte, sempre propensi alla cospiratoria maldicenza, la convinzione che Alessandro sia un debole, troppo innamorato di Voltaire e Rousseau per potersi occupare dell’Impero con il necessario pugno di ferro.
Mai giudizio è stato più malriposto. Se la Russia non è crollata sotto l’urto della Grande Armée lo si deve innanzitutto alle insospettabili attitudini al comando rivelate dallo Zar di fronte al pericolo incombente. I suoi dignitari hanno in tutta evidenza sottovaluto la lezione di cui Alessandro I ha fatto tesoro durante gli anni trascorsi nella tenuta di Gatcina dove il padre Paolo I, inviso alla Zarina che lo tiene lontano dagli affari di governo, impone al figlio una rigida educazione di tipo prussiano: la vita di caserma con i suoi rigori e le sue privazioni, le marce forzate e la pratica delle armi fortificano il principe nel corpo e gli offrono l’opportunità di riflettere sulla reale natura del ruolo che la Provvidenza lo ha chiamato a ricoprire.
Matura in lui, lentamente ma inesorabilmente, la consapevolezza che le funamboliche astrazioni dei filosofi illuministi sono argomenti da salotto, utilissimi per intrattenere con arguzia le dame ma assai poco attinenti all’esercizio del potere e alle prerogative della maestà. La Svizzera e l’Inghilterra sono lontanissime da Carskoe Selo e per fronteggiare la minaccia rappresentata da Napoleone e impedire che l’Impero si frantumi in mille pezzi, allora come oggi alla Russia non serve un Marco Aurelio, ma un Diocleziano.
Dopo la vittoria a Bordino contro le truppe di Napoleone, non ebbe indugi nel dare alle fiamme Mosca, la città sacra dell’Ortodossia sede del Patriarcato, la Terza Roma erede diretta di Bisanzio dove gli Zar ricevono da tempo immemorabile la loro solenne investitura, pur di tagliare i rifornimenti all’ odiato avversario e consegnarlo così all’ inesorabile stretta del generale inverno. Un gesto impressionante…
Senza dubbio. Merezkovsij fa propria una visione della vita degli uomini e dei loro modi (Spengler avrebbe parlato più propriamente di «morfologia della Civiltà») segnata in maniera indelebile dall’idea della predestinazione. Un amor fati che si traduce giocoforza in un titanismo eroico tale per cui spetta solo alle grandi individualità il compito di «portare la croce» testimoniando, con il proprio operato, il compimento nel tempo del disegno escatologico in cui si estrinseca la Teodicea.
Per lo scrittore russo lo Zar è il Demiurgo, appartiene, come l’Imperatore Giuliano protagonista di un’altra sua biografia, alla stirpe degli Dèi terreni, che operano nel mondo avendo l’Eternità come orizzonte. Nella weltanschauung elaborata da Merezkovskij solo ai santi e agli eroi è concesso il gravoso privilegio di essere l’essenza di memorie future: aut Caesar, aut nihil, come avrebbe detto il Borgia. Ai giganti si confanno gesti impressionanti.
Aiuta Renovatio 21
Lei ha visto una similitudine tra l’aggressione napoleonica alla Russia di Alessandro a quanto sta avvenendo oggi…
Lo scrittore francese Sylvain Tesson, in quel bellissimo diario sulle orme del còrso in ritirata che è Beresina. In sidecar con Napoleone (edito in Italia da Sellerio) ha scritto che «davanti ai palazzi in fiamme e al cielo color sangue Napoleone comprese di aver sottovalutato la furia sacrificale dei Russi, l’irriducibile oltranzismo degli slavi». Questa frase lapidaria suona oggi alle nostre orecchie quasi come una profezia.
Quando l’urgenza del momento lo richiede, il loro fatalismo arcaico, l’innato senso del tragico, la capacità di immolare tutte le proprie forze nel rogo dell’istante, senza alcuna preoccupazione per ciò che accadrà, rendono i Russi impermeabili a qualunque privazione, una muraglia umana anonima e invalicabile, la stessa contro la quale, un secolo e mezzo più tardi, anche Adolf Hitler, giunto alle porte di Stalingrado, avrebbe visto infrangersi le proprie mire espansionistiche. Identico tipo umano, stesso nemico, medesimo risultato. Una duplice lezione della quale, come testimoniano le cronache belliche di questi mesi, i moderni epigoni di Napoleone, ormai ridotti sulla difensiva e prossimi alla disfatta nonostante l’impressionante mole di uomini e mezzi impiegata, non sembrano aver fatto tesoro.
«Ogni passo che il nemico compie verso la Russia lo avvicina maggiormente all’Abisso. Mosca rinascerà dalle sue ceneri e il sentimento della vendetta sarà la fonte della nostra gloria e della nostra grandezza». Sono parole impressionanti quelle di Merežkovskij.
A voler essere pignoli questa frase non è stata pronunciata da Merezkovskij, ma da Alessandro I in persona, a colloquio con il Generale Kutuzov poco prima del rogo fatale. Dostoevskij ci ricorda che «il cuore dell’anima russa è intessuto di tenebra». Quanto più intensa è la luce, tanto più lugubri sono le ombre che essa proietta sul muro. Ai nemici della Russia consiglio caldamente di rileggere queste parole ogni sera prima di coricarsi…
A quali scrittori si sentirebbe di accostare Merežkovskij?
L’editoria di casa nostra, non perdonando allo scrittore russo il fatto di aver salutato con favore, negli anni del suo esilio parigino, il passaggio delle divisioni della Wehrmacht lungo gli Champs Elysées, ha riservato alle sue opere una posizione marginale, ma in Russia Merezkovskij è considerato un nume tutelare, che campeggia nel pantheon del genio nazionale accanto a Tolstoj e al mai sufficientemente citato Dostoevskij che a lui sono legati, come i lettori avranno modo di scoprire, da profonda, intima consanguineità.
Paolo Gulisano
Articolo previamente apparso su Ricognizioni.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine: Adolph Northen, La ritirata di Napoleone da Mosca (1851)
Immagine di pubblico dominio CCo via Wikimedia
Arte
Microsoft vuole bandire le donne formose dai videogiuochi?

Sostieni Renovatio 21
Di recente è emerso che esistono società di consulenza che portano le case produttrici di videogiochi a inserire elementi politicamente corretti nelle loro storie: più personaggi non-bianchi, gay, trans, più lotta agli stereotipi maschili – un vasto programma nel mondo dell’intrattenimento giovanile. In un recente videogioco sono arrivati a dipingere una criminale parafemminista uccidere Batman. L’incredibile sviluppo, lesivo non solo delle passioni dei fan ma propriamente del valore dell’IP (la proprietà intellettuale; i personaggi di film, fumetti e videogiochi questo sono, in termini legali ed economici) è stato letto come una dichiarazione di guerra del sentire comune, con l’esecuzione del Batmanno come chiaro emblema del patriarcato e della concezione del crimine come qualcosa da punire. Sorveglia e punire: non l’agenda portata avanti negli USA dai procuratori distrettuali eletti con finanziamenti di George Soros, nelle cui città, oramai zombificate, ora governa il caos sanguinario e il disordine più tossico.tesla cybertruck is just ps1 lara croft boobs pic.twitter.com/W6BXuGzMRq
— scene celebrity (@whackkat) May 12, 2021
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Arte
No al Jazz. Sì al Dark Jazz

In un mattino qualsiasi dello scorso anno scoprii l’esistenza della musica Dark Jazz, e mi piacque.
Intendiamoci: ritengo di per sé il jazz una musica incomprensibile, a tratti censurabile. Sono pronto già ora a scrivere un disegno di legge per impedire la nerditudine jazzistica qualora espressa in pubblico: avete presente, quei tizi che si mettono a tamburellare sillabando a parole ritmi indefinibili «da-pu-dapudada-puda-da-pu-da-pu», e non capisci se stanno mimando il piano, il sassofono, la chitarra, la batteria, il contrabbasso. A loro interessa solo fare «da-be-du-pu-dapudadeda-pudade-da-pu-da-pu-de», percuotendo qualsiasi superficie a portata, anche e soprattutto in assenza di musica di sottofondo.
A costoro non deve essere portato nessun rispetto, a costoro va usato il pugno di ferro di una legge con pene severissime per ogni «da-pu-dadepudada-depudade-dade-pude-da-pu-de-pu-dada» emesso in pubblico, e un pensiero andrebbe fatto anche per un divieto nelle case private.
I jazzomani sono un problema sociale che la Repubblica Italiana ha ignorato per troppo tempo. Sappiamo, anzi, che essi dilagavano anche sotto il fascismo, e uno degli untori della jazzomania italica fu il filosofo destroide Giulio Evola (1898-1974), che oggi non vogliam chiamare Julius, e ci chiediamo perché per tutti questi anni lo abbiano fatto gli altri.
Sostieni Renovatio 21
A questo punto un disclaimer, ché non salti fuori qualcuno che accusi di incoerenza: tanti anni fa partecipai, producendo videoproiezioni, ad uno dei grandi festival di Jazz siti in Italia, il cui direttore è l’amico compagno di giovanili scorribande eurasiatiche, in ispecie in Ucraina e Crimea, quando ancora era ucraina (ma le scritte NO NATO già v’erano). Proiettai immagini durante un omaggio a Piero Piccioni in un prestigiosissimo teatro del Nord; l’anno successivo invece lavorai alle proiezioni per un omaggio a Roman Polanski suonato dal polacco Marcin Wasilewski – è fu un concerto estivo stupendo, struggente, emozionante.
Ciò detto, basta col jazz. Basta soprattutto con i suoi appassionati e la loro aria di superiorità morale stile lettore di Repubblica in era berlusconiana.
Basta con quelli capaci di parlarti per ore di Carlo Parker, Duca Ellington, Miles Davis, Dizzy Gillespy – senza darti nemmeno il tempo di intervenire per protestare che di tutto l’esercito di geni afroamericani a te non te ne frega niente.
A costoro vorremmo poter ricordare l’immortale scena di Collateral (2004), dove al tizio saputo che racconta con boria flemmatica un retroscena della storia del Jazz, il brizzolato killer interpretato da Tom Cruise pianta una serie di pallottole in fronte.
Vabbè, così è un po’ esagerato. Però ebbasta. Eddai. No Jazz. No «da-pu-dabe-dedu-pude-dapudadeda-dapude-da-pu-da-pu-dadeda».
Purtuttavia, siamo pronti a riconoscere che va ammessa l’attenuante per chi il jazz lo suona: il musicista jazzo, va riconosciuto, sa suonare, anzi, ha di solito pure studiato, e non poco. Anzi a questo punto osanniamo anche il capolavoro cinematografico Whiplash (2024) per aver raccontato in modo magistrale i dolori che questi artisti devono affrontare.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
È quindi con estrema sorpresa che, quel giorno dello scorso anno, abbiamo ricevuto dall’algoritmo di YouTube (lo stesso che censura i video di Renovatio 21, pure quelli privati) il suggerimento di ascoltare questa misteriosa compilation di Dark Jazz.
Potete farlo anche voi. Noi ne siamo rimasti affascinati parecchio.
Sentite le atmosfere? Sì, sembrano antiche, ti pare di essere in un film noir del primo Novecento, o forse no – i noir hollywoodiani non mettevano il jazz – sei nella percezione del Noir che si aveva negli anni Novanta, come in un film di Davide Lynch, ma più definito, anche se sempre altamente inquietante, ambiguo, agrodolce. Il fantasma di Badalamenti, il compositore non il capo-mafia, aleggia su tutto.
O forse, si tratta solo di un riflesso presente, un riflesso di noi? Si tratta degli anni 2020, che guardano agli anni Novanta, che andavano indietro di mezzo secolo?
Non lo sappiam, ma ci gusta, e anche molto.
Abbiamo così compreso che si tratta di un genere, anche se non ancora catalogato ufficialmente. Altri nomi possono essere usati per la categoria, come «Doom Jazz», «Jazz Noir», persino «Horror Jazz»…
Aiuta Renovatio 21
Per orientarsi, bisogna compulsare i forum, dove altri come me hanno notato l’esistenza del genere, e cercano suggerimenti.
Consigliano, ad esempio, il Zombies Never Die Blues dei Bohren & der Club of Gore, un gruppo tedesco della Ruhr fondato nel 1988 che, partito dal Metal e dall’Hardcore, è considerato il capostipite del genere.
Salta fuori in gruppo che si chiama Free Nelson Mandoomjazz.
Sostieni Renovatio 21
Da segnalare assolutamente il Lovecraft Sextet, con la loro musica dedicata all’«orrore cosmico» di cui scriveva il solitario autore di Providence che inventò Chtulhu.
Kilimanjaro Dark Jazz Ensamble, Non Violent Communication, Asunta e Hal Willner sono gli altri grandi nomi citati per il genere. E ancora, i russi Povarovo, i neoeboraceni Tartar Lamb, i tedeschi Radare e Taumel, gli italiani Senketsu No Night Club, Macelleria Mobile di Mezzanotte e Detour Doom Project, i progetti che raccolgono australiani, italiani e messicani come Last Call at Nightowls.
Insomma tanta roba da ascoltare, specie quando si sta facendo dell’altro.
C’è sempre tempo per ricredersi su una cosa. Tuttavia, sul jazz in generale, resto sulle mie posizioni: subito una legge per proibire il jazzomanismo, ma con un emendamento per salvare il Dark Jazzo.
No?
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Pensiero2 settimane fa
Pensiero2 settimane faLa giovenca rossa dell’anticristo è arrivata a Gerusalemme
-



 Cervello1 settimana fa
Cervello1 settimana fa«La proteina spike è un’arma biologica contro il cervello». Il COVID come guerra alla mente umana, riprogrammata in «modalità zombie»
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori della 15ª settimana 2024
-



 Vaccini2 settimane fa
Vaccini2 settimane faVaccini contro l’influenza aviaria «pronti per la produzione di massa». Un altro virus fuggito da un laboratorio Gain of Function?
-



 Salute6 giorni fa
Salute6 giorni faI malori della 16ª settimana 2024
-



 Pensiero6 giorni fa
Pensiero6 giorni faForeign Fighter USA dal fronte ucraino trovato armato in Piazza San Pietro. Perché?
-



 Animali2 settimane fa
Animali2 settimane fa«Cicala-geddon»: in arrivo trilioni di cicale zombie ipersessuali e forse «trans» infettate da funghi-malattie veneree
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane faSinodo 2024, grandi manovre in favore dell’ordinazione delle donne



















