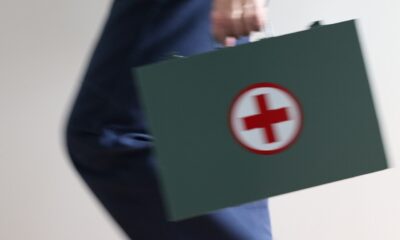Pensiero
Stato, popolazione e industria nell’Italia del 2025: intervista al professor Pagliaro

Renovatio 21 torna ad intervistare il professor Mario Pagliaro per una panoramica della politica energetica di questo 2025. «Lo Stato tornerà protagonista dell’economia» ci aveva detto quasi 3 anni fa. Commentando poi la necessità del ritorno dell’IRI, lo scorso marzo aveva aggiunto: «il cambiamento, è già iniziato».
Sono passati quasi 6 mesi, e lo Stato – che aveva già riacquisito il controllo di Autostrade, e quello della ex SIP (poi TIM) – ha comperato la divisione veicoli militari Iveco dagli eredi Agnelli, e si appresta a nazionalizzare la ex Ilva. Dirigente di ricerca del CNR, fra i pionieri dello sviluppo dell’energia solare quando, alla metà del primo decennio dei 2000, non ci credeva nessuno, il professor Pagliaro ha dato a Renovatio 21 numerose interviste sui temi dell’energia, dell’industria e anche della sua Sicilia.
Sono appena stati varati pesanti dazi sulle esportazioni negli Stati Uniti. Mese dopo mese, la produzione industriale italiana continua a calare da oltre due anni. Con i dazi imposti dagli USA sulle importazioni, e il costo dell’energia radicalmente aumentato a causa della fine delle importazioni in Europa di gas e petrolio dalla Russia, la Germania vede venir meno l’interesse a utilizzare l’euro al posto del marco. Convinti che l’Italia sia attesa nei prossimi mesi sia attesa da profondi cambiamenti, siamo dunque tornati a sentire l’accademico europeo.
Le risposte del professor Pagliaro hanno al solito un carattere di antiveggenza che tornerà utile a tutti i lettori della nostra testata.
Professor Pagliaro, lei aveva previsto un ritorno dello Stato nell’economia quando, nella cosiddetta Seconda Repubblica, è stata solo una gara fra i cosiddetti «Centrodestra» e «Centrosinistra» a vendere e liquidare il più rapidamente possibile tutte le aziende e le banche pubbliche.
La verità in economia come in politica è ciò che è ineludibile, e non ciò che è dimostrabile. L’Italia negli oltre 20 anni dell’euro è stata costretta a deflazionare i salari per massimizzare le esportazioni, e a comprimere in ogni modo la domanda interna per minimizzare le importazioni, in modo da realizzare ogni anno un forte avanzo primario per avere i soldi con cui comprare risorse energetiche e materie prime di cui manca.
Ci sono anche altre ragioni, ma restando ai numeri è sufficiente osservare come fra il 1991 e il 2024, l’Italia abbia registrato un forte avanzo primario quasi ogni ogni anno: con le sole eccezioni del 2009 successivo alla grande crisi finanziaria iniziata nel settembre 2008, e del quadriennio 2020-2023 dovuto ai vari lockdown e al forte incremento della spesa pubblica assistenziale a sostegno di famiglie e imprese. Questo però rende l’Italia un Paese dove nessun giovane vorrebbe aprire un’azienda, men che mai un’azienda manifatturiera.
Bastano due numeri per comprenderlo: per pagare a un lavoratore uno stipendio di 3 mila euro al mese (36 mila euro l’anno) un’azienda deve spenderne ben oltre il doppio a causa dell’elevata pressione fiscale e contributiva sul lavoro. In queste condizioni, il Paese è rapidamente deindustrializzato.
Così, quando si è trattato di scegliere se seguire l’ideologia del liberismo economico egemone durante il ventennio dell’euro, oppure salvare alcune imprese strategiche, e anche una grande banca, lo Stato è tornato ad investire direttamente acquisendone il controllo.
La questione si ripropone adesso con la produzione di acciaio dal minerale ferroso: se l’Italia non vorrà perderla dovrà ricostituire l’Ilva nazionalizzando gli impianti, che peraltro fu proprio lo Stato a costruire.
Sostieni Renovatio 21
Più volte Renovatio 21 ha registrato le sue predizioni sul ruolo che giocherà nella rinascita italiana la grande diaspora degli italiani all’estero. Quanti sono gli italiani che hanno lasciato l’Italia dal 2002, anno dell’introduzione dell’euro?
I numeri sono disvelatori. La nuova diaspora italiana è fatta di molti milioni di persone: molti di più di quelli stimati ufficialmente in base alle cancellazioni anagrafiche nei Comuni. Chi si trasferisce all’estero sarebbe infatti obbligato a iscriversi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), venendo cancellato dalle anagrafi comunali, ma l’obbligo viene largamente disatteso.
Ad esempio, secondo i dati ISTAT, tra il 2002 e il 2021 gli italiani trasferiritisi all’estero sarebbero circa 1,4 milioni. Secondo il CNEL, le cifre reali sono tre volte più grandi di quelle ufficiali. Inoltre, la nuova emigrazione italiana è completamente diversa da quella del passato: le partenze riguardano primariamente le regioni più ricche. Ad andarsene sono persone molto istruite, cioè essenzialmente tecnici altamente specializzati e giovani laureati, che nel 2022 erano la metà (48%) degli emigrati con età compresa fra 18 e 34 anni. Su 10 giovani espatriati, 5 partono dal Nord Italia e 3 dal Mezzogiorno.
Chi resta, inoltre, non fa più figli: con sole 370mila nascite nel 2024, la natalità in Italia è ai minimi storici dall’Unità. Emigrano, e non tornano, i giovani italiani qualificati non solo perché i salari all’estero sono molto più alti. Ma soprattutto perché le opportunità di lavoro sono migliori: è migliore, di più elevata qualità, la tipologia di lavoro qualificato offerto all’estero.
I giovani italiani emigrano così nei Paesi europei più sviluppati e negli Stati Uniti. Di fatto, oggi, anche nei Paesi arabi del Golfo Persico per le opportunità di lavoro in ricerca, alta formazione accademica e sanità.
E in che modo questi giovani che non vogliono tornare potrebbero contribuire, concretamente, alla rinascita dell’Italia?
Nel caso auspicabile, e a nostro avviso ineludibile, del ritorno allo sviluppo economico e industriale guidato dallo Stato, l’Italia vedrebbe un diffuso ricambio di tutte le sue classi dirigenti. A guidare tanto le aziende pubbliche che molte amministrazioni dello Stato sarebbero proprio molti ex giovani italiani emigrati dal 2002, poi divenuti grandi manager, imprenditori, docenti universitari, ricercatori, informatici, finanzieri, esperti di comunicazione, etc.
C’è una grande differenza infatti fra l’emigrazione italiana e quella di altri popoli. Gli italiani mantengono un profondo legame con il loro Paese, che dura persino attraverso le generazioni, come mostra ad esempio il caso della grande comunità di origine italiana negli Stati Uniti o in Canada.
In breve, molti dei giovani ed ex giovani italiani che hanno lasciato l’Italia a partire dal 2002 tornerebbero in Italia per amore del loro Paese, in un contesto completamente nuovo in cui al posto della deflazione salariale e della deindustrializzazione, torneranno tanto una forte crescita dei salari che della domanda interna accompagnati e sostenuti da un grande piano di reindustrializzazione del Paese.
In questo contesto, aiuterà assumere una visione di lungo periodo, che guardi ai tratti essenziali dello sviluppo italiano, tanto quello dovuto alle Partecipazioni statali, che alla capacità imprenditoriale degli italiani.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Assumendo questa prospettiva, qual’è appunto il tratto essenziale di questa capacità imprenditoriale?
Il tratto essenziale dell’imprenditorialità italiana è la sua capacità di creare sviluppo «dappertutto e rasoterra» per usare le parole di chi l’ha descritta in oltre 60 anni di studio sociale ed economico come il fondatore del Censis, Giuseppe De Rita. Nel 2006, lo invitai al CNR a Palermo per parlare proprio della vicenda delle Partecipazioni statali, in cui lui era stato coinvolto direttamente dai vertici della Svimez dove lavorava.
Il professor De Rita in Sicilia spiegò chiaramente come tutta la programmazione italiana, dal Piano Vanoni al Piano Giolitti fra il ’54 e il ’64, sia stata opera dell’Ufficio studi IRI e di loro giovani economisti e sociologi in servizio allo Svimez. Pur avendo preso parte direttamente alla pianificazione industriale ed economica, sarà proprio De Rita con il Censis a raccontare lo sviluppo diffuso delle piccole imprese italiane a partire dai primi anni Settanta.
Uno sviluppo che il grande sociologo ha descritto come esplosione della soggettività italiana: con la nascita dell’economia sommersa con la banca pubblica locale che ne finanziava lo sviluppo. Fino alla nascita dei distretti industriali. Nel censimento del 1981 le imprese industriali italiane erano passate ad oltre 1 milione dalle 480mila di dieci anni prima.
Con la nascita di oltre 20 distretti industriali che avevano diffuso l’industria al di fuori del «triangolo industriale» Torino-Genova-Milano. Giustamente, De Rita fa notare come in 10 anni gli italiani avessero creato lo stock di industrie create nei 100 anni precedenti, in pratica dall’Unità d’Itala.
Aiuta Renovatio 21
Esiste ancora, fra i giovani italiani, questa capacità di fare impresa?
Certo che esiste. Solo che non essendo più conveniente economicamente fare impresa in Italia, vanno a farla all’estero. Guardi allo sviluppo delle aziende delle cosiddette criptovalute, e vi scorgerà fin dagli albori informatici, manager e imprenditori italiani. Italiano è uno dei maggiori manager del noto colosso del commercio via Internet. Ma la lista è lunghissima: giovani italiani hanno creato e portato al successo in Europa, in Nordamerica, Medio Oriente e persino negli ex Paesi comunisti imprese di ogni natura.
La capacità di intraprendere è tratto essenziale dell’italianità: come tale, non può essere perduto. Non è possibile prevedere il futuro: ma l’Italia, a mio avviso, trarrà grandi benefici dalla ricomposizione dell’ordine economico e politico in corso in Europa e nel mondo.
Sostenere questa possibile evoluzione richiede anche la capacità di conoscere meglio, e più da vicino, molti aspetti della storia economica e sociale dell’Italia. Come dice il mio amico Giuseppe De Rita, «economia e cultura in Italia si ignorano». Per risolvere questa storica separazione occorre che un supplemento di impegno anche da parte di chi è impegnato nella formazione e nella ricerca.
Al quale spero possano contribuire anche i nostri periodici dialoghi.
Grazie professore. Alla prossima.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Andrea Donato via Flickr pubblicata su licenza CC BY-ND 2.0
Pensiero
Il Giappone di fronte alla legalizzazione della prostituzione

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Sostieni Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Pensiero
Consacrazioni FSSPX, non «chi», ma «quanti»: il sogno di un fedele

Per il piccolo mondo antico tradizionista è di certo la notizia più clamorosa, ancorché attesa, che si possa immaginare: le nuove consacrazioni della Fraternità San Pio X sono la comunicazione che tanti – nel mondo, milioni – aspettavano, e da decadi.
Chi scrive è un fedele FSSPX, per cui addentro, anche felicemente, a questa vorticosa, irrinunciabile hype ecclesiastica. Nel giro lefebvrista ovviamente non si parla d’altro, e si è slatentizzata definitivamente la pratica del toto-vescovi, che veniva esercitata sottovoce negli scorsi anni, mentre ora è in ogni chiacchiera fuori dalle cappelle, ogni telefonata, e non voglio pensare cosa siano ora certi gruppi Whatsapp e Telegram, applicazioni da cui cerco di tenermi più alla larga possibile.
Sì, il toto-consacrazioni impazza, al punto che alla pratica possiamo dare pure il nome in lingua inglese («l’inglese è il greco moderno») di bishopping. Chiunque ora si dà alle gioie del bishopping, con bishoppatori di tutte le età, bishoppano le vecchie guardie che hanno conosciuto monsignor Lefebvre come i neoconvertiti, i giovani, quelli di passaggio – che, per fortuna non mancano mai: una realtà senza «portoghesi» è una realtà morta.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Ebbene, con discrezione, senza esagerare, mi ci sono messo anche io. Ho sentito varie voci, tra fraternitologi e persone con ampie cognizioni della FSSPX, per verificare quello che penso, farmi un’idea, tracciare un’ipotesi più chiara. Ne sono uscito solo con una certezza: ho solo opinioni, congetture – e sogni. E forse vale la pena, per una volta, di concentrarsi su questi.
Con ordine: il primo fraternitologo che ho sentito ha, come tutti (come me), alzato le mani al cielo – non c’è modo di sapere nulla. Mi dice: dicono che non faranno un africano, anche se forse sarebbe il caso, e rimarrano in Europa. L’età sarà bassa, perché per fare il vescovo della Fraternità ci vuole un fisico bestiale, per resistere agli urti della chiesa moderna, cresimando bambini a quattro angoli del pianeta, dall’Alaska al Sudafrica, da Tokyo all’Amazzonia. Ne faranno, secondo lui, tre: cifra conservativa. Di lui mi fido sempre, ma qui?
E chi saranno i futuri prelati? Ecco che si fa qualche nome, questo qui che fa questo, quest’altro che fa quello.
Sento un’altra voce con profonda conoscenza della materia, che con profonda saggezza mi conferma che non c’è modo di sapere: lo sa solo chi ha deciso, cioè chi le nomine le ha fatte, e chi verrà consacrato (forse). Lui dice: non ne faranno più di quattro. Immagino che sia perché quattro è il numero di vescovi ordinati eroicamente nel 1988 dal fondatore. Ma può esserci certezza qui? No. Nemmeno della provenienza: ci sarà un francese, un americano… probabile, sì, ma in ultima analisi cosa ne sappiamo? Nessuna certezza!
Nel frattempo è arrivata Roma. «Proseguono i contatti tra la Fraternità San Pio X e la Santa Sede, la volontà è quella di evitare strappi o soluzioni unilaterali rispetto alle problematiche emerse» ha detto il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni. Ad occhio non sanno nulla neanche loro, anzi sanno meno di noi: con evidenza non hanno idea di cosa fare, mentre noi sì, pregare e tripudiare, baciare gli anelli, ricevere e tramandare, persistere, esistere – combattere sempre, perché militia est vita hominis super terram (Gb 7,1)
Non sappiamo nemmeno se la lettera ricevuta dal Vaticano, quella che da quel che dice il superiore generale don Davide Pagliarani avrebbe cagionato la decisione a procedere autonomamente con le consacrazioni, sarà pubblicata. Qualcuno bisbiglia: non è che la letterina sia venuta fuori di punto in bianco, stile bigliettini a scelta binaria con crocetta che circolano in classe a fine-elementari-inizio-medie: «Ti vuoi mettere con me? □ SI □ NO»
Immaginiamo il livello di difficoltà, con la Curia che può dire: «no… anzi sì, ma tra un po’… anzi no, anzi uno… uno nel 2028… anzi no… anzi sì, uno nel 2030, scelto da noi… anzi uno scelto da noi, da fuori della Fraternità». Roma locuta, causa infinita.
E cioè, tutto quello che non è stato fatto per i comunisti cinesi. Perché, rammentiamolo pure noi, la situazione è paradossalmente la medesima della Chiesa patriottica, il fac-simile della Chiesa Cattolica creato dal Partito Comunista Cinese, con cui Roma ha pensato bene di fare accordi – i famigerati, catastrofici, accordi sino-vaticani – ottenendone per premio la repressione più tremenda dalla chiesa sotterranea, la distruzione di chiese, il rapimento di seminaristi e sacerdoti, torture ai religiosi, insomma una tragedia immane, bagnata da ondate continue di sangue di martire.
Il Partito Comunista Cinese ha nominato e consacrato, tra i tanti degli ultimi mesi di scandalo, il vescovo di Shanghai – non solo quelli di province impronunciabili dell’entroterra sinico, ma il vertice della diocesi della seconda città più importante del Dragone. E cosa ha fatto il Sacro Palazzo? Nulla. Spallucce. Pazienza.
Sostieni Renovatio 21
Ma scusate, non ci sarebbe la questione della… scomunica? Massì, la scomunica latae sententiae per chi ordina vescovi illecitamente, ma validamente: un vescovo ordinato da un vescovo è un vescovo, anche se satanista. Latae sententiae significa che la pena canonica arriva senza giudizi, esce subito quando l’azione è compiuta. Cioè, la scomunica va considerata all’atto stesso: quindi anche i prelati comunisti cinesi, pur ratificati a posteriori, sono da considerarsi scomunicati?
Per il diritto canonico alla pena latae sententiae si contrappone la pena ferendae sententiae: in questo caso la scomunica c’è solo nel momento in cui viene pubblicamente dichiarata dal Sacro Palazzo, come nel recente caso di mons. Viganò.
E quindi, alla fine, tutto questo si risolve in una grande questione di PR? Il problema, per alcuni, non è tanto quello di incorrere in una scomunica automatica, ma quello che lo dica la Sala Stampa vaticana. Non abbiamo solo l’esempio cinese: con le ordinazioni di monsignor Williamson non pare ci sia stata alcuna comunicazione mediatica di scomunica – creiamo un ulteriore neologismo: «scomunicazione» – da parte di Roma. La scomunica c’è comunque, ma bisogna evitare – dicono certuni – la scomunicazione.
A questo punto del labirinto capisco che devo mollare il principio di realtà: non c’è modo di sapere niente di niente nemmeno qui. E allora, se non posso contare sui ragionamenti, posso solo parlare di quello che sogno. Io non sogno «chi», ma «quanti».
Sogno che la Fraternità non faccia uno, due, tre, quattro vescovi: sogno che ne facciano dieci, venti. Sogno che facciano tanti americani, un africano, un italiano, svizzeri, tedeschi, spagnoli, brasiliani, un (il…) giapponese, un polacco, e quanti francesi vogliono. Sogno che divengano vescovi anche quei tanti bravi preti ordinati da monsignor Lefebvre che in Italia, in Francia, in Germania hanno lavorato per la Fraternità rendendola questo monumento invincibile – una nomina «onoraria», se vogliamo, impossibile, mi dicono, ma vi sto parlando di sogni, non della realtà.
«Sarebbe come di quegli eserciti africani, in cui ci sono più generali che soldati» mi ha detto un santo sacerdote della FSSPX quando gli ho esternato, ancora un anno fa, la mia speranza di vedere consacrazioni a doppia cifra. Ha sicuramente ragione lui, tuttavia lo stesso sogno che faccio io mi è stato confessato, sulle scale di pietra di un millenario oratorio della Fraternità da un fedele pater familias, ad alta voce in lingua veneta: «i gà da farghene diese o venti – minimo!».
Si era subito dopo l’incidente che ferì monsignor Tissier portandolo poi all’agonia e alla morte. «’Sa ‘speteli» diceva il fedele, «cosa aspettano». Il popolo la pensa così. Vox populi vox Dei: bisogna ammettere che di fedeli spaventati dalle scomuniche non ne conosco nemmeno uno. Anzi c’è chi teorizza pure, e non senza saggezza: se non ci fosse stato Ratzinger a togliere le scomuniche nel 2009 il problema non si sarebbe mai posto.
Aiuta Renovatio 21
La realtà sarà certamente differente dai sogni dei fedeli. Mi sono riservato queste righe solo per significare per sempre che questi sogni esistono. E parlano di cose concretissime.
Perché il sogno vero è quello di vedere la vera Chiesa cattolica convincersi di essere non una minoranza numerica, ma una maggioranza spirituale – l’unica vera forza che deve riprendere Roma e il mondo, e da lì tornare ad irradiare all’umanità ferita il verbo del Dio della Vita, consegnando alle future generazioni quello che abbiamo, forse per poco, fatto in tempo a ricevere prima dell’estinzione, del messaggio e della vita umana stessa.
Sogno che la capsula del tempo che contiene la vera Chiesa di Cristo si apra, e ricostruisca su questo panorama di rovine romane che è sotto i nostri occhi e dentro le nostre anime.
Sì, sogno un esercito di vescovi per cui combattere, e se necessario morire, al fine di riconquistare la Terra a Cristo.
Non fatemene una colpa. E non pensate che sia solo: molti sono come me. E molti verranno dopo, lo sappiamo perché li stiamo allevando.
E quindi: lasciateci sognare. Lasciateci seminare, nei sogni e nelle parole, nello spirito e nella carne, per la Crociata salvifica di cui abbisogna il pianeta – e per i vescovi che essa merita.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine da FSSPX.News
Essere genitori
Bambini nella neve, bambini nel bosco: pedolatria olimpica e pedofobia di sistema

Sostieni Renovatio 21
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Oligarcato2 settimane fa
Oligarcato2 settimane faEpstein aveva proposto a JPMorgan un piano per ottenere «più soldi per i vaccini» da Bill Gates
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane faLa profezia di padre Malachi Martin avvertì nel 1990: «potremmo trovarci finalmente di fronte a un falso papa»
-



 Cina4 giorni fa
Cina4 giorni faEnigmi femminili cinesi alle Olimpiadi
-



 Vaccini2 settimane fa
Vaccini2 settimane faVaccini e COVID, l’architetto chiave della lista contro la «disinformazione» si dimette dopo che l’uscita dei documenti Epstein
-



 Spirito1 settimana fa
Spirito1 settimana faL’élite ostracizza chi si non si converte all’ideologia infernale del globalismo: omelia di mons. Viganò nel Mercoledì delle Ceneri
-



 Spirito1 settimana fa
Spirito1 settimana faMons. Viganò sul set della «Resurrezione» del cattolico tradizionalista Mel Gibson
-



 Predazione degli organi6 giorni fa
Predazione degli organi6 giorni faUn cuore «bruciato», due vite spezzate dalla predazione degli organi
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori della 6ª settimana 2026