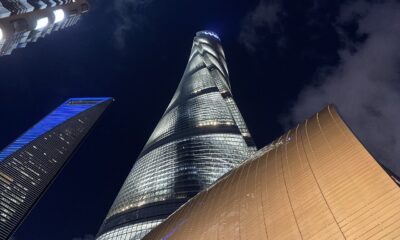Pensiero
Memorie dal sottosuolo ebraico

Anche quest’anno è giunto il «giorno della Memoria». Si chiama così, senza che sia specificato di cosa: gli altri dì dell’anno, forse sono senza memoria, pare il messaggio degli organizzatori. Oppure che questa è una memoria più importante delle altre?
È una memoria che non si può lavar via, che va fissata in mondo indelebile: le altre memorie sono RAM, mentre quella dell’«olocausto» – altra espressione generica assai, che sposta via tanti altri significati, compresi quelli della religione cristiana – è decisamente da hard disk.
Dal mio disco rigido quindi, quest’anno voglio estrarre un po’ di memorie assortite sull’argomento. Mi sblocco un po’ di ricordi personalissimi, così, per cercare di stare in linea, per una volta, con una giornata mondiale.
Sostieni Renovatio 21
Io ho memoria, innanzitutto, di una cosa accaduta ieri l’altro. Mio figlio, 8 anni, ha sentito in una conversazione l’espressione «campo di concentramento» e, pur non sapendo esattamente cosa volesse dire, mi ha chiesto di «Teresen. Teresin…».
«Theresienstadt...?» gli ho chiesto sbalordito.
«Sì, quello».
«E dove lo hai sentito?»
«A scuola…»
Scopro così che, dopo il lavaggio di cervello sul caso Cecchettin, qualcuno in classe ha parlato ai bambini dello sterminio degli ebrei, cosa del quale, almeno lui, ha potuto capire fino ad un certo punto. Come sappiamo, non è importante: quello che conta è che il discorso pubblico venga sfogato, e che qualche parola chiava («Theresien…» «Auschw…») entri nei giovani cervelli, e anche solo qualche sillaba va bene.
Scopro così che l’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan ha inviato una lettera aperta alle scuole del Veneto:
«Vi invito, anche quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, come comunità educante del nostro Veneto, a ricordare degnamente questa data simbolo della persecuzione dell’odio nei confronti degli ebrei. Purtroppo la battaglia all’antisemitismo non è ancora compiutamente vinta perché il seme dell’antisemitismo continua a riemergere con molte facce e strumenti diversi. È una battaglia che soprattutto nella scuola dobbiamo affrontare trovando la più ampia diffusione tra le nuove generazioni così da costruire gli anticorpi contro l’odio antisemita. L’odio, nei confronti del popolo ebraico e contro lo Stato di Israele, è un dramma che ancora oggi si perpetra nel mondo».
Sono parole che, scrive il messaggio, l’assessore aveva usato anche l’anno scorso, ma che ha copincollato anche quest’anno perché «purtroppo, ancora più attuale dopo i fatti del 7 ottobre 2023 da parte del terrorismo islamico con l’obiettivo di colpire lo Stato di Israele».
«Si assiste ad un dibattito pubblico acceso e polarizzante ed è quanto mai necessaria una riflessione in ordine ai pericoli di un rinnovato odio nei confronti degli ebrei, che si è caratterizzato recentemente per episodi di estrema violenza anche nel nostro territorio, come accaduto a Vicenza in occasione di un recente evento internazionale ove partecipavano degli espositori israeliani. Episodio esecrabile che ha visto la giusta condanna da parte di tutte le forze politiche e che non deve ripetersi grazie all’apporto culturale garantito dalle nostre scuole».
«Il 27 gennaio è ancora più importante difendere la democrazia e la libertà».
La democrazia e la libertà coincidono con lo Stato di Israele? Non è tanto questo, che colpisce il quivis de populo. Ma scusate, la Donazza non è quella che la sinistra accusava di revisionismo? Non è quella che avrebbe cantato «faccetta nera» per radio a La Zanzara? Insomma quella considerata di destra, tanto di destra?
A fine anni Ottanta, la Donazzana fu presidente provinciale vicentina del Fronte della Gioventù, il movimento giovanile del MSI. Qui si sblocca un ricordo dell’era almirantiana: com’è, che ad un certo punto, i missini – tra i quali nel 1979 si candidò anche il marito della senatrice sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre – presero a difendere lo Stato Ebraico? Sì, è successo. Si disse: è perché l’URSS difende i palestinesi (certo: dopo essere stato il primo Paese a riconoscere Israele, e a tenersi in pancia e fuori caterve di ebrei russi). Anzi no: è perché Israele è uno stato militarista, uno stato etnico – il motivo per cui piace pure al Battaglione Azov, che lo dice ufficialmente (e non scherziamo).
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Sarà quello? Mboh. Intanto io sblocco quella memoria, così per capire come le «lettere aperte» istituzionali dalla fiamma arrivano fino alla mente di mio figlio.
Quello degli ebrei a scuola è un tema ciclico e risalente. Dall’hard disco personale ripesco un giorno di più di un quarto di secolo fa, un sabato pomeriggio, sono da solo in un bel bar dentro una rara casetta liberty, di solito andavo lì alla sera per gli amici e le ragazze ma il pomeriggio, quando non c’è nessuno, c’è grande pace, e lo spritz lo pagherò 1000 lire (fate voi i conti – comunque era un posto costoso, nel baretto successivo della via il prezzo era 500 lire).
I tizi del locale sono di sinistra: ecco che sul bancone spunta Repubblica, giornale che leggo con avidità. Mi colpisce un grande editoriale, un articolone, un’articolessa, si intitola «Io professore fallito». Mi fiondo a leggerlo, perché fiuto subito la voglia del quotidiano di vellicare questa parte consistente del suo pubblico, gli insegnanti di scuola, medie, elementari, superiori, università, che vuolesi ceto medio riflessivo ma è soprattutto casta statale sempre in cerca di qualcuno che riconosca quanto bravi, intelligenti sono – e soprattutto dire quanto, ancorché talvolta tristi ed incompresi, quanto sono necessari al Paese.
Il pezzo è tutto un racconto intimo di dettagli personali anche poco significanti (tipo l’articolo che state leggendo). L’autore racconta di aver portato i suoi studenti a vedere un film in un multisale di una città del Lazio. Si tratta di Train de vie, una pellicola sull’Olocausto però con allegra musichetta balcanica alla Bregovic (quella che, anni dopo, Elio e le Storie Tese dissero solennemente che «ci ha rotto i…»): «un film straordinario, geniale, capace di ribaltare da un’inquadratura all’altra ogni ruolo e di guardare alla tragedia della Shoa [sic] con uno sguardo obliquo, ironico, poetico, in modo diverso (perché diverso è lo stile) ma analogo (per una vicinanza poetica tra i due autori) a La vita è bella di Benigni» scrive il professore nella mirabile infilata iniziale.
«Io non l’avevo mai visto prima e mi sono emozionato, gli alunni in gran parte si sono annoiati. A un certo punto mi sono dovuto alzare per andare ad azzittire un gruppetto di ragazzi che dalle prime file continuava ad alzare grida di “Heil Hitler!”» racconta con amarezza.
«Nell’intervallo sono andato al bar, fuori dal cinema, a prendermi un caffè. Vicino a me c’era il proprietario del cinema. Io l’ho riconosciuto, lui no. È un uomo sulla sessantina, uno di quegli ex malandrini talmente narcisisti da non riuscire a memorizzare un solo volto. Ne ho conosciuti a migliaia. Sono talmente concentrati sulla loro vita che tutto il resto non solo lo ignorano, ma faticano a considerarne l’esistenza. Sono perfino comici, certe volte, perché a un occhio inesperto tanta pienezza di sé, e senso dell’esclusione, può confondersi facilmente con un rincoglionimento da macchietta».
Diciamo di non sapere se, dopo la pubblicazione, sia partita una denuncia per diffamazione: ci starebbe. Ma si va avanti:
«Il barista gli ha chiesto se nel cinema ci fossero i ragazzi della scuola, e lui ha riposto di sì con la testa, appoggiando la tazzina del caffè alle labbra protese. Poi l’altro si è informato sul film che stavano proiettando. Allora lui ha mandato giù il caffè inghiottendo sonoramente, ha fatto schioccare la lingua, ha infilato una mano in tasca, ne ha estratto un mazzo di biglietti di vario taglio, ha sfilato con la punta di indice e pollice una banconota da mille, l’ha allungata alla cassa e infine ha risposto: – Un treno per vivere, ‘n’antra stronzata sull’ebbrei».
Ecco: «‘n’antra stronzata sull’ebbrei». Scritto proprio così: «sull’ebbrei». La frase romanesca mi è rimasta impressa nella memoria per anni, e non manca di farmi ridere ancor’oggi.
Ricercando questo mirabile testo, ho appreso che l’autore non era solo un professore, ma anche uno scrittore – specie nota in Italia, i docenti di scuola pubblica che gliela fanno a farsi fare il giro in giostra con il grande editore, e conseguentemente con qualche saletta di libreria o circolo Arci riempita di loro simili e tesserati PCI-PDS-DS-PD che per una sera si fanno convincere ad uscire di casa rinunziando al film su Rete 4. Si chiama Sandro Onofri, purtroppo sarebbe morto poco dopo la pubblicazione dell’articolo per cancro al polmone.
Lo scrittore e poeta e insegnante, ci chiediamo, come si sarebbe sentito quando, sugli stessi canali della grande sinistra e dell’establishment che ospitavano il suo sdegno per la mancanza di devozione olocaustica, anni dopo sarebbero apparsi peana al battaglione Azov? Quando la sinistra mondiale e il suo padronato borghese slatentizzato avrebbero fischiettato davanti a svastiche e lettere runiche, e anche a certi video recenti di supposte persecuzioni degli ebrei in Est Europa?
Davanti a chi gli avrebbe mostrato l’orrore nazista vivo e vegeto, e armato e finanziato dal contribuente italiano, avrebbe detto: «‘n’antra stronzata su Hitleh»…?
Aiuta Renovatio 21
Sblocchiamo un ricordo più recente. Il lettore deve sapere che mesi fa, molto prima dell’efferata strage di Hamas del 7 ottobre, Renovatio 21 aveva in canna un editoriale che parlava della Finestra di Overton che si stava aprendo riguardo l’antisemitismo. Il pezzo non fu prodotto e pubblicato, e mal ce ne incolse: ci avevamo, come sempre, ragionissima, e poco dopo avremmo visto l’odio per gli ebrei divenire mostruosamente mainstream con il cortocircuito attuale, dove in USA università e giovani della Generazione Z (più o meno goscisti, ma tutti, comunque, «fluidi», woke e nichilisti) arrivano a giustificare e persino celebrare i massacri contro gli ebrei (e ad esaltare le epistole del Bin Laden).
L’articolo che volevamo scrivere partiva dalle sparate del rapper Kanye West, che di colpo aveva cominciato a fare discorsi sugli ebrei piuttosto puntuti. Intervistato da Tucker Carlson, l’uomo – che è bipolare e miliardario, e popolarissimo – si era contenuto.
Poi, presentatosi in Texas da Alex Jones vestito tipo lo «storpio» di Pulp Fiction (una maschera nera che gli copriva il viso che forse veniva dalle sue frequentazioni con Balenciaga, marchio con cui ha collaborato molto), aveva spalancato tutto: lodi a Hitler, responsabile anche dell’invenzione dei microfoni, e attacchi diretti, nome e cognome, a Ari Emanuel, figlio di un terrorista sionista dell’Irgun e uomo più potente di Hollywood (e della TV, e della UFC, e chissà di cos’altro), fratello del capo di Gabinetto di Obama Rahm Emanuel (ora controverso ambasciatore in Giappone) e pure di Ezekiel Emanuel, medico e ultravaccinista della Bioetica di governo che va oltre l’eutanasia per chiedere direttamente la rinuncia alle cure per le persone oltre i 75 anni.
Anyone remember this? ????
Ye on Infowars with Alex Jones talking about Netanyahu.#Netanyahu #InfoWars #AlexJones #KanyeWest #Ye pic.twitter.com/LqhPwHVVYX
— ????Sno™️???? (@vrotocol) January 20, 2024
L’intervista del Jones con questo tizio mascherato era a dir poco incredibile: i discorsi sugli ebrei che faceva Kanye, che per qualche ragione ora vuole contrarre il suo nome in «Ye» – erano semplicemente inauditi in pubblico.
Capiamo anche l’imbarazzo del caso: difficile dire che si tratta del peccato onnipresente della società americana, quel suprematismo bianco che ci devono convincere essere legato al voto a Trump, perché il Kanye è nero.
E quindi: le critiche ferali sui potentati ebraici stavano diventando mainstream…? Certi discorsi, erano relegati all’underground dei lunatici.
Sostieni Renovatio 21
Un attimo, mi si sta bloccando un altro ricordo: sono a Nagasaki, la città più bella del mondo, tanti anni fa. Vicino alla stazione dei treni, tra la baia e i monti verdi, dopo un grande ballatoio che ti fa camminare sopra le strade, c’è un imperdibile negozio di libri usati. Il mio povero giapponese non mi consente la lettura di testi in presenza di troppi ideogrammi kanji, ma è uno spasso vero per il bibliofilo ammirare l’arte libraria nipponica: la tipografia, la consistenza della carta, il design delle copertine… anni dopo, alla Fiera di Francoforte, mi sarei fatto amico produttori di libri locali solo per sentire la passione con cui descrivono questo lavoro.
Tra i libri che sfoglio nella città del mio pellegrinaggio atomico, uno attira la mia attenzione: si chiama «Zionist Underground Conspiracy», o qualcosa del genere, ma non credo che parli davvero di complotti sionisti del sottosuolo: forse è un libro che parla di jazz, o di avanguardia letteraria, non lo ricordo, non lo so, perché, da mòna, lo sfogliai e non lo comprai.
Epperò è vero che c’è da chiedersi come i giapponesi vivano ‘sto «Giorno della Memoria». Messi giapponesi partecipavano alle «conferenze» razziali nella Germania nazista, dove cercavano di convincere tutti che i cinesi sono gli ebrei d’Oriente: ne parlava anche molto scandalizzato, Julius Evola nei suoi racconti di quegli eventi.
Ecco che scatta la voglia di rammentare il Fugukeikaku, l’«operazione fugu»: a forza di sentire i tedeschi lamentare delle incredibili capacità di controllo economico degli ebrei, i giapponesi, molto pragmaticamente, si erano detti: ma scusate, ma perché non sfruttiamo questa loro competenza? Pianificarono quindi di portare quantità di ebrei in Manciukuò, lo Stato fantoccio che il Giappone Imperiale aveva creato in Manciuria (lo potete vedere nel film L’Ultimo Imperatore).
Il fugu è una pietanza nota ai lettori di Renovatio 21: il pesce palla è cibo prelibato, che ha ucciso, vogliamo rammentarlo spesso, Bando Mitsugoro VIII (1906-1975), un attore che aveva il titolo di Ningen Kokuho, «tesoro nazionale vivente». Il pesce va preparato con una cura assoluta, perché varie parti sono velenose, quindi se finiscono, anche solo in parte in bocca al cliente del ristorante (che deva avere una licenza speciale per offrirlo nel menu), c’è la morte. L’attore patrimonio vivente morì dopo averne mangiato una quantità, una sfida al fato stile roulette russa ittico-venefica.
Ebbene, quei capoccia militari nipponici che idearono il Piano Fugu riconoscevano che l’importazione di ebrei poteva essere fatale al Paese. Per capire la situazione necessitiamo di una certa dose di elasticità, che è quella che serve spesso a contatto con le mentalità orientali. Cionondimeno, alcuni trovano la cosa talmente bizzarra da essere divertente.
Secondo alcuni, l’operazione fugu permise a molti ebrei di salvarsi dallo sterminio cui andavano incontro in Europa: il fugu come Schindler, come Perlasca. Tuttavia, non ci sembra che nemmeno quest’anno, nella pletora di contenuti olocaustici piombati per il «giorno della memoria», il pesce palla abbia trovato il suo posto. Ricordiamo pure, en passant, che in quello stesso 1934 Stalin creò ai confini della Manciuria l’oblast’ degli ebrei, una provincia autonoma estremo-orientale solo per giudei, che è peraltro ancora esistente. Anche il baffone… aveva concepito un suo piano fugu?
Vabbè, rimane il fatto che questo «underground sionista» di cui parlava quella copertina di libro a Nagasaki non ho capito cosa sia.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Un attimo, si sblocca un ulteriore ricordo, recentissimo. È un altro articolo che non siamo riusciti a scrivere, forse per mancanza di tempo, forse perché inebetiti dalla questione, che toglie il fiato e le parole pure…
Sapete cosa è successo a Brooklyn. Avete visto nitidamente quelle immagini sconvolgenti… sotto una sinagoga degli Chabad Lubavitcher (avete presente: sono quelli con la barbona, i riccioletti palandrano, il capellazzo a tutte le stagioni, quelli che sarebbero dietro a Milei, anzi davanti, perché mica la cosa è più nascosta), hanno trovato dei tunnel sotterranei, scavati dagli stessi ebrei ortodossi.
????
The Israeli students in question tore down the walls, started a riot with the police, and protested inside the tunnel. 10 people have since been arrested and the buildings are closed to the public. pic.twitter.com/hEuACCQYVi— CueBacca (@CueBacca17) January 9, 2024
I giornali mainstream americani, quelli filoisraeliani, magari pure con famiglie ebree come editori, hanno dovuto titolare proprio così: «Jewish Tunnel in New York City».
Ci siamo stropicciati gli occhi diverse volte, e dato tanti pizzicotti. La faccenda è che ci sono le immagini, che sono semplicemente pazzesche. La polizia che scopre i tunnel, o cerca di murarli, e la torma di ebrei hassidici – tutti uguali identici – che scatenano la rivolta: lasciateci le nostre strutture segrete sotterranee.
????Riot Unfolds as NYPD Responds to Discovery of Underground Tunnel in Brooklyn Temple
????#CrownHeights | #Brooklyn
Currently, numerous law enforcementare at the scene of a riot at the Chabad headquarters in Crown Heights, Brooklyn, where individuals tore wooden panels to… pic.twitter.com/JwttELX5ya
— The Truth Hammer #ProjektJncojok????????????????⭐️⭐️⭐️???? (@TruthHammer1776) January 10, 2024
Il podcaster Tim Pool la ha detta giusta. Mostrando il filmato che mostra incontrovertibilmente un signore ebreo che esce da un tombino in strada (!?!) ha considerato: «pensa di essere senza il video, e dover descrivere questa scena a qualcuno».
Hasidic Jew seen crawling out of sewer after NYPD busts Chabad tunnel network under New York City.
Follow: @AFpost pic.twitter.com/hJurb2Cc4Q
— AF Post (@AFpost) January 9, 2024
Effettivamente, il racconto di tale realtà fotografica in Italia potrebbe essere materia da legge Mancino.
Aiuta Renovatio 21
Ebrei che operano nel sottosuolo? Ebrei che costruiscono tunnel sotto le città? Credo che nell’antisemitismo a cavallo tra XIX e XX secolo fosse venuta fuori pure una storia del tipo che gli ebrei erano dietro la costruzione della metropolitana, perché da sotto terra sarebbe stato più facile, poi, farle cadere a suon di terrorismo (non ricordo dove ho letto questa cosa, ma immagino la facilità con cui il complottaro antisemita ottocentesco poteva arrivare a simili idee).
Bisogna capire che il sotterraneo è la proiezione psicospaziale del complottista di bassa lega: se sentite qualcuno che improvvisamente vi parla di tunnel segreti sotto la vostra città, qualsiasi essa sia, siete in presenza spesso di cospirazionista domofugo, cioè scappato di casa, cioè inattendibile e perdigiorno: perché chi vuole sempre credere ad un lato occulto della realtà, se pensa a dove vive, ci proietta subito una parte invisibile, che non può che essere sottoterra.
Poi però arrivano queste immagini.
Scusate, ma cosa sono quei materassi? È vero che sono materassi delle dimensioni dei letti da bambini? E cosa sono quelle macchie? E quel seggiolone…?
Stop it stalker! Go home or go find a tunnel in NY to hide or at least clean your mattress ???? pic.twitter.com/0B0gJFQ0LA
— Maged (@MagedMorsy) January 26, 2024
The first video of those moments has emerged.❗️❗️❗️
Recently, Jews who dug tunnels under #NewYork to an underground synagogue were exposed.
Bloody beds, baby high chairs and cutting tools were found in the tunnel. pic.twitter.com/YmZcQ0FcRr— J.Mırror???????? (@J__Mirror) January 13, 2024
Im trying get this straight. Some unmarried Jews dig a tunnel, for an “unexplained” reason. The tunnel contains baby high chairs and stained mattresses. Wtf is going on here? Could it have to with this scandal? https://t.co/okKMRv37F5 pic.twitter.com/dbX28giXlm
— The Man from the North (@Curtis39873882) January 9, 2024
Sostieni Renovatio 21
Risposte che mica arrivano con facilità. Tuttavia vari media hanno tentato di spegnere il fuoco con getti di teorie rassicuranti: va tutto bene, i tunnel erano per allargare la sinagoga. Allargare la sinagoga, sottoterra?
Ma no, i tunnel servivano a collegare la sinagoga con altre sinagoghe, o centri, o case, della zona. Ma perché scavare una galleria sotterranea illegale per farlo?
Ma no, tutto OK, in verità sappiamo che gli ebrei di Nuova York si erano opposti eroicamente al lockdown COVID del sindaco e del governatore, servivano quello… ma scusate, non è stato detto che i tunnel sono stati fatti l’anno scorso o poco prima, a restrizioni pandemiche morte?
Ma no, si tratta di mikvah, bagni rituali, quelli che si usano ritualmente per le donne ebree quando hanno il mestruo, solo che qui sono fatti per gli uomini… ma scusate, gli uomini hanno le mestruazioni? In USA anche sì, tuttavia è difficile che siano gli ebrei ortodossi a crederlo. Quindi: mikve rituali per purificare i futuri rabbini dal loro ciclo? Machedaverodavero?
Un comico su YouTube fa la battuta: il segno davvero apocalittico della situazione è il fatto che si sono visti dei giovani maschi ebrei ortodossi fare lavori manuali. Umorismo tutto neoeboraceno, dove è noto che di queste centinaia di aspiranti, solo il 2% diverranno rabbini, e gli altri saranno sistemati in qualche lavoro avulso dal lavoro materiale come la tratta dei diamanti in triangolazione con Anversa, Tel Aviv e forse qualche parente piazzato sopra una remota miniera africana.
Un altro dice: dopo questa cosa, la nostra vita è in discesa. Come faranno a chiamarci ancora complottisti? A deridere chi dice che la realtà, forse, non è quella che vediamo in superficie?
Qualcuno del giro QAnonista tira fuori dei disegni di artisti che, dicono, sarebbero nelle collezioni artistiche dei fratelli Podesta, che non capiamo bene come possano c’entrare qualcosa qui, ma sono inevitabili rigurgiti del Pizzagate.
It’s possible John Podesta’s artwork came to life yesterday.
There is absolutely zero reason for a child size mattress should be soiled and kept in an illegally constructed tunnel under a synagogue in NYC.
ZERO!!!! pic.twitter.com/12PcnMvEXP
— Teresa (@pepedownunder) January 10, 2024
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Altri ricordano più concretamente una pagina del sito internet dell’ADL. L’Anti Defamation League è il potente ente creato per combattere i discorsi antisemiti, anche schedando chiunque possa produrne anche solo echi lontani.
Nata – e collegata, secondo E. Michael Jones, al giro della mafia ebraica – per contrastare una fiammata di antisemitismo quando una 13enne di Atlanta fu trovata morta stuprata, l’ADL negli anni è passata a tacciare quantità impressionanti di persone di razzismo e di deviazione dai dogmi del politicamente corretto, arrivando di recente ad attaccare persino Elon Musk.
Il lavoro certosino di censimento di ogni possibile idea eterodossa da condannare perché pericolosa, aveva portato l’ADL a scrivere anche di una credenza detta «Mole/tunnel children», circolante fra i gruppi QAnon.
«Durante i primi mesi della pandemia di COVID-19, il governo ha allestito un ospedale improvvisato nel Central Park di New York. Allo stesso tempo, la Marina degli Stati Uniti ha inviato volontariamente in città la nave ospedale USNS Mercy per aiutare gli ospedali traboccanti» scrive il sito dell’ente di censura ebraico. «QAnon ha affermato che le tende a Central Park erano lì per nascondere buchi nel terreno che sarebbero stati utilizzati per salvare i numerosi bambini presumibilmente trafficati nei tunnel sotto il parco. Questi bambini salvati sarebbero stati portati alla USNS Mercy. Questa teoria ha guadagnato ulteriore popolarità perché la linea Q della metropolitana corre sotto il parco».
Diciamo che questa scheda che deride chi crede in tunnel segreti e traffici di bambini è invecchiata male – specie considerando che proviene da un’organizzazione, l’ADL, fondata nel 1913 dall’ordine giudeo-massonico B’nai B’rith.
E quindi… quei tunnel cosa sono? L’FBI, che ha programmi per infiltrare i pericolosi cattolici della messa in latino, sta indagando?
Non è che avremo risposta, lo sappiamo. Ci rimane l’immagine degli ebrei che escono dalle fogne, come le tartarughe ninja mutanti del vecchio cartone che un trentennio fa impazzava negli USA e anche un po’ in Italia.
Tuttavia, sblocchiamo un altro ricordo nel giorno memoria personale.
Sono in India, è il tardo autunno 2005. Sono ad Auroville, una stramba cittadina dove abitano in larga parte occidentali seguaci del filosofo e attivista separatista indiano Sri Aurobindo, delle cui stranezze magari parliamo un’altra volta. La mitica Marta, l’amica che ci ospita ci porta ad una sorta di festicciola sulla spiaggia, è notte, e l’Oceano Indiano scroscia nel buio più totale. Ad un tavolo ci sono dei ragazzi che mi presentano. Uno ha la pelle ambrata, il volto simpatico, ed è intento a prepararsi una sigaretta esotica. Capisco subito che si tratta di un israeli chilum smoker, espressione con cui gli indigeni indiani definiscono la massa di giovani israeliani che si abbattono costantemente sul subcontinente.
In pratica funziona così: in Israele fai tre anni di naja tremenda, dove di fatto non è che ti annoi in caserma, vai praticamente in guerra. I ragazzi (e le ragazze) sono talmente distrutti dall’esperienza che l’immediata reazione, già durante il servizio, è quella di convertirsi alla musica elettronica di tipo trance e all’uso di droghe sintetiche – insomma, il mondo dei rave, che ha fatto da teatro alla strage iniziale del 7 ottobre, con i parapendii motorizzati di Hamas a planare sul festival del ferale massacro nel deserto.
Finito il militare, ai giovani israeliani non bastano più i festoni locali – cercano uno spazio di decompressione in terre lontane per continuare a drogarsi ed ascoltare musiche para-spiritualiste, almeno per un po’, almeno prima di entrare finalmente all’università. L’India è la meta favorita per questo tipo di lavoro: qui trovano un certo senso di libertà, una qualche cifra spirituale orientale (che magari non intacca il loro ebraismo, secolare o no che sia, ma che è presente) e magari pure la cannabis che cresce in ogni angolo.
Quella sera avevo voglia di saperne di più. Il ragazzo stava davanti a me, e quindi sono partito con le domanda.
«Quanti passaporti hai?». Due. Uno era di un Paese UE che non avrei detto.
«Hai fatto il militare?». Sì, tre anni. L’ha fatto tutto. Ora stava decidendo dove, nel mondo, andare all’università.
«Hai mai ucciso un uomo?» chiedo a bruciapelo.
Lui, noto, cerca di non reagire d’istinto. Solo per un secondo, ferma il rollaggio.
«Sì» mi dice facendo come un sorriso, che però non è un sorriso. I suoi occhi dicono altro. Poi il sorriso finisce, lo sguardo gli diventa più controllato, razionale.
«Stavo in un carrarmato. Di notte, ho visto sullo schermo uno che scendeva dal muro. Una volta a terra, a cominciato a camminare così, come per non essere visto… combat walking»
«Ho chiesto al mio superiore se sparare. Lui mi ha detto di sì. L’ho fatto. In seguito sono stato premiato».
A questo punto il ragazzo israeliano accende. È chiaro che ci ha pensato mille volte. È chiaro che vuole dimenticare. È altrettanto chiaro, tuttavia, che non sa ancora cosa pensare, come sentirsi. O almeno, sa di non poterlo esprimere, forse nemmeno a se stesso: sia dentro stia venendo macinato, sia abbia invece il nulla.
Aiuta Renovatio 21
Ultimo ricordo di ebrei dal sottosuolo della mia mente, sempre con ambientazione indica, questa volta più leggero.
Estate 2010, sono a Dharamsala, la capitale del governo tibetano in esilio, residenza del Dalai Lama, eterna meta di pellegrinaggio di buddisti e divorziate a go-go. Sono con un gruppo di amici, cinque italiani e cinque indiani e indiane; abbiamo appena attraversato l’Himalaya in moto, siamo all’ultima tappa prima di tornare a Delhi.
Siamo esausti: in un passo a 5000 metri di altitudine metà della ciurma è caduta vittima del mal di montagna, e attorno a noi c’era il nulla, il deserto himalayano per chilometri di burroni sulla strada più pericolosa del mondo. A Leh, città più a Nord dell’India, avevamo visto come l’altitudine arrivi nei polmoni impedendoti quasi di fare le rampa di scale. A Lamayuru, un luogo sperduto vicino ad un monastero lamaista, eravamo finiti in un Overlook Hotel dove una ragazza finlandese sembrava intrattenere indiani a caso, in un contesto spettrale raccapricciante. A Sri Nagar, in Kashmir, sembrava che ci potessimo riposare: ed ecco invece che, di notte, viene nella nostra stupenda house boat che galleggia intarsiata sul lago Dal la polizia con il tizio che ce l’ha affittata, e ci dicono, apertis verbis, che è meglio se prendiamo le moto e fuggiamo via, perché per l’indomani era prevista una rivolta musulmana, cosa a cui qualcuno di noi pure pensava perché arrivando c’erano soldati armati di kalashnikov ogni cinquanta metri: ecco che sgommiamo impanicati, mentre prima dell’alba partono dai minareti suoni che si mischiano in un rumore che domina la valle e che sembra sul serio uscito dall’inferno.
Quindi, siamo a Dharamsala, qui bisogna riposarsi. Ce lo meritiamo. E se non trovi pace nella capitale del buddismo internazionale (almeno secondo Hollywood), dove la vuoi trovare? Gli israeli chilum smokers ci sono anche qui, ma ci sono tanti altri foreigner. La presenza israeliana era stata una costante in tutto il viaggio. Li avevamo visti a Manali, cittadina montana da cui si parte, dove negozi e call center hanno cartelli in hindi e in ebraico, skippando in alcuni casi del tutto l’inglese ed i caratteri latini. Nella valle di Numbra, posto remoto e magico con yak e cammelli d’alta quota da cui l’Himalaya guarda al Karakorum, ne avevamo incontrati una torma, tutti altamente disinteressati a fare amicizia con noi, anche se eravamo gli unici esseri viventi in tutta la zona.
Ecco che esce una rischiosa idea per il meritato relax: da qualche parte, dispersa nelle colline attorno a Dharamsala, c’è… una pizzeria. Proprio così: pur sapendo che stiamo andando incontro all’orrore puro, decidiamo unanimemente di partire alla sua cerca. Non ci si arriva in macchina e nemmeno in moto: bisogna camminare su un sentiero a piedi, dalla fine di un paesino, dove ancora si vede qualche stall, qualche localino dove notiamo lo spalmo di ulteriore presenza israeliana, poi avanti, nel buio, tra le colline. Alla fine, si giunge a questo posto sperduto povero ed indefinibile come la cosa che ci danno da mangiare, ma che ci importa, siamo qui, siamo in compagnia, siamo vivi, siamo sopravvissuti a tutto, siamo sopravvissuti all’Himalaya.
È stato camminando sul sentiero di ritorno che si è manifestata la scena con cui voglio chiudere questo scritto.
«Robi… Robi… vieni…. guarda!»
L’amico mi chiama da distante, ma come sussurrando, agitando le mani in aria. Pure nella tenebra, vedo che sta ridendosela di gusto. Lo raggiungo. Lui mi indica un punto sotto il sentiero, e continua a sganasciare sommessamente.
Allungo gli occhi: nel mezzo del niente, c’era una sorta di piccola struttura residenziale, quasi un condominio, tutto avvolto nell’oscurità. Tutte le finestre mostravano però che dentro c’era vita, le luci erano accese, forse si poteva sentire pure qualcuno parlare, e un lieve tunza-tunza della musica techno-trance in sottofondo.
«Guarda, Robi, guarda in quella finestra!»
A questo punto, vedo: nel caldo paratropicale indiano, nella capitale dei tibetani esiliati, nella notte più cupa ai piedi dell’Himalaya… ci sono, dentro un appartamento, due ragazzi ebrei ortodossi, riccioli, barba, cappello, palandrano, occhiali a fondo di bottiglia – proprio come quelli che a Nuova York scavano i misteriosi tunnel con dentro i materassi. Erano lì che parlavano, chiacchieravano uno metteva la mano sulla spalla dell’altro, sembravano sereni… felici.
Forse a leggerlo non fa effetto, ma assicuro che il cortocircuito di senso – tizi stile video Rock The Casbah dei Clash nell’oscurità asiatica – sul momento mi sconvolse, e non ricordo se risi o piansi, di dolore o di gioia (anche questo, in quel viaggio pazzesco, dovevo vedere).
Ci penso, in questo giorno della memoria, voglio ricordarlo: una delle prove che in effetti gli ebrei, dalla scuola elementare di mio figlio ai sotterranei americani, sono davvero un po’ dappertutto, sono un po’ in ogni cosa, e in modo paradossale – nel momento in cui si parla dei tunnel di Hamas, saltano fuori i tunnel ebraici di Brooklyn, nel giorno indetto per la memoria dello sterminio nazista, vengono accusati di genocidio all’Aia.
Rimane il dubbio: non sappiamo fino a che punto sia lecito, legale, tenere a mente queste cose, e pure scriverle.
Per cui, con le memorie dal sottosuolo ebraico, fermiamoci qua.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine generata artificialmente
Pensiero
Di tabarri e boomerri. Pochissimi i tabarri

Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Pensiero
Trump e la potenza del tacchino espiatorio

Il presidente americano ha ancora una volta dimostrato la sua capacità di creare scherzi che tuttavia celano significati concreti – e talvolta enormi.
L’ultima trovata è stata la cerimonia della «grazia al tacchino», un frusto rito della Casa Bianca introdotto nel 1989 ai tempi in cui vi risiedeva Bush senior. Il tacchino, come noto, è l’alimento principe del giorno del Ringraziamento, probabilmente la più sentita ricorrenza civile degli americani, che celebra il momento in cui i Padri Pellegrini, utopisti protestanti, furono salvati dai pellerossa che indicarono ai migranti luterani come a quelli latitudini fosse meglio coltivare il granturco ed allevare i tacchini. Al ringraziamento degli indiani indigeni seguì poco dopo il massacro, però questa è un’altra storia.
Fatto sta che il tacchino, creatura visivamente ripugnante per i suoi modi sgraziati e le sue incomprensibili protuberanze carnose, diventa un simbolo nazionale americano, forse persino più importante dell’aquila della testa bianca, perché il rapace non raccoglie tutte le famiglie a cena in una magica notte d’inverno, il tacchino sì. Tant’è che ai due fortunati uccelli di quest’anno, Gobble e Waddle (nomi scelti online dal popolo statunitense, è stata fatta trascorrere una notte nel lussuosissimo albergo di Washington Willard InterContinental.
🦃 America’s annual tradition of the Presidential Turkey Pardon is ALMOST HERE!
THROWBACK to some of the most legendary presidential turkeys in POTUS & @FLOTUS history before the big moment this year. 🎬🔥 pic.twitter.com/QT2Oal12ax
— The White House (@WhiteHouse) November 24, 2025
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Da più di un quarto di secolo, quindi, eccoti che qualcuno vicino alla stanza dei bottoni si inventa che il commander in chief appaia nel giardino delle rose antistante la residenza e, a favore di fotografi, impartista una grazia al tacchino, salvandolo teoricamente dal finire sulla tavola – in realtà ci finisce comunque suo fratello, o lui stesso, ma tanto basta. Non sono mancati i momenti grotteschi, come quando il bipede piumato, dinanzi a schiere di alti funzionari dello stato e giornalisti, ha scagazzato ex abrupto e ad abundantiam lasciando puteolenti strisce bianche alla Casa Bianca.
Non si capisce cosa esattamente questo rituale rappresenti, se non la ridicolizzazione del potere del presidente di comminare grazie per i reati federali, tema, come sappiamo quanto mai importante in quest’ultimo anno alla Casa Bianca, visti le inedite «grazie preventive» date al figlio corrotto di Biden Hunter, al plenipotenziario pandemico Anthony Fauci, al generale (da alcuni ritenuto golpista de facto) Mark Milley. Sull’autenticità delle firme presidenziali bideniane non solo c’è dibattito, ma l’ipostatizzazione del problema nella galleria dei ritratti dei presidenti americani, dove la foto di Biden, considerato in istato di amenza da anni, è sostituita da un’immagine dell’auto-pen, uno strumento per automatizzare le firme forse a insaputa dello stesso presidente demente.
Ecco che Donaldo approffitta della cerimonia del pardon al tacchino per lanciare un messaggio preciso: appartentemente per ischerzo, ma con drammatico valore neanche tanto recondito.
Trump si mette a parlare di un’indagine approfondita condotta da Bondi e da una serie di dipartimenti su di « una situazione terribile causata da un uomo di nome Sleepy Joe Biden. L’anno scorso ha usato un’autopsia per concedere la grazia al tacchino».
«Ho il dovere ufficiale di stabilire, e ho stabilito, che le grazie ai tacchini dell’anno scorso sono totalmente invalide» ha proclamato il presidente. «I tacchini conosciuti come Peach and Blossom l’anno scorso sono stati localizzati e stavano per essere macellati, in altre parole, macellati. Ma ho interrotto quel viaggio e li ho ufficialmente graziati, e non saranno serviti per la cena del Ringraziamento. Li abbiamo salvati al momento giusto».
La gente ha iniziato a ridere. Testato il meccanismo, Trump ha continuato quindi ad usare i tacchini come veicoli di attacco politico.
«Quando ho visto le loro foto per la prima volta, ho pensato che avremmo dovuto mandargliele – beh, non dovrei dirlo – volevo chiamarli Chuck e Nancy», ha detto il presidente riguardo ai tacchini, facendo riferimento ai politici democratici Chuck Schumer e Nancy Pelosi. «Ma poi ho capito che non li avrei perdonati, non avrei mai perdonato quelle due persone. Non li avrei perdonati. Non mi importerebbe cosa mi dicesse Melania: ‘Tesoro, penso che sarebbe una cosa carina da fare’. Non lo farò, tesoro».
Dopo che il presidente ha annunciato che si tratta del primo tacchino MAHA (con tanto di certificazione del segretario alla Salute Robert Kennedy jr.), l’uso politico del pennuto è andato molto oltre, nell’ambito dell’immigrazione e del terrorismo: «invece di dar loro la grazia, alcuni dei miei collaboratori più entusiasti stavano già preparando le carte per spedire Gobble e Waddle direttamente al centro di detenzione per terroristi in El Salvador. E persino quegli uccelli non vogliono stare lì. Sapete cosa intendo».
Tutto bellissimo, come sempre con Trump. Il quale certamente non sa che l’uso del tacchino espiatorio non solo non è nuovo, ma ha persino una sua festa, in Alta Italia.
Aiuta Renovatio 21
Parliamo dell’antica Giostra del Pitu (vocabolo piementose per il pennuto) presso Tonco, in provincia di Asti. La ricorrenza deriverebbe da usanze apotropaiche contadine, dove, per assicurarsi il favore celeste al raccolto, il popolo scaricava tutte le colpe dei mali che affligevano la società su un tacchino, che rappresentava tacitamente il feudatario locale. Secondo la leggenda, questi era perfettamente a conoscenza della neanche tanto segreta identificazione del tacchino con il potere, e lasciava fare, consapevole dello strumento catartico che andava caricandosi.
Tale mirabile festa piemontese va vanti ancora oggi, anticipata da un corteo storico che riproduce la visita dei nobili a Gerardo da Tonco, figura reale del luogo e fondatore dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni in Gerusalemme, poi divenuto Sovrano Militare Ordine di Malta.
Subito dopo il gruppo che accompagna Gerardo avanza il carro su cui troneggia il tacchino vivo, autentico protagonista della celebrazione. Seguono quindi i giudici e i carri delle varie contrade del paese, che mettono in scena, con grande realismo, momenti di vita contadina tradizionale. Il passaggio del tacchino è tra ali di folla che non esitano ad insultare duramente il pennuto sacrificale.
Il clou dell’evento è il cosiddetto processo al Pitu, arricchito da un vivace botta-e-risposta in dialetto piemontese tra l’accusa pubblica e lo stesso Pitu, il quale tenta inutilmente di difendersi. Dopo la inevitabile condanna, il Pitu chiede come ultima volontà di fare testamento in pubblico, dando vita a un nuovo momento di ilarità.
Durante la lettura del testamento, infatti, egli si vendica della sentenza rivelando, sempre in stretto dialetto, vizi grandi e piccoli dei notabili e dei personaggi più in vista della comunità. Fino al 2009, al termine del testamento, un secondo tacchino (già macellato e acquistato regolarmente in macelleria, quindi comunque destinato alla tavola) veniva appeso a testa in giù al centro della piazza. Dal 2015, purtroppo, il tacchino è stato sostituito da un pupazzo di stoffa, così gli animalisti sono felici, ma il tacchino in zona probabilmente lo si mangia lo stesso.
Ci sarebbe qui da lanciarsi in riflessioni abissali sulla meccanica del capro espiatorio di Réné Girard, ma con evidenza siamo già oltre, siamo appunto al tacchino espiatorio.
Il tacchino espiatorio diviene il dispositivo con cui è possibile, se non purificare, esorcizzare, quantomeno dire dei mali del mondo.
Ci risulta a questo punto impossibile resistere. Renovatio 21, sperando in una qualche abreazione collettiva, procede ad accusare l’infame, idegno, malefico tacchino, che gravemente nuoce a noi, al nostro corpo, alla nostra anima, al futuro dei nostri figli.
Noi accusiamo il tacchino di rapire, o lasciare che si rapiscano, i bambini che stanno felici nelle loro famiglie.
Noi accusiamo il tacchino di aver messo il popolo a rischio di una guerra termonucleare globale.
Noi accusiamo il tacchino di praticare una fiscalità che pura rapina, che costituisce uno sfruttamento, dicevano una volta i papi, grida vendetta al cielo.
Noi accusiamo il tacchino di essere incompetente e corrotto, di favorire i potenti e schiacciare i deboli. Noi accusiamo il tacchino di essere mediocre, e per questo di non meritare alcun potere.
Noi accusiamo il tacchino di aver accettato, se non programmato, l’invasione sistematica della Nazione da parte di masse barbare e criminali, fatte entrare con il chiaro risultato della dissoluzione del tessuto sociale.
Noi accusiamo il tacchino di favorire gli invasori e perseguitare gli onesti cittadini contribuenti.
Noi accusiamo il tacchino di aver degradato la religione divina, di aver permesso la bestemmia, la dissoluzione della fede. Noi accusiamo il tacchino di essere, che esso lo sappia o meno, alleato di Satana.
Noi accusiamo il tacchino di operare per la rovina dei costumi.
Noi accusiamo il tacchino per la distruzione dell’arte e della bellezza, e la sua sostituzione con bruttezza e degrado, con la disperazione estetica come via per la disperazione interiore.
Noi accusiamo il tacchino di essere un effetto superficiale, ed inevitabilmente tossico, di un plurisecolare progetto massonico di dominio dell’umanità.
Noi accusiamo per la strage dei bambini nel grembo materno, la strage dei vecchi da eutanatizzare, la strage di chi ha avuto un incidente e si ritrova squartato vivo dal sistema dei predatori di organi.
Noi accusiamo il tacchino del programa di produzione di umanoidi in provetta, con l’eugenetica neohitlerista annessa.
Noi accusiamo il tacchino di voler alterare la biologia umana per via della siringa obbligatoria.
Noi accusiamo il tacchino di spacciare psicodroghe nelle farmacie, che non solo non colmano il vuoto creato dallo stesso tacchino nelle persone, ma pure le rendono violente e financo assassine.
Noi accusiamo il tacchino per l’introduzione della pornografia nelle scuole dei nostri bambini piccoli. Noi accusiamo il tacchino per la diffusione della pornografia tout court.
Noi accusiamo il tacchino per l’omotransessualizzazione, culto gnostico oramai annegato nello Stato, con i suoi riti mostruosi di mutilazione, castrazione, con le sue droghe steroidee sintetiche, con le sue follie onomastiche e istituzionali.
Noi accusiamo il tacchino di voler istituire un regime di biosorveglianza assoluta, rafforzato dalla follia totalitaria dell’euro digitale.
Noi accusiamo il tacchino, agente inarrestabile della Necrocultura, della devastazione inflitta al mondo che stiamo consegnando ai nostri figli.
Tacchino maledetto, i tuoi giorni sono contati. Sappi che ogni giorno della nostra vita è passato a costruire il momento in cui, tu, tacchino immondo, verrai punito.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia
Civiltà
Da Pico all’Intelligenza Artificiale. Noi modernissimi e la nostra «potenza» tecnica

Sostieni Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori della 48ª settimana 2025
-



 Politica1 settimana fa
Politica1 settimana faIl «Nuovo Movimento Repubblicano» minaccia i politici irlandesi per l’immigrazione e la sessualizzazione dei bambini
-



 Persecuzioni1 settimana fa
Persecuzioni1 settimana faFamosa suora croata accoltellata: possibile attacco a sfondo religioso
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane fa«Rimarrà solo la Chiesa Trionfante su Satana»: omelia di mons. Viganò
-



 Fertilità2 settimane fa
Fertilità2 settimane faUn nuovo studio collega il vaccino contro il COVID al forte calo delle nascite
-



 Vaccini1 settimana fa
Vaccini1 settimana faIl vaccino antinfluenzale a mRNA di Pfizer associato a gravi effetti collaterali, soprattutto negli anziani
-



 Senza categoria7 giorni fa
Senza categoria7 giorni faI malori della 49ª settimana 2025
-



 Spirito1 settimana fa
Spirito1 settimana faGran Bretagna, ondata persistente di conversioni al cattolicesimo