Civiltà
Elisabetta Frezza: Gioventù terminali, generazioni telecomandate, artificializzate, geneticamente modificate. Formare il ritorno degli uomini liberi

Renovatio 21 pubblica l’intervento di Elisabetta Frezza al convegno «Sapiens^3. Superare un’antropologia disumana», Centro Ad Gentes, Nemi (Roma), 4 luglio 2021
Gli antichi chiamavano specchio di Diana questo piccolo lago di Nemi in cui storia e mito si incontrano. Diana era la dea della caccia e dei giovani che si affacciavano all’età adulta.
Anche oggi, come allora, a suggellare questo passaggio ci sono dei riti di iniziazione. Dei quali è mutata la forma, perché si sono smaterializzati, e si risolvono nella apposizione di un marchio di Stato; ed è mutato lo stesso significato, per il fatto che l’età adulta non è altro che un prolungamento caricaturale dell’infanzia, in una società liquida e ormai svirilizzata.
C’è di mezzo qualche millennio tra l’ora presente e il tempo di Diana Nemorensis. C’erano, allora, altri eroi, altre armi e altre battaglie. A cui sbaglieremmo se smettessimo di guardare.
Dei riti di iniziazione è stata mutata la forma, perché si sono smaterializzati, e si risolvono nella apposizione di un marchio di Stato; ed è mutato lo stesso significato, per il fatto che l’età adulta non è altro che un prolungamento caricaturale dell’infanzia, in una società liquida e ormai svirilizzata
Se partiamo dal fondo, dall’ultimo anno e mezzo – dal «via» della nuova era post-COVID – salta all’occhio come le istituzioni, quelle centrali e a cascata quelle periferiche, si siano disvelate come braccio armato del Potere, ossia come sua emanazione diretta, non più mediata (nemmeno per finta) dal diritto; quel diritto che, figlio della Civiltà più che millenaria sbocciata in questa terra – fatalità è proprio il Rex Nemorensis la prima magistratura della storia di Roma – ha sviluppato nei secoli una funzione duplice e interdipendente: da un lato svolge una funzione essenzialmente ordinatrice per la società, secondo un ordine che deve rispondere a criteri oggettivi ispirati al bene comune e in primis a un’esigenza di conservazione; dall’altro incorpora una funzione di garanzia per il singolo cittadino e per le formazioni sociali (naturali, che significa pregiuridiche, in primo luogo la famiglia) in cui l’individuo nasce, cresce e forma la propria personalità: serve cioè, in questo senso, a fare da argine alle degenerazioni del potere, per porre il cittadino al riparo dall’arbitrio sia del legislatore sia del giudice.
Il diritto oggi è stato inghiottito dalla cosiddetta pandemia.
E il Potere, oggi, si presenta al pubblico sottoforma di auctoritas autoaccreditata dal mito scientista: infatti è decentrato dalla sua sede naturale e (almeno nominalmente) «democratica», e trasferito in capo a organismi tecnici (comitati tecnico-scientifici, task force, cabine di regia) che emettono gli ipse dixit soggetti, poi, a mera ratifica da parte degli organi della politica. Con il risultato che il sindacato di legittimità sopra gli atti, cui viene data la forma di provvedimenti legislativi o amministrativi, diventa pressoché impraticabile.
Perché questi atti sono blindati dentro un guscio tecnocratico che rende spuntata ogni forma di controllo giuridico. Ma pure, paradossalmente, ogni forma di controllo scientifico, sempre per l’ipse dixit di cui sopra.
Salta all’occhio come le istituzioni, quelle centrali e a cascata quelle periferiche, si siano disvelate come braccio armato del Potere, ossia come sua emanazione diretta, non più mediata (nemmeno per finta) dal diritto; quel diritto che, figlio della Civiltà più che millenaria sbocciata in questa terra
Dunque, il presidio rappresentato dall’ordinamento giuridico in uno Stato di diritto ne esce di fatto neutralizzato (resta, e solo in parte, come puro involucro onomastico), grazie anche alla acquiescenza, tacita ma eloquentissima, delle istituzioni che sarebbero incaricate di esserne custodi, specialmente in frangenti di crisi o di emergenza.
La politica, dal canto suo, relegata dal pretesto emergenziale in una posizione ancillare, sconta almeno altri due limiti propri:
1) sconta la annosa tara di essere, nella cosiddetta democrazia rappresentativa, ostaggio dell’arbitrio delle maggioranze, dove le maggioranze sono le masse psicomediaticamente pilotate. Sappiamo bene come la propaganda sia in grado di generare superstizioni inscalfibili, e come su queste si fondi la logica del consenso, che viene guadagnato soprattutto attraverso la manipolazione dei linguaggi e delle idee;
2) sconta un limite empirico, di cui non possiamo non prendere atto: sugli scranni parlamentari e governativi sono approdate schiere di abusivi della politica, cioè personaggi privi del senso stesso, e alto, del mestiere che fanno, e perciò capaci solo di screditarlo e di affossarlo.
Il diritto oggi è stato inghiottito dalla cosiddetta pandemia. E il Potere, oggi, si presenta al pubblico sottoforma di auctoritas autoaccreditata dal mito scientista: infatti è decentrato dalla sua sede naturale e (almeno nominalmente) «democratica», e trasferito in capo a organismi tecnici (comitati tecnico-scientifici, task force, cabine di regia) che emettono gli ipse dixit soggetti, poi, a mera ratifica da parte degli organi della politica. Con il risultato che il sindacato di legittimità sopra gli atti, cui viene data la forma di provvedimenti legislativi o amministrativi, diventa pressoché impraticabile
Al guinzaglio di avventurieri senza scrupoli che ne sfruttano l’ignoranza, l’ignavia o la stupidità, questi personaggi ottusi o ottusamente conniventi, poiché condizionano le maggioranze parlamentari, stanno producendo la distruzione di tutte le basi etiche, alcune conquistate a caro prezzo, di una società che aveva pensato se stessa come emancipata dai lacci delle tirannie e della arroganza di poteri incontrollati.
Nemmeno percepiscono, gli abusivi della politica, la gravità di quanto sfornano a getto continuo e nei più vari ambiti tematici. Giocano con il Lego, tolgono e spostano mattoncini – che si chiamano obblighi, diritti, libertà – senza rendersi conto, per una specie di incapacità metafisica, che, magari, qualcuno di questi mattoncini è la chiave di volta di una costruzione complessa, eretta con fatica, scrupolo, sacrifici, per reggere e proteggere la convivenza civile.
Pare del tutto estranea, a costoro, l’idea di avere per le mani un oggetto da maneggiare con cura e sapienza, la cui gestione implica una immensa responsabilità. L’ordinamento infatti è un sistema organico e strutturato di norme che risponde a principi generali fondamentali; si sostanzia di categorie tecniche – il diritto è una disciplina tecnica e parla un linguaggio proprio, non fungibile con parole in libertà – e, se si toccano quei principi, viene giù tutto, e ci si mette nulla a precipitare nella barbarie.
Un esempio eclatante della barbarie incipiente è l’obbligo inflitto al personale sanitario di sottoporsi alla somministrazione di un farmaco del tutto nuovo e tuttora in fase di sperimentazione, come dichiarano espressamente le stesse case produttrici: un obbligo assistito da sanzioni che incidono sul diritto del lavoro e al lavoro, fino a travolgerlo.
Col DL 44 si è materializzato un monstrum giuridico che disintegra con nonchalance, in un colpo solo, una serie di cardini dell’ordinamento costituzionale a partire nientemeno che dall’art. 1; ma, ancor prima, aggredisce quel nucleo inscalfibile di principi portanti inviolabili e inderogabili che nemmeno una legge di rango sopraordinato, come è la Costituzione, può intaccare, perché non può far altro che riconoscerli e garantirli. Altrimenti si spezza quel nesso tra nomos e dike che si radica nella consuetudine morale profonda e che, a partire da Antigone, tiene in piedi, puntella, non tanto e non solo un ordinamento positivo, ma una Civiltà.
Al guinzaglio di avventurieri senza scrupoli che ne sfruttano l’ignoranza, l’ignavia o la stupidità, questi personaggi ottusi o ottusamente conniventi, poiché condizionano le maggioranze parlamentari, stanno producendo la distruzione di tutte le basi etiche, alcune conquistate a caro prezzo, di una società che aveva pensato se stessa come emancipata dai lacci delle tirannie e della arroganza di poteri incontrollati
C’era una volta l’habeas corpus. E ci voleva un manipolo di individui eletti da nessuno per pensare di eliminarlo, dall’oggi al domani, con decretazione d’urgenza. D’altra parte, il progressismo scientista e positivista, percorso dal sacro fuoco ecologista, è tranquillamente disposto a riconoscere la dignità morale della zanzara, ma non si fa alcuno scrupolo a profanare con disinvoltura la bandiera della dignità umana che pure sventola da decenni, ad pompam, in tutte le carte, interne e sovranazionali, dei diritti.
E però, ridurre un qualunque essere umano ad oggetto di sperimentazione, travalicando la sua volontà che deve essere libera, attuale e informata, vuol dire reificarlo. E questo fatto impone a tutti noi, indistintamente, di ricordare cosa abbia potuto significare la sperimentazione sull’uomo nel tempo in cui era praticata – con il consenso politico – da un certo dottor Mengele, di cui ultimamente si sente parlare sempre meno.
A margine, vale la pena di sottolineare lo strabismo delle stesse maggioranze illuminate che, del tutto incuranti della contradditorietà delle proprie emissioni tossiche, avevano già stravolto in senso inverso (ma ideologicamente convergente) la ratio dell’art. 32 Cost. quando, a partire dal caso Englaro, hanno preteso che persino la somministrazione di cibo e di acqua necessari per assicurare la sopravvivenza di una persona disabile sia da considerare trattamento sanitario e, come tale, debba essere condizionato al consenso del paziente, consenso vero o (come è stato per Eluana) semplicemente presunto. Stravolgendo così, con una orchestrazione farisaica, il senso di una norma nata per salvare le vite da trattamenti invasivi arbitrari, e non certo per garantire la soppressione di un congiunto magari diventato scomodo. Eppure in questo modo è stato tirato fuori dal cilindro del legislatore il cosiddetto «testamento biologico».
Ora d’improvviso quel consenso, ritenuto imprescindibile persino per essere nutriti e idratati, diventa tranquillamente trascurabile se si tratta di imporre una pozione di magia genetica (fàrmakon nella etimologia greca significa medicina e anche veleno) preparata dagli apprendisti stregoni di stanza nelle multinazionali farmaceutiche per i loro esperimenti faustiani.
C’era una volta l’habeas corpus. E ci voleva un manipolo di individui eletti da nessuno per pensare di eliminarlo, dall’oggi al domani, con decretazione d’urgenza. D’altra parte, il progressismo scientista e positivista, percorso dal sacro fuoco ecologista, è tranquillamente disposto a riconoscere la dignità morale della zanzara, ma non si fa alcuno scrupolo a profanare con disinvoltura la bandiera della dignità umana che pure sventola da decenni, ad pompam, in tutte le carte, interne e sovranazionali, dei diritti
Fatto sta che, insomma, siamo scivolati rovinosamente nella giungla del sopruso istituzionalizzato in cui non vi è più alcun argine alla demenza fatta precetto, in un vortice di spregiudicatezza e di irresponsabilità dove il confine tra l’impostura, la malafede e la tragicomicità è diventato davvero difficile da identificare.
In questa giungla può trovare sfogo incontrastato la libidine di comando e di prevaricazione di quanti, privi di scrupoli e al servizio di interessi personali e contingenti, si trovino a vestire pro tempore la divisa della autorità, nei più diversi ordini di grandezza: dai dicasteri fino agli istituti scolastici, dagli enti territoriali ai condomini.
Dilaga ovunque la sindrome del kapò – di cui ciascuno di noi nei mesi trascorsi ha di sicuro fatto una qualche personale esperienza – che colpisce in misura direttamente proporzionale alla pusillanimità e alla frustrazione repressa di chi sia esposto al contagio per la posizione che riveste.
In questo virtuosismo di dissennatezza e prepotenza, la massa a trazione mediatica, acquisito definitivamente l’habitus del suddito mentalmente depresso e assuefatto, peraltro intimidita dal piglio autoritario del despota diffuso, è disposta a mettere da parte ogni reazione che il semplice buon senso – questo sconosciuto – dovrebbe suggerirle.
Ad alimentare la propensione alla obbedienza cieca e automatica – si può dire cadaverica – se in origine era effettivamente, e comprensibilmente, la paura di un virus sconosciuto, ora è per lo più un’altra paura primordiale, che se possibile lascia ancora meno spazio all’esercizio del pensiero: la paura della morte civile, ossia la paura di essere emarginati dal consesso sociale, altrimenti detto società civile, perché fatta di bravi cives, cioè – nella accezione aggiornata del termine – ominidi educati dalla culla alla tomba a conformarsi ai dogmi del nuovo evangelo civico (arricchito recentemente del corposo capitolo sanitario).
Siamo scivolati rovinosamente nella giungla del sopruso istituzionalizzato in cui non vi è più alcun argine alla demenza fatta precetto, in un vortice di spregiudicatezza e di irresponsabilità dove il confine tra l’impostura, la malafede e la tragicomicità è diventato davvero difficile da identificare
Quell’evangelo che è diventato nel frattempo persino una nuova supermateria obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo (supermateria perché trasversale a tutte le altre e che quindi si comporta come una sorta di asso pigliatutto) e che va sotto l’etichetta rassicurante di «nuova educazione civica» – pareva brutto chiamarla direttamente Agenda 2030, ma di fatto quello è: i libri di testo, infatti, si intitolano proprio così – introdotta con l. 92/2019 ed entrata in vigore giusto giusto a partire dall’ultimo anno scolastico 2020/21. Guarda un po’ le combinazioni.
Questa materia è un grande carro dentro cui vengono trasportati i macromotivi delle ideologie in voga, per addomesticare il suddito globale. In contemporanea il Vaticano, per non sfigurare, si è inventato una cosa che ha chiamato Global Compact on Education (c’era una volta il latino), con cui ha messo a tema anche lui la necessità di «ricostituire il patto educativo globale per costruire il futuro del pianeta», come da decalogo mondialista, quale risulta dal combinato disposto della Agenda ONU 2030 e della enciclica Laudato sì, che non sono altro che le due facce della stessa medaglia.
Così la teologia globalista, che si presenta al mondo in veste egualitaria, pacifista, ecologista (nel senso di Greta), scientista, genderista, omosessualista e ora terapeutica, diventa un programma congiunto contro-culturale (a-culturale) da imporre alle masse a uso e consumo del Potere; di qui discende la sua implacabile vocazione fondamentalista, nel senso che quanti non vi si convertano sono ipso facto rigettati dal consesso civile. Candidati alla nuova apartheid.
Ad alimentare la propensione alla obbedienza cieca e automatica – si può dire cadaverica – se in origine era effettivamente, e comprensibilmente, la paura di un virus sconosciuto, ora è per lo più un’altra paura primordiale, che se possibile lascia ancora meno spazio all’esercizio del pensiero: la paura della morte civile, ossia la paura di essere emarginati dal consesso sociale, altrimenti detto società civile, perché fatta di bravi cives, cioè – nella accezione aggiornata del termine – ominidi educati dalla culla alla tomba a conformarsi ai dogmi del nuovo evangelo civico (arricchito recentemente del corposo capitolo sanitario).
Questo pacchetto di dogmi è stato imbellettato con un cerone mistico e si è tramutato in un vero e proprio credo, elaborato nei templi delle tecnocrazie sovranazionali, sposato dalla chiesa postcattolica, e propagato in filodiffusione a reti unificate. Una religione con le sue formule, i suoi riti, i suoi sacramenti, i suoi ministri del culto.
L’apporto del cristianesimo – un cristianesimo evidentemente contraffatto, orizzontale, rivisto e corretto in salsa filantropica e umanitaria – è oltremodo utile a fornire alla manovra il respiro universale cui ambisce.
Nelle catechesi di massa, come è questa con cui abbiamo a che fare, torna comoda la struttura gerarchica del cattolicesimo romano, che incorpora in sé il germe dell’obbedienza, sfruttando l’equivoco madornale insito nella domanda che pochi si fanno, ma che è cruciale: obbedienza a chi? Alla verità rivelata, o alla istituzione pro tempore? A Cristo, o al suo vicario? Alla legge di Dio, o ai suoi interpreti estemporanei? Questa ambiguità sul senso dell’obbedienza lascia tutto lo spazio all’indottrinamento massivo, che fa leva su un duplice atavico bisogno delle persone: di avere una guida morale da seguire, e di sentirsi in pace con la coscienza.
A questo serve, e non è cosa da poco, la santa alleanza tra le tecnocrazie e la neochiesa, impegnate oggi nella stessa identica opera di proselitismo.
Da notare che chi aderisce a questa nuova religione ha il terrore di sottoporne i dogmi al vaglio della ragione, perché sa che questo vaglio potrebbe far crollare miseramente una impalcatura farlocca a cui ha finito per affidare tutto, per puro atto di fede, a partire dalla propria salute, la propria vita, la salute e la vita dei propri figli.
Ecco perché il devoto si aggrappa disperatamente ai mantra che i media di regime diramano per soffocare i fatti – che hanno il vizio di accadere nonostante la narrazione costruita a tavolino che tenta di soffocarli – e li ripete ipnoticamente, questi mantra, in cattedra, al bar, dal salumiere, nel sonno.
Ecco perché il devoto odia coloro che non si lasciano trascinare nel gorgo del conformismo ed esercitano ancora un discernimento critico (peraltro nemmeno troppo sofisticato, anzi piuttosto elementare). Questo nuovo uomo pio odia gli empi che disertano i rituali di massa, le orge scientificamente corrette, perché in qualche modo mettono in luce tutta la debolezza, l’abulia, l’apatia, di chi si lascia stregare dai suoni disarticolati della propaganda, per quanto siano palesemente stonati, grossolanamente contraddittori, ma non importa.
Ecco perché il devoto odia coloro che non si lasciano trascinare nel gorgo del conformismo ed esercitano ancora un discernimento critico (peraltro nemmeno troppo sofisticato, anzi piuttosto elementare).
Questo nuovo uomo pio odia gli empi che disertano i rituali di massa, le orge scientificamente corrette, perché in qualche modo mettono in luce tutta la debolezza, l’abulia, l’apatia, di chi si lascia stregare dai suoni disarticolati della propaganda, per quanto siano palesemente stonati, grossolanamente contraddittori, ma non importa.
La massa ovina non si pone troppi problemi: obbedisce in cambio di una brucata qua e là. E comunque, a rinsaldare e nobilitare questa modalità gregaria (cioè propria di chi è parte integrante del gregge) soccorre l’autoidentificazione con la figura del missionario, che incarna la più alta forma di altruismo caritatevole. Così che, appunto, anche la coscienza ne esce non solo pacificata, appagata, ma addirittura gonfiata con generoso autocompiacimento.
Alla luce di tutto questo, è evidente come da un anno e mezzo a questa parte noi non siamo di fronte a una operazione di carattere sanitario, ma semmai psicosociale e psicopolitico. L’adesione al piano terapeutico calato dall’alto è un referendum, una richiesta di consenso (non informato, perché fondato su un puro atto di fede).
Ebbene, il popolo eterodiretto ha votato: la maggioranza ha detto sì. Un voto estorto con l’inganno, in cambio del miraggio della restituzione di una finta libertà, come se la mia libertà fosse l’oggetto di una graziosa concessione altrui.
Particolarmente esposte a restare catturate nelle geometrie perverse e pervertite di questo potere ab-soluto (sciolto da ogni vincolo superiore) e nei suoi tentacoli mediatici, e soprattutto prone a subirne massimamente i danni, sono le nuove generazioni. Plasmabili per definizione e obbedienti per formazione.
Alla luce di tutto questo, è evidente come da un anno e mezzo a questa parte noi non siamo di fronte a una operazione di carattere sanitario, ma semmai psicosociale e psicopolitico. L’adesione al piano terapeutico calato dall’alto è un referendum, una richiesta di consenso (non informato, perché fondato su un puro atto di fede)
Il loro indottrinamento, già a buon punto grazie a un programma che parte da molto lontano, ha subito nell’ultimo anno e mezzo una accelerazione furibonda e un cambio di passo verso l’addestramento precoce della vita in schiavitù.
È stato inflitto loro un violento condizionamento psicofisico, fortemente potenziato dalla privazione protratta di tutti quegli spazi naturali, tempi naturali, modalità spontanee, legati indissolubilmente ai bisogni vitali di individui in crescita: la scuola, l’aggregazione, il movimento, l’aria aperta. Addirittura sono stati cancellati i volti, le espressioni; è stato inibito il contatto, il respiro, il sorriso e l’abbraccio. La vita.
Nelle parentesi elargite in presenza, momentaneamente scarcerati dalla famigerata DAD, gli scolari sono stati costretti a inscenare in modo continuato, come tante scimmiette ammaestrate, una serie di rituali di massa (distanziamenti, igienizzazioni, controlli, monitoraggi, sensi unici alternati, e chi più ne ha più ne metta): un incrocio tra un lager e un presidio sanitario, insomma. Queste azioni ritmate e ripetute, intimamente condizionanti, finiscono per cementare demenziali automatismi, per inculcare ipocondria, diffidenza verso i propri simili, subordinazione cieca agli ordini della sedicente autorità. L’obbedienza a ogni genere di imposizione, cui la massa è stata educata per tempo a scuola con mezzi subdoli quanto suggestivi, si radica così definitivamente legandosi pure al voto in pagella.
Ebbene, il deserto sensoriale e l’annientamento psicofisico sono stati la premessa ideale per completare un piano di conquista e di sottomissione di una generazione già pesantemente minata nel proprio sistema immunitario dalla dipendenza telematica (con tutti i suoi effetti degradanti sullo sviluppo delle facoltà superiori), oltre che da una scuola divenuta, da tempo, palestra di omologazione coatta: è stato fatto un lavoro implacabile e certosino nella scuola dei test a crocette, del mercato e delle soft skills, del successo formativo, dei crediti e dei debiti. Dell’alternanza con il lavoro, dei corsi alla sessualità e alla non violenza, all’inclusione, alla alimentazione e al codice della strada. Di tutto, insomma, fuorché della conoscenza, della cultura, della teoresi: ovvero dei fondamentali. La scuola è di fatto una fabbrica di invertebrati analfabeti, che devono essere svuotati di tutto e rimpinzati di contenuti ad alta carica ideologica.
Com’è intuitivo, ha un ruolo chiave nel processo di destrutturazione, liquefazione e riprogrammazione dell’essere umano, perché è lì che transitano tutti e che tutti si possono plasmare, come il pongo.
Particolarmente esposte a restare catturate nelle geometrie perverse e pervertite di questo potere ab-soluto (sciolto da ogni vincolo superiore) e nei suoi tentacoli mediatici, e soprattutto prone a subirne massimamente i danni, sono le nuove generazioni. Plasmabili per definizione e obbedienti per formazione.
La cattività protratta, e tutta la sofferenza che ne è scaturita, è stata il trampolino di lancio per l’ultimo ricatto e la soluzione finale che, attraverso i noti raggiri mediatici, ha indotto i nostri ragazzi ad assumere di slancio il ruolo di cavie inconsapevoli in una surreale, agghiacciante, transumanza. Messi in carcere per un anno e mezzo-due, sono diventati delle molle, hanno perso la capacità di guardare a un orizzonte che vada oltre la prospettiva asfittica della vacanzina estiva o della serata in discoteca. Hanno perso il senso del limite e il senso stesso della vita e, pur di riconquistarne una fettina, un pallido simulacro peraltro a scadenza, sono pronti a tutto.
Non bisogna dimenticare che la scuola dell’emergenza – un grottesco surrogato di scuola – era stato definito dall’UNESCO (propaggine ONU per l’educazione, la scienza e la cultura), come «l’esperimento di più vasta scala nella storia dell’istruzione». Siamo, appunto, nell’era degli esperimenti di massa. Ce lo dicono a chiare lettere, ormai non c’è più nulla di nascosto, la fase carsica dell’esecuzione del piano egemonico è superata, ora è tutto alla luce del sole. Pornograficamente.
La cavia predestinata di questo esperimento era appunto l’alunno, ridotto a paziente, a terminale, a materiale di laboratorio, ostaggio fisso della macchina che gli è fornita in dotazione e che deve prendere il sopravvento su di lui, profilandolo e, poi, telepilotandolo. Nel fantastico mondo dei finti diritti e della finta democrazia, nella ubriacatura delle finte libertà, il controllo si fa sempre più penetrante e pervasivo e serve alla manipolazione, alla standardizzazione, alla robotizzazione sistematica. D’altra parte, il potere che ci sovrasta (e che si presenta oggi sotto la forma insidiosa del biopotere) è ossessionato dal controllo. Talmente ossessionato da fare irruzione fin dentro lo spazio sacro della sovranità famigliare e persino della sovranità biologica, genetica, molecolare. E di quella spirituale.
Ebbene, il deserto sensoriale e l’annientamento psicofisico sono stati la premessa ideale per completare un piano di conquista e di sottomissione di una generazione già pesantemente minata nel proprio sistema immunitario dalla dipendenza telematica (con tutti i suoi effetti degradanti sullo sviluppo delle facoltà superiori), oltre che da una scuola divenuta, da tempo, palestra di omologazione coatta. La scuola è di fatto una fabbrica di invertebrati analfabeti, che devono essere svuotati di tutto e rimpinzati di contenuti ad alta carica ideologica
Bene. Abbiamo il risultato (parziale) di questo bell’esperimento scolastico. Ce lo hanno fornito i dati, rilanciati pure senza vergogna dai giornaletti mainstream, che titolano: «I ragazzi come reduci di guerra». I primi sono stati i neuropsichiatri del Bambin Gesù, poi l’equipe del Gaslini, da ultimo l’istituto neurologico Mondino di Pavia, e molte altre sirene qualificate che hanno fatto suonare l’allarme rosso: il 79 per cento degli adolescenti manifesta sintomi riconducibili a un disturbo post traumatico da stress. Proprio come i reduci del Vietnam. Si impennano i suicidi, tentati e consumati.
È criminale che, dopo questa strage dichiarata, gli stessi cosiddetti “esperti” lascino che passi liscio liscio il messaggio becero che la vita, rapinata e insultata fino a quel punto, si ripari e si riconquisti attraverso un green pass, che sta diventando il patentino da esibire in società per farle credere (alla società) che sei un tipo emancipato. Quando invece è la plastica manifestazione del più beota asservimento.
Stiamo truffando e annientando una generazione intera. Ora lo stiamo facendo proprio fisicamente. Ma spiritualmente, moralmente, culturalmente il grosso del lavoro era già stato fatto e il terreno era ampiamente dissodato.
Lo Stato, appropriandosi manu militari dei suoi sudditi in erba, li vuole crescere ligi, uguali e obbedienti. L’arma vincente, per ottenere la piena uniformità di vedute e comportamenti, ed evitare disertori, è la minaccia dell’esclusione dei non conformi dal gruppo dei pari.
In questo delirio collettivo, è sbocciata addirittura una nuova virtù civica, la delazione (che si è aggiunta alla lista dei comandamenti del bravo cittadino globale, allevato in batteria col becchime della Agenda ONU 2030). Il sicofante, prototipo del personaggio spregevole nella letteratura classica, è diventato un eroe nella nuova catechesi scolastica.
La scuola dell’emergenza – un grottesco surrogato di scuola – era stato definito dall’UNESCO (propaggine ONU per l’educazione, la scienza e la cultura), come «l’esperimento di più vasta scala nella storia dell’istruzione». Siamo, appunto, nell’era degli esperimenti di massa. Ce lo dicono a chiare lettere, ormai non c’è più nulla di nascosto, la fase carsica dell’esecuzione del piano egemonico è superata, ora è tutto alla luce del sole. Pornograficamente
Si sa bene quanto la pressione del gruppo abbia il potere di conformare fino a intimamente persuadere, soprattutto chi fisiologicamente ha bisogno del gruppo per identificarsi e via via identificare se stesso, e per sbalzare fuori così la propria personalità. Sapevano di affondare il coltello nel burro. Li avevano già programmati per rispondere a un determinato segnale.
Ma di questo trattamento crudele e zootecnico in cui sono rimaste invischiate le nuove generazioni, e non da oggi, i primi responsabili ovviamente siamo noi, i loro ascendenti. Abbiamo assistito in questi mesi al film impietoso e grottesco di genitori storditi, e nonni teledipendenti, ripiegati tutti sul proprio travolgente egotismo, che non hanno fatto altro che avallare una narrazione drogata e rincarare ab intra le vessazioni inflitte a quei figli che, invece, avrebbero dovuto proteggere dagli abusi e armare con le armi della ragione, dell’autonomia, del coraggio.
Senza colpo ferire li hanno consegnati al leviatano, come vittime sacrificali. Nel senso letterale, perché in questi rituali si praticano anche sacrifici umani.
L’idea estrema che deve passare è che bisogna mettere nel conto anche i sacrifici umani, la gente deve imparare ad accettarli in nome del calcolo utilitarista: alcuni muoiono, magari tu stesso muori, ma siccome secondo la vulgata altri da queste morti trarrebbero beneficio, nel bilancio demenziale inculcato alle masse rintronate va bene così. In un clamoroso quanto devastante ribaltamento dei principi morali più elementari, della logica e, ancor prima, del primordiale istinto di conservazione.
Paradossalmente, la leva che ci ha portato fino a dover subire la schiavitù più feroce che sta umiliando le nostre vite è stata proprio l’ubriacatura della finta libertà.
L’uomo si è persuaso di potersi autodeterminare senza limiti nel suo brodo individualistico ed edonistico, fino al punto di sbarazzarsi persino della realtà, della natura e della stessa fisiologia. Ma l’uomo-misura di tutte le cose, quello che si dà le proprie leggi senza alcun parametro superiore, non può che approdare al proprio suicidio. Un po’ come la barca che perde il timoniere o gli strumenti di bordo e non vede più le stelle sopra di sé a darle l’orientamento. Ci siamo schiacciati rasoterra e ci siamo chiusi il cielo sopra di noi.
L’immanentizzazione della religione, completamente addomesticata alle logiche adulterate del mondo, è stata, in questo processo, decisiva.
Stiamo truffando e annientando una generazione intera. Ora lo stiamo facendo proprio fisicamente. Ma spiritualmente, moralmente, culturalmente
Non è un’iperbole paragonare i connotati dell’ora presente a quelli dell’universo concentrazionario, di cui la letteratura ci offre descrizioni mirabili, ma dalle quali non abbiamo tratto l’insegnamento che avremmo dovuto. Del resto, c’è un motivo per cui la storia non si insegna e non si impara più.
In Arcipelago Gulag, Solženicyn racconta la vita nelle centinaia di lager in cui, fra il 1930 e il 1953, sono transitati circa venti milioni di cittadini sovietici. Ogni lager era un’isola dell’Arcipelago.
A un certo punto della sua opera, l’autore elenca i veleni che, dal vasto mare dei lager, si propagarono in tutta la Russia, fino a deformare anche la cosiddetta «vita libera» di coloro che stavano oltre i reticolati. Questi veleni, diffusi come un gas tossico, dappertutto, erano: «costante paura, marchiatura, circospezione e diffidenza, generale ignoranza, delazione, corruzione, tradimento e menzogna come forma di esistenza, crudeltà, psicologia da schiavi».
Meno di un secolo dopo, ciascuna di queste componenti, nessuna esclusa, si ripropone e stende sulla società lo stesso reticolato invisibile. Anzi, l’insieme di questi elementi esce amplificato dalla potenza di fuoco, e dalla estensione senza confini territoriali, del progresso tecnologico, soprattutto biotecnologico. Il nostro è un lager planetario.
L’idea estrema che deve passare è che bisogna mettere nel conto anche i sacrifici umani, la gente deve imparare ad accettarli in nome del calcolo utilitarista: alcuni muoiono, magari tu stesso muori, ma siccome secondo la vulgata altri da queste morti trarrebbero beneficio, nel bilancio demenziale inculcato alle masse rintronate va bene così. In un clamoroso quanto devastante ribaltamento dei principi morali più elementari, della logica e, ancor prima, del primordiale istinto di conservazione
Ciò che davvero interessa i suoi tenutari non è l’egemonia economica o l’espansione geopolitica, ma è il dominio sull’uomo, nel corpo e nel pensiero: la sua umiliazione, la sua riduzione, secondo un piano antico, esplicito e ordinatissimo, che operativamente possiamo ricondurre al Club di Roma alla fine degli anni Sessanta, ma le cui radici teoriche risalgono al Malthus di qualche secolo prima. Era stato messo in fila da tempo tutto ciò che serve all’avvento del postumano e del transumano. Cioè, dell’anti-umano.
Ecco allora i piani di riduzione della popolazione, detti graziosamente di «pianificazione famigliare» (Planned Parenthood). Ecco la sterilizzazione generalizzata, chiamata con la formula più carina di «sviluppo sostenibile» (che è poi il titolo della Agenda 2030), ecco la decrescita più o meno felice. Ovvero la contrazione terminale del sistema tutto: delle libertà, della procreazione, del lavoro. In una parola, della Civiltà.
L’uomo, l’Imago Dei, va annientato.
Alla depopolazione, secondo il programma neomalthusiano che sta alla radice delle agende sovranazionali da qualche decennio a questa parte, si procede attraverso due direttrici interdipendenti: la sterilizzazione e l’eugenetica.
Il mondo nuovo è un mondo sterilizzato, in ogni senso possibile. Sia nel senso che l’umanità va resa sterile, cioè va messa in condizione di non riprodursi naturalmente, e va educata a essere sterile. Sia nel senso che deve nascere, vivere e morire in ambiente sterile: la fecondazione avviene in provetta e l’utero artificiale – si dice in ambienti sedicenti scientifici – sarebbe preferibile all’utero materno perché a differenza di questo è un ambiente sterile; allo scemare della qualità della vita – qualità misurata secondo il metro arbitrario di chi comanda – c’è l’eutanasia a garantire una dipartita pulita, anch’essa in ambiente sterile e sanificato; infine, la cremazione assicura l’igiene post mortem.
Ciò che davvero interessa i suoi tenutari non è l’egemonia economica o l’espansione geopolitica, ma è il dominio sull’uomo, nel corpo e nel pensiero: la sua umiliazione, la sua riduzione, secondo un piano antico, esplicito e ordinatissimo, che operativamente possiamo ricondurre al Club di Roma alla fine degli anni Sessanta, ma le cui radici teoriche risalgono al Malthus di qualche secolo prima. Era stato messo in fila da tempo tutto ciò che serve all’avvento del postumano e del transumano. Cioè, dell’anti-umano.
Tutto risponde a un disegno contronaturale, contro il logos (contro il bio-logos) che sovrintende al creato. Contro la carne e lo spirito.
L’uomo deve essere pian piano sostituito dal prodotto fabbricato in laboratorio, all’ultimo grido dell’ingegneria eugenetica. L’ultimo grido si chiama CRISPR. Il CRISPR è il procedimento biotecnologico di editing genetico, cioè di taglia e cuci molecolare, con cui nel DNA vengono sostituiti dei geni, i cosiddetti geni bersaglio, e poi viene ricucita la catena genetica.
Le tecniche connesse con la fecondazione in vitro (il grande affare della provetta) servono a programmare i connotati dell’essere umano nella fase che precede l’impianto dell’embrione. Ancora una volta, su modello zootecnico. Li abbiamo già, i bambini geneticamente modificati, tipo le famose gemelline cinesi, nate nel 2019 AIDS-free (immuni all’HIV) con la tecnica CRISPR.
Un co-scopritore del CRISPR ha detto a chiare lettere che «fare il bambino con il CRISPR sarà come vaccinarlo». La provetta cioè, di fatto, come cantiere prenatale della vita diventa una sorta di vaccino preventivo incorporato nel procedimento di fabbricazione del manufatto umano, in modo che il prodotto sottoforma di bambino possa essere consegnato all’aspirante genitore insieme al relativo certificato di garanzia: immune all’HIV, o un domani immune al Covid, ma anche, per esempio, dotato di ossa indistruttibili, o di orecchio assoluto, di intelligenza matematica.
Il genetista sir Richard Dawkins nel 2006 diceva che è lecito chiedersi, essendo ormai passati sessant’anni dalla morte di Hitler, quale sia la differenza morale tra la riproduzione di esseri con abilità musicali, e il costringere un bambino a prendere lezioni di musica. O tra l’allenare corridori veloci o saltatori in alto, e riprodurli.
L’uomo deve essere pian piano sostituito dal prodotto fabbricato in laboratorio, all’ultimo grido dell’ingegneria eugenetica. L’ultimo grido si chiama CRISPR. Il CRISPR è il procedimento biotecnologico di editing genetico, cioè di taglia e cuci molecolare, con cui nel DNA vengono sostituiti dei geni, i cosiddetti geni bersaglio, e poi viene ricucita la catena genetica
Cosa significa questo? Significa che, sotto la suggestione del miglioramento della progenie (il che dovrebbe ricordare qualcosa, ma di nuovo il non studiare più la storia serve anche a dimenticare gli orrori del passato), stiamo allegramente consegnando ai signori delle farmaceutiche il controllo di qualità e di quantità sulle nostre vite.
In cambio dell’illusione di ottenere il figlio perfetto, munito dei connotati scelti da catalogo, liberato a priori da una lista di malattie e affrancato dai rischi connessi alla lotteria della natura (una roulette russa, in fondo), in cambio di questa illusione, siamo disposti a cedere il rubinetto della vita alle multinazionali del farmaco e ai filantropi che le controllano, che potranno accenderlo o spegnerlo a piacimento, e possono condurre impuniti i loro esperimenti eugenetici.
Non ci vuole molto a capire come l’agenda segnata voglia che la procreazione, da naturale, debba diventare sintetica. Cioè de-sessualizzarsi (il sesso viene relegato a funzione ricreativa, ma sterile) e spostarsi verso il paradigma della “fertilizzazione”, come nella zootecnia (con relative selezioni e manipolazioni tecnologiche).
Il «padre» della prima bambina concepita in provetta nel 1978 – il prototipo Louise Brown – per la sua impresa conquistò nel 2010 il Nobel per la medicina. Nella motivazione del premio, si legge che, grazie a lui, «la fecondazione in vitro passa da visione a realtà, e comincia una nuova era della medicina». E lui, sir Robert Edwards, dichiarò, papale papale, di essere riuscito a dimostrare con successo di sapersi mettere al posto di Dio. E preconizzava compiaciuto che «presto sarà colpa dei genitori avere un bambino portatore di disordini genetici». Vale a dire che, nella sua testa, la normalizzazione della provetta doveva gradualmente portare verso la demonizzazione della generazione naturale.
Le tecniche connesse con la fecondazione in vitro (il grande affare della provetta) servono a programmare i connotati dell’essere umano nella fase che precede l’impianto dell’embrione. Ancora una volta, su modello zootecnico. Li abbiamo già, i bambini geneticamente modificati, tipo le famose gemelline cinesi, nate nel 2019 AIDS-free (immuni all’HIV) con la tecnica CRISPR
Ha fatto proseliti costui, perché il nostro ministero della salute qualche anno fa, in occasione del lancio dei cosiddetti Fertility Day (una bella trovata della Lorenzin acclamata dalla galassia cattolica), diceva che la FIVET, «nata come risposta terapeutica a condizioni di patologia specifiche e molto selezionate, sta forse assumendo il significato di un’alternativa fisiologica». Cioè, alla procreazione come madre natura l’ha pensata. Alternativa fisiologica è il passaggio che precede la «scelta obbligata» perché, in questo ordine di idee, la procreazione naturale, quella appunto affidata alla roulette russa della natura, deve diventare un rischio assurdo e correrlo una scelta irresponsabile, da persone civicamente ineducate e anche un po’ egoiste: oggi infatti il progresso offre la possibilità di eliminare gli imprevisti attraverso la riprogenetica, sterilizzata e selettiva, quella che produce e consegna designer babies su ordinazione, chiavi in mano e in garanzia.
Il punto è che la fecondazione artificiale, cioè la fabbricazione dell’uomo in laboratorio, è intimamente e inscindibilmente interconnessa alla eugenetica. Per una questione di logica invincibile. Se io ordino un bambino e, dopo tutta la filiera, mi viene consegnata una creatura con qualche patologia o senza gli optional richiesti è, tecnicamente, un aliud pro alio.
Lo stesso Edwards non ha mai fatto mistero né del proprio brutale orizzonte utilitarista, né del proprio credo eugenetico. «Quando la gente dice che la diagnosi preimpianto è costosa, rispondo sempre: qual è il prezzo di un bambino disabile che nasce? Qual è il costo che ognuno deve sopportare? È un prezzo terribile per tutti, e il costo economico è immenso. Per una diagnosi preimpianto, a confronto, servono davvero pochi soldi». L’eroe della scienza, vincitore del premio Nobel, portatore per definizione di un’alta vocazione umanitaria, colui che ha inaugurato una nuova era della medicina, può permettersi impunemente di parlare come un Mengele. Il grande innominato che ci ha lasciato in eredità un sacco di cloni in incognita.
Cosa significa questo? Significa che, sotto la suggestione del miglioramento della progenie (il che dovrebbe ricordare qualcosa, ma di nuovo il non studiare più la storia serve anche a dimenticare gli orrori del passato), stiamo allegramente consegnando ai signori delle farmaceutiche il controllo di qualità e di quantità sulle nostre vite
Quindi, alla base della legge 40/2004 («norme in materia di procreazione medicalmente assistita)» – per inciso legge voluta e scritta dal mondo cattolico e prolife – e poi alla base dell’ingresso della fecondazione artificiale nei LEA di Stato non vi è di certo la preoccupazione di incentivare le nascite, come qualcuno voleva farci credere, a partire appunto dai cattolici. Peraltro e per inciso, se c’era bisogno di una riprova di come tutti rispondano a un unico richiamo e a interessi convergenti, basti dire che oggi i cosiddetti prolife italiani sono tutti presi a promuovere la bontà dei cosiddetti «vaccini» OGM: e con questo è detto tutto.
La FIVET è subdola perché si presenta al pubblico sotto la maschera della vita (dietro il paravento caritatevole di fornire un bimbo in braccio a chi lo desideri e che, siccome ogni volontà desiderante oggi si tramuta magicamente in diritto, sarebbe titolare del cosiddetto «diritto alla genitorialità»). Ma il suo obiettivo, per chi vede la luna e non si ostina a guardare il dito, è tutt’altro e prevale su tutto: è appunto la desessualizzazione della procreazione, la sua artificializzazione, connessa con la selezione eugenetica della specie, in costanza di libera orgia, purché sterile.
La FIVET in quanto tale – omologa, eterologa, la sostanza non cambia – porta con sé la reificazione e la mercificazione dell’uomo. Esattamente a questo mirano i ministeri che si chiamano della salute, mira la neochiesa, mirano soprattutto le multinazionali del farmaco, i loro scagnozzi e i loro padroni.
E intanto l’uomo, nel silenzio generalizzato, si derubrica a manufatto di precisione, a prodotto industriale come un altro, soggetto alle regole del mercato e alla logica del profitto, diventa un codice a barre. Una monade senza identità, privata persino delle radici di un padre e di una madre, di un grembo e di una famiglia, al di fuori di quella catena che, da che mondo è mondo, lega insieme le generazioni. E che a tutti i costi si vuole spezzare, con conseguenze che nemmeno gli scienziati-stregoni sono in grado di prevedere. Fanno esperimenti, loro.
In cambio dell’illusione di ottenere il figlio perfetto, munito dei connotati scelti da catalogo, liberato a priori da una lista di malattie e affrancato dai rischi connessi alla lotteria della natura (una roulette russa, in fondo), in cambio di questa illusione, siamo disposti a cedere il rubinetto della vita alle multinazionali del farmaco e ai filantropi che le controllano, che potranno accenderlo o spegnerlo a piacimento, e possono condurre impuniti i loro esperimenti eugenetici
Ora la Francia, come sempre all’avanguardia, ha in dirittura di arrivo una legge che consentirà la ricerca senza limiti sulle cellule staminali embrionali umane, la creazione di gameti artificiali, copie di embrioni umani, embrioni chimerici ed embrioni transgenici. Cioè permetterà, di fatto, la trasformazione dell’uomo in un organismo geneticamente modificato, e l’attraversamento della barriera delle specie. Ovviamente, tutto dietro il paravento del progresso medico-scientifico e biotecnologico, per il bene dell’umanità. L’Italia, come sempre, seguirà a ruota.
Secondo una nota genetista francese, Henrion-Caude, c’è un rapporto diretto tra i trattamenti genici sperimentali di massa a mRNA, diffusi a seguito della pandemia da COVID-19, e gli orizzonti spalancati dalla nuova legge francese che liberalizza la manipolazione del DNA degli embrioni. Entrambe sono manovre di chiara matrice transumanista. Dove il transumanesimo diventa una operazione di massa.
Evidentemente, l’obiettivo è controllare il seme della stirpe dell’uomo, il suo codice genetico, il codice della vita.
Quello che stiamo vedendo e vivendo ora non è altro che l’esito cibernetico della hybris antica e il precipitato finale del non serviam, il binomio suicida con cui la creatura, disconoscendo il proprio statuto, addenta il frutto dell’albero della vita.
Il 12 febbraio 1974, giorno del suo arresto cui seguì l’espulsione dalla Russia, fu pubblicata la celebre esortazione di Solženicyn ai suoi compatrioti, intitolata Vivere senza menzogna.
La FIVET è subdola perché si presenta al pubblico sotto la maschera della vita (dietro il paravento caritatevole di fornire un bimbo in braccio a chi lo desideri e che, siccome ogni volontà desiderante oggi si tramuta magicamente in diritto, sarebbe titolare del cosiddetto «diritto alla genitorialità»). Ma il suo obiettivo, per chi vede la luna e non si ostina a guardare il dito, è tutt’altro e prevale su tutto: è appunto la desessualizzazione della procreazione, la sua artificializzazione, connessa con la selezione eugenetica della specie, in costanza di libera orgia, purché sterile.
«Stiamo ormai per toccare il fondo, su tutti noi incombe la più completa rovina spirituale, sta per divampare la morte fisica che incenerirà noi e i nostri figli, e, noi continuiamo a farfugliare con un pavido sorriso: Come potremmo impedirlo? Non ne abbiamo la forza. Siamo a tal punto disumanizzati, che per la modesta zuppa di oggi siamo disposti a sacrificare qualunque principio, la nostra anima, tutti gli sforzi di chi ci ha preceduto, ogni possibilità per i posteri, pur di non disturbare la nostra grama esistenza. Non abbiamo più nessun orgoglio, nessuna fermezza, nessun ardore nel cuore. (…) Davvero non c’è alcuna via d’uscita? E non ci resta se non attendere inerti che qualcosa accada da sé? Ciò che ci sta addosso non si staccherà mai da sé, se continueremo tutti ogni giorno ad accettarlo, ossequiarlo, consolidarlo, se non respingeremo almeno la cosa a cui più è sensibile. Se non respingeremo la menzogna. (…) Ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave che abbiamo trascurato e che pure è tanto semplice e accessibile: il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna. Anche se la menzogna ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili: che non domini per opera mia! (…) Per i giovani che vorranno vivere secondo la verità, all’inizio l’esistenza si farà alquanto complicata: persino le lezioni che si apprendono a scuola sono infatti zeppe di menzogne… Ma per chi voglia essere onesto non c’è scappatoia…: mai, neanche nelle più innocue materie tecniche, si può evitare l’uno o l’altro dei passi che si son descritti, dalla parte della verità o dalla parte della menzogna: dalla parte dell’indipendenza spirituale o dalla parte della servitù dell’anima. E chi non avrà avuto neppure il coraggio di difendere la propria anima non ostenti le sue vedute d’avanguardia, non si vanti d’essere un accademico o un «artista del popolo» o un generale: si dica invece, semplicemente: sono una bestia da soma e un codardo, mi basta stare al caldo a pancia piena. Ma se ci facciamo vincere dalla paura, smettiamo di lamentarci che qualcuno non ci lascerebbe respirare: siamo noi stessi che non ce lo permettiamo. Pieghiamo la schiena ancora di più, aspettiamo dell’altro, e i nostri fratelli biologi faranno maturare i tempi in cui si potranno leggere i nostri pensieri e mutare i nostri geni. Se ancora una volta saremo codardi, vorrà dire che siamo delle nullità, che per noi non c’è speranza, e che a noi si addice il disprezzo di Puskin: A che servono alle mandrie i doni della libertà?».
Solženicyn ha fatto conoscere al mondo i meandri maligni dell’Arcipelago Gulag; ma, insieme a questi, ha fatto conoscere anche i tanti ricoveri spirituali di cui l’arcipelago, nonostante tutto, era disseminato. Perché, proprio là dentro, gli uomini che intendevano mantenere integro il loro cuore potevano trovare la via della salvezza.
La FIVET in quanto tale – omologa, eterologa, la sostanza non cambia – porta con sé la reificazione e la mercificazione dell’uomo. Esattamente a questo mirano i ministeri che si chiamano della salute, mira la neochiesa, mirano soprattutto le multinazionali del farmaco, i loro scagnozzi e i loro padroni.
Non a caso egli titola L’anima e il reticolato la parte della sua opera dedicata alla rinascita spirituale sua e di tanti suoi compagni di prigionia.
Senza volerlo, i reticolati erano divenuti riparo di una terra benedetta, fecondata dai martiri, e fiorita di quel cristianesimo di cui la rivoluzione aveva cancellato sì le tracce, ma senza distruggere la semente.
Oggi i renitenti alla leva della menzogna sono chiamati, ancora una volta, ad uno sforzo che sembra sovrumano.
Ma la pillola rossa una volta inghiottita produce effetti irreversibili e dirompenti: fa saltare fuori dalla società anestetizzata. La cosa ostica e insieme tremenda da digerire è che lo Stato ti vuole male, che lo Stato, al quale tu peraltro versi le tasse, in realtà lavora per il tuo danno. Che la forza di gravità delle istituzioni non tende al bene comune, ma al male comune. Questa prospettiva genera una dissonanza cognitiva insostenibile, che i più rifiutano a priori, perché, per lo meno in prima battuta, getta nella sensazione terribile dell’abbandono.
La cosa ostica e insieme tremenda da digerire è che lo Stato ti vuole male, che lo Stato, al quale tu peraltro versi le tasse, in realtà lavora per il tuo danno. Che la forza di gravità delle istituzioni non tende al bene comune, ma al male comune. Questa prospettiva genera una dissonanza cognitiva insostenibile, che i più rifiutano a priori, perché, per lo meno in prima battuta, getta nella sensazione terribile dell’abbandono
Invece questa prova va affrontata con determinazione.
Innanzitutto con la consapevolezza che abbiamo a che fare con un’Idra dalle molte teste ma da un unico corpo, cioè tanti filoni in apparenza a se stanti fanno capo a un mostro ideologicamente compatto.
Poi con la certezza che la Verità non è quella creata da chi in un dato momento si è conquistato una posizione di supremazia, ma è qualcosa che ci precede e ci resiste, e non si definisce a colpi di maggioranze: la menzogna rimane menzogna anche se la maggioranza la professa e pretende di imporla a tutti come regola di vita.
A noi tocca ogni sforzo per far uscire i nostri figli da questo folle involucro di conformismo e pseudo sicurezza in cui li vogliono ingabbiare per disinnescare la loro vitalità, addestrandoli alla passività cadaverica, smerciando loro in cambio una libertà falsa, del tutto illusoria. In questa sterile sbornia libertaria va risvegliata l’esigenza della trasgressione, che dovrebbe essere peraltro una attitudine congeniale a chi si affaccia alla vita. Va stimolato l’esercizio dello spirito critico sopra ogni regola di cui è preteso il rispetto acritico attraverso un martellamento ossessivo di messaggi di morte e di terrore, e di ricatti e intimidazioni che creano un cupo rumore di fondo.
Dobbiamo fare ogni sforzo per tenere viva nelle nuove generazioni la capacità di elaborare e manifestare un pensiero libero, il che implica la capacità di reggere il dissenso, anche in condizioni di solitudine o di minoranza. Per far questo servono le energie culturali e serve la forza spirituale, interiore, per poter dire: non in mio nome.
Alla dittatura biosecuritaria e ai suoi farmaci transumanisti abbiamo qualcosa di grande da opporre: abbiamo il patrimonio spirituale e la forza del logos di una straordinaria Civiltà, germogliata e sedimentata in questa nostra terra, luogo dell’innesto del cristianesimo nella cultura e nel pensiero dei classici.
Alla dittatura biosecuritaria e ai suoi farmaci transumanisti abbiamo qualcosa di grande da opporre: abbiamo il patrimonio spirituale e la forza del logos di una straordinaria Civiltà, germogliata e sedimentata in questa nostra terra, luogo dell’innesto del cristianesimo nella cultura e nel pensiero dei classici.
Abbiamo l’orgoglio delle nostre radici e della nostra identità, un vincolo materiale, fatto di terra e di sangue, in cui riconoscerci. Abbiamo anche il legame fondato sull’idem sentire, un legame che si stringe nel momento della verità, ed è in grado di generare nuove e feconde alleanze. Abbiamo la nostra coscienza, un bene che nessuno potrà mai imprigionare tra i reticolati, e che dobbiamo tenacemente continuare a nutrire di vera libertà.
Per tutto questo insieme, e soprattutto per la responsabilità che non possiamo non sentire, enorme, verso chi ci succede, ci sarà dato infine anche il coraggio, un’arma grande e benedetta che rende sempre onore a chi la prende con sé.
Elisabetta Frezza
Articolo previamente pubblicato sul sito dell’autrice.
PER APPROFONDIRE
In affiliazione Amazon
Civiltà
Tutti contro lo spot con l’Eucarestia sostituita da una patatina. Ma il vero scandalo è il Concilio e la caduta della civiltà cristiana

Circola da ieri in rete l’indignazione per il nuovo spot pubblicitario di un noto marchio di patatine.
La storia è raccontata con il linguaggio tipico della pubblicità TV: mentre sullo sfondo odiamo la melodia dell’Ave Maria di Schubert, vediamo un gruppo di novizie di un convento che si allinea per ricevere la comunione dalle mani del parroco. Tuttavia, la prima a ricevere l’ostia consacrata si ritrova a masticare una patatina. Scopriamo quindi una suora ai margini del gruppo fa lo stesso direttamente dalla busta.
In pratica, una suora ha sostituito la Santa Eucarestia con delle patatine fritte prodotto industrialmente. La voce fuori capo è di una femmina che con voce languida dice «Il divino quotidiano».
Sostieni Renovatio 21
Il canale YouTube della casa di produzione specializzata in pubblicità, che sul sito dice di essere il marchio di una società a responsabilità limitata con sede in una località termale austriaca, ha caricato il video ieri. Al momento è ancora visibile.
È segnato il nome del regista, Dario Piana, che spiega il linguaggio classico, qualcuno direbbe un po’ antiquato, del filmato: si tratta di uno dei più grandi nomi della pubblicità TV italiana, certo forse conosciuto poco oltre la cerchia dei pubblicitari milanesi e della loro filiera, uno specialista ultrasettantenne con decenni di esperienza fatti negli anni d’oro dell’ascesa delle réclame nelle TV berlusconiane, una firma-garanzia vista per qualche ragione come il pinnacolo cui aspirare per chi vuole fare uno spottone per un’aziendona.
La pubblicità, scrivono i giornali, sarebbe visibile nei canali social dell’azienda, che ricordiamo è nota per aver fatto in passato spot con l’attore pornografico Rocco Siffredi, e polemiche per lo slogan scelto per la campagna pubblicitaria – «la patata tira».
Era inevitabile che i cattolici si incazzassero. Ha chiesto l’immediata sospensione dello spot che «offende la sensibilità religiosa di milioni di cattolici praticanti» una sigla chiamata AIART (Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione), che mai avevamo sentito prima e che dicono sia di ispirazione cattolica.
Secondo l’associazione dei catto-ascoltatori cui sarebbe oltraggioso «banalizzare l’accostamento tra la patatina e la particola consacrata», e si potrebbe parlare di un vero ricorso alla blasfemia: «strappare un applauso ad un pubblico compiacente con riferimenti blasfemi, è degradante per chi fa, o pretende di fare, pubblicità», dicono.
«Ci si appella al politically correct e alla cancel culture, ma solo contro la religione cristiana (ma solo quella) ci si sente autorizzati a qualsiasi obbrobrio?».
Notiamo che siamo davanti ad una posizione moderata. Quanto mostrato è gravissimo: perché la Santa Eucarestia è il centro della religione cristiana, o meglio è Cristo stesso, è Dio stesso.
L’Eucarestia è il miracolo fondamentale della fede cattolica. Insultare la Santa Comunione è offendere la Fede, e direttamente Dio in persona. Quei cattolici che credono si tratti di un atto perfettamente equivalente alla bestemmia, ragionano con logica basica, inevitabile.
Non per scandalizzarci, tuttavia, che scriviamo, aggiungendosi a quanti ora si battono il petto. Ricordiamo che qualche anno fa un gruppo di avvocati denunciò un cantante del concerto dei sindacati – quello del 1° maggio, dove ora si tifa per armi ucraine e vaccini – per aver simulato l’atto di consacrazione dell’Eucarestia con un preservativo – grande provocazione, davvero… se poi un giorno ci spiegano pure perché uno deve rivendicare felice di coprirsi la parte più sensibile del suo corpo con un pezzo di gomma sintetica che per soprammercato lo sterilizza). Non sappiamo quanta strada abbia fatto quella denunzia…
Non è la blasfemia ad essere rilevante qui, ma il come possa, contro ogni logica, essere prodotta. Perché c’è un grosso problema in tutta la storiella dello spot raccontato.
La trama è palesemente incongrua ed irreale, per il motivo semplice che prima di venire data ai fedeli, l’eucarestia viene consacrata. Che vuol dire, perfino nel rito postconciliare, innalzata dal sacerdote che pronuncia le formule necessarie a che avvenga la transustanziazione. Cioè: il prete della finzione pubblicitaria, avrebbe dovuto accorgersi che stava consacrando delle patatine. E nel caso il sacerdote fosse orbo od ubriaco, se ne sarebbero accorti i chierichetti, i fedeli, tutti.
In pratica: chi ha scritto e girato e mandato in giro lo spot, sembra ignorare come funziona una Messa, come funziona la Comunione. Ciò potrebbe includere una discreta quantità di persone che vanno dai geniali pubblicitari che l’hanno pensata, ai committenti che l’hanno accettata, ai produttori, al regista, alle maestranze presenti, agli attori, ai montatori, all’ufficio marketing dell’azienda, etc. Tanta gente. Nessuno a cui sia venuto il dubbio: ma non è che questa storia della pisside piena di patatine non tiene? Non è che qualcuno si può accorgere di questo errore narrativo gigantesco – quello che in gergo cinematografico è chiamato «buco di sceneggiatura»?
Qui, secondo noi, sta il vero scandalo. La società è talmente decristianizzata che pure nella blasfemia non c’è conoscenza della tradizione cattolica che si va a negare, o deridere, o anche solo a criticare. Non hanno idea di come sia fatta, eppure vogliono usare la chiesa cattolica e le sue forme, ci si avvicinano appena possono – un fenomeno che appare chiaro anche nel mondo LGBT, dove alla prima fessura che si apre gli attivisti omotransessualisti si ficcano nelle cattedrali, come visto nel caso di San Patrizio a Nuova York usato per le celebrazioni blasfeme di un transessuale argentino.
Va detto che gli LGBT, tuttavia, hanno in qualche modo presente cosa sia la chiesa, e questo spiega perché ne sono ossessionati. I pubblicitari, invece, non è detto che lo sappiano.
Quindi se non sanno quello che fanno, ci si chiede se si può parlare davvero di intenzioni blasfeme. Ma di questo non ci importa. Rileva realizzare come blasfema sia l’intera società post-cristiana dove, in mancanza di fede e pure di conoscenza basilare, cose come questa posson saltar fuori.
Aiuta Renovatio 21
La causa dell’abisso di bestemmia, sciatteria ed ignoranza in cui è caduta la società umana ha un nome ed un cognome: si chiama Concilio Vaticano II, la più grande catastrofe vissuta dall’umanità negli ultimi secoli, l’alterazione profonda del sistema operativo spirituale e personale di miliardi di persone, con conseguente sabotaggio dell’intera civiltà.
Prima del Concilio, lo scandalo dello spottino patatino era impensabile: non solo perché la gente non avrebbe mai accettato un’offesa del genere, non solo perché non gli sceneggiatori nemmeno l’avrebbero concepita, ma perché quasi tutti erano stati almeno una volta a Messa, e sapevano che l’Ostia, prima di essere distribuita, va consacrata pubblicamente (cosa perfino evidente nel nuovo rito, dove si fa ad populum, cioè rivolti ai fedeli).
Lo scandalo vero, dunque, non è la pubblicità blasfema, ma il Concilio che ci ha portato dove siamo ora, dove l’attacco a Dio pare scritto nel codice stesso dello Stato moderno.
E quindi: cari cattolici, cari telespettatori, cari cittadini sincero-democratici, cari democristiani, cari post-cristiani, avete voluto il Paese laico, adesso beccatevi la patatina ignorante, e tutta la sua filiera di lavoratori intellettuali strapagati.
Avete voluto detronizzare Cristo al punto da accostare il suo corpo ad una patata fritta, al punto da dimenticare perfino il rito centrale degli ultimi millenni; adesso proseguite pure con la cancellazione delle statue con donne che allattano e le vacanze scolastiche pel Ramadan.
Blasfemie a parte, lo scandalo è qui: nella decadenza del consorzio umano, nella caduta della civiltà cristiana.
Roberto Dal Bosco
Immagine screenshot da YouTube
Civiltà
«Vediamo i sommi sacerdoti prostrarsi dinanzi agli idoli infernali del Nuovo Ordine Mondiale»: omelia di mons. Viganò nella Domenica di Pasqua

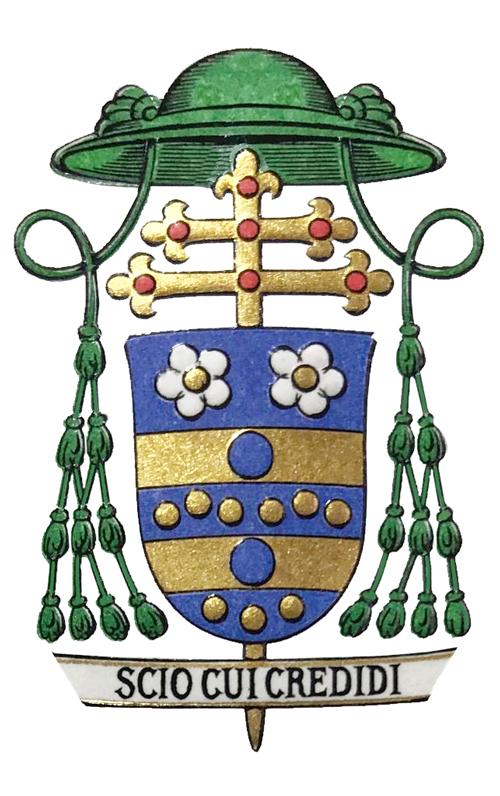
ADHUC TECUM SUM
Omelia nella Domenica di Pasqua
Resurrexi, et adhuc tecum sum. Sono risorto, e sono ancora con te.
Salmo 138
Hæc dies, quam fecit dominus. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Sono le parole che la divina Liturgia ripeterà durante tutta l’Ottava di Pasqua, per celebrare la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, trionfatore della morte. Permettetemi tuttavia di fare un passo indietro, al Sabato Santo, ossia al momento in cui le spoglie del Salvatore giacciono nel Sepolcro senza vita e la Sua anima scende negl’inferi per liberare dal Limbo coloro che morirono sotto l’Antica Legge aspettando il Messia promesso. Una settimana fa il Signore era acclamato Re d’Israele ed entrava trionfalmente in Gerusalemme. Pochi giorni dopo, appena celebrata la Pasqua ebraica, le guardie del tempio Lo arrestavano e con un processo farsa convincevano l’autorità imperiale a metterLo a morte per esserSi proclamato Dio. Abbiamo accompagnato il Signore nel pretorio; abbiamo assistito alla fuga dei Discepoli, alla latitanza degli Apostoli, al rinnegamento di Pietro; Lo abbiamo visto flagellare e coronare di spine; Lo abbiamo visto esposto agli insulti e agli sputi della folla sobillata dal Sinedrio; Lo abbiamo seguito lungo la via che porta al Calvario; abbiamo contemplato la Sua crocifissione, ascoltato le Sue parole sulla Croce, udito il grido con cui spirava; abbiamo visto oscurarsi il cielo, tremare la terra, strapparsi il velo del Tempio; abbiamo pianto con le Pie Donne e San Giovanni la Sua Morte e la deposizione dalla Croce; abbiamo infine osservato la pietra sepolcrale chiudere la Sua tomba e la guarnigione delle guardie del tempio sorvegliare che nessuno vi si avvicinasse per rubarne il corpo e dire che Egli era risorto dai morti. Tutto era già scritto, profetato, annunciato.Sostieni Renovatio 21
Aiuta Renovatio 21
Civiltà
Putin: le élite occidentali si oppongono a tutti i popoli della Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha messo in guardia dai tentativi occidentali di seminare divisione fra le genti russe e dai tentativi di frammentare il suo territorio secondo linee etniche. Lo riporta il sito governativo RT.
Intervenendo alla sessione plenaria del Consiglio internazionale del popolo russo, Putin ha lanciato un appassionato appello alla solidarietà tra i diversi popoli del Paese. Tali sforzi mirano non solo a danneggiare il popolo russo stesso, ma contro tutti i gruppi che compongono il paese, ha dichiarato Putin.
«La russofobia e altre forme di razzismo e neonazismo sono diventate quasi l’ideologia ufficiale delle élite dominanti occidentali. Sono diretti non solo contro i russi, ma contro tutti i popoli della Russia: tartari, ceceni, avari, tuvini, baschiri, buriati, yakuti, osseti, ebrei, ingusci, mari, altaiani. Siamo tanti, non li nominerò tutti adesso, ma, ripeto, questo è diretto contro tutti i popoli della Russia», ha dichiarato il Presidente.
«L’Occidente non ha bisogno di un Paese così grande e multinazionale come la Russia», ha continuato il presidente, aggiungendo che la diversità e l’unità della Russia «semplicemente non si adattano alla logica dei razzisti e dei colonizzatori occidentali».
Sostieni Renovatio 21
Ecco perché, secondo Putin, l’Occidente ha iniziato a suonare «la vecchia melodia» di chiamare la Russia una «prigione di nazioni», descrivendo il popolo russo come «schiavi» e arrivando addirittura a chiedere la «decolonizzazione» della Russia.
«Abbiamo già sentito tutto questo», ha detto, aggiungendo che ciò che gli oppositori della Russia vogliono veramente è smembrare e saccheggiare il paese, se non con la forza, almeno seminando discordia all’interno dei suoi confini.
Putin ha continuato avvertendo che qualsiasi interferenza esterna o provocazione volta a provocare conflitti etnici o religiosi nel Paese sarà considerata un «atto aggressivo» e un tentativo di utilizzare ancora una volta il terrorismo e l’estremismo come strumento per combattere la Russia.
«Reagiremo di conseguenza», ha dichiarato.
Il presidente ha sottolineato che l’attuale lotta della Russia per la sovranità e la giustizia è «senza esagerazione» di «natura di liberazione nazionale» perché è una lotta per la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini.
Putin ha anche osservato che il popolo russo, come già fatto in passato, è diventato ancora una volta un ostacolo per coloro che lottano per il dominio globale e cercano di portare avanti la loro «eccezionalità».
«Oggi lottiamo non solo per la libertà della Russia, ma per la libertà del mondo intero», ha detto il presidente, precisando che Mosca è ora «in prima linea nella creazione di un ordine mondiale più equo» e che «senza un governo sovrano, una Russia forte, non è possibile alcun ordine mondiale duraturo e stabile».
Come riportato da Renovatio 21, all’ultima edizione del Club Valdai Putin aveva tenuto un denso discorso dove lasciava intendere una concezione della Russia come Stato-civiltà.
Riguardo alle élite occidentali, parlando di forniture di gas, il presidente russo aveva lamentato due mesi fa la mancanza di «persone intelligenti». Considerando le bollette, è davvero difficile dargli qui torto.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di President of Russia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
-



 Pensiero2 settimane fa
Pensiero2 settimane faLa giovenca rossa dell’anticristo è arrivata a Gerusalemme
-



 Cervello1 settimana fa
Cervello1 settimana fa«La proteina spike è un’arma biologica contro il cervello». Il COVID come guerra alla mente umana, riprogrammata in «modalità zombie»
-



 Scuola2 settimane fa
Scuola2 settimane faDal ricatto del vaccino genico alla scuola digitalizzata: intervento di Elisabetta Frezza al convegno su Guareschi
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori della 15ª settimana 2024
-



 Cina2 settimane fa
Cina2 settimane faVescovi e preti cattolici cinesi imprigionati e torturati, chiese e croci demolite con l’accordo sino-vaticano
-



 Vaccini2 settimane fa
Vaccini2 settimane faVaccini contro l’influenza aviaria «pronti per la produzione di massa». Un altro virus fuggito da un laboratorio Gain of Function?
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane faBergoglio sta «ridimensionando» il papato: parla mons. Viganò
-



 Salute5 giorni fa
Salute5 giorni faI malori della 16ª settimana 2024











