Pensiero
Generale di quell’esercito che ha vaccinato la popolazione e armato l’Ucraina critica i gay: idolo istantaneo degli antisistema da Telegram

Impazziti per il generale. Tutti. Alla sinistra non è sembrato vero di poter trovare un bersaglio da linciare con tiro di pietre arcobaleno, oramai non se ne trovano più; il governo non si è fatto sfuggire l’occasione di fare un ulteriore inchino a Sodoma, rimuovendo il militare, non si sa quanto lecitamente; i giornali, di ambo i versanti della valle italica, tripudianti per una storia che finalmente crea interesse nel nulla mediatico estivo.
Lo spettacolo peggiore, tuttavia, lo offre la dissidenza antisistema – nel senso, quella che dice di opporsi al mainstream, all’obbligo di vaccinazione, di gender, di ucrainofilia, la vasta popolazione della dissidenza che si trova sui canali Telegram e le chat Whatsapp, quella che, dosata di dopamina ad ogni scrollata, si indigna e chiede il cambiamento in questo mondo di menzogna.
Ecco orde di no-greenpassisti, di telegrammatori antisistemici in solluchero per quello che passa e dice, in un libro autopubblicato, una cosa critica dei gay. Un partito chiede addirittura al militare di candidarsi alle elezioni per il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi. Idolo istantaneo. «Santo subito».
Che dire, sarà il fascino della divisa. Il generale Vannacci, tre lauree e due master in materia di scienza strategica, non è un personaggio di secondo piano. Pochi giorni prima del Natale 2017, compare in un messaggio del presidente Mattarella, videocollegato dall’Iraq, dove il generale addestrava le truppe irachene: «la sconfitta di Daesh è un grande risultato, ottenuto anche con l’importante contributo dell’Italia», dice il canuto capo dello Stato. «Daesh» è il modo in cui quelli bravi chiamano l’ISIS. In pratica il generale ha condotto la battaglia contro lo Stato Islamico e ha vinto, dice il presidente della Repubblica.
Era tenente quando tra il 1992 e il 1994 partecipava alla Missione Ibis, in Somalia – una storia controversa con polemiche roventi, bufale, scoop, scandali, scuse che nessuno tuttavia ricorda. Tutto rientrato.
Incursore, diviene, da maggiore, capo del Battaglione, quindi capo delle Forze Speciali dell’Allied Rapid Reaction Corps della NATO. Elabora una dottrina interforze per le Operazioni speciali, leggiamo sull’ottimo profilo che qualche giorno fa ne ha dato La Verità.
Nel 2009 è a Kabul come assistente del capo di Stato maggiore che su mandato del Consiglio di Sicurezza ONU deve sorvegliare la capitale afghana. Qui lavora a stretto contatto con Stanley McChrystal, il generale che in un’intervista su Rolling Stone nel 2010 criticò Obama, venendo poi rimosso. Il giornalista, invece, morì non troppo tempo dopo in un incidente d’auto difficilmente spiegabile, che lasciò tanti dubbi ai soliti cospirazionisti. (La storia di McChrystal è raccontata nel film con Brad Pitt War Machine, dove tuttavia il destino di Hastings non è toccato nemmeno con un bastone.)
A Herat e Farah, tra le enigmatiche ed esiziali lande afghane, il generale italiano coordina la Task Force 45, dove comanda la lotta agli insorti.
Nel 2011, quando scoppia la cosiddetta «Primavera Araba», è inviato dallo Stato maggiore in Libia per proteggere i diplomatici italiani, di cui, ricevuto l’ordine, dispone l’evacuazione in maniera impeccabile con un C-130 dell’aeronautica militare italiana.
Quindi, torna in Afghanistan per la NATO come capo di Stato maggiore delle Forze Speciali: gli americani lo premieranno con una Bronze Star Medal per «atti di eroismo o di servizio meritevole in zone di combattimento».
Tornato in Italia, la carriera continua in modo irresistibile: eccolo a capo del 9° Reggimento d’assalto Col Moschin, poi si occupa di relazioni militari internazionale negli uffici dello Stato maggiore; promosso a generale di Brigata viene messo a capo della Folgore, dove rompe la tradizione e invece di rimanere in silenzio nel giorno dell’insediamento, come usa, tiene un discorso. Dopo la Folgore, l’Iraq e l’ISIS, pardon, «Daesh».
Nel 2020 è a Mosca dove gli è affidata la sicurezza della diplomazia italiana. Nel 2022, riporta sempre La Verità, nelle prime fasi del conflitto, l’Italia espelle diplomatici russi operanti sul territorio nazionale; la Russia reagisce in modo speculare: anche Vannacci, ora generale di divisione, è dichiarato «persona non gradita» dal Cremlino.
Leggendo questo curriculum, del quale abbiamo saltato sicuramente moltissimo, viene voglia solo di togliersi il cappello: questa è una carriera con i fiocchi, questo è un guerriero servitore dello Stato fatto e finito.
Se poi ci si mette anche il fatto che il nostro si è distinto per denunce vere e proprie a difesa dei suoi uomini, si potrebbe pure far scattare, davvero, la standing ovation. Leggiamo infatti che tornato dall’Iraq avrebbe presentato «due denunce, una alla Procura militare e l’altra alla Procura della Repubblica di Roma, nelle quali denuncia «gravi» e «ripetute omissioni» nella tutela della salute del contingente italiano, esposto, stando alla sua versione, ai rischi dell’uranio impoverito usato per le munizioni e mettendosi di traverso al ministero della Difesa, che aveva assunto una posizione decisamente opposta», scrive il quotidiano milanese.
Ci vuole un certo eroismo, sì: difendere i propri uomini (e, possibilmente, la loro progenie…) davanti all’Istituzione non è da tutti.
Tuttavia, qui ci parte un campanellino… Ci sembra che, negli anni, si sia sviluppata una certa vulgata, anche piuttosto pubblicizzata dalle Commissioni Parlamentari di Inchiesta, sul ruolo che sulla salute dei soldati avrebbero avuto i vaccini.
Non è che ce lo sogniamo, la questione è perfino nel nome: «Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni Relazione sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela previdenziale nelle forze armate».
La storia, di cui non ha il monopolio l’Italia (pensiamo agli USA, e alla questione dei vaccini sperimentali antiantrace, e oltre) fa venire in mente la ripugnante idea che, come sempre, i nostri soldati vengano utilizzati come carne da cannone – e carne da siringa.
Tuttavia, al di là di queste valutazioni, possibile che la questione dei vaccini militari nel contesto dell’uranio non sia arrivata al generale?
Non sappiamo. Tuttavia nel libro autopubblicato, vi è un passaggio che fa pensare al fatto che il generale forse non vede di buon occhio chi critica i sieri inoculati alla popolazione.
Nel primo capitolo, intitolato, «Il Buonsenso» (con la maiuscola) leggiamo che «il riferirsi a sé stessi [sic] è una delle caratteristiche dei tempi moderni che ha mosso i suoi primi timidi passi, probabilmente, da quando Cartesio ha pronunciato il fatidico anatema “Cogito ergo sum“».
I limiti di questa tendenza cartesiana individuata dal generale vengono subito spiegati: «diventa difficile da sostenere quando ci riferiamo solo e unicamente a noi stessi senza tener conto di alcun altro, di quelli che ci hanno preceduto, della società, della maggioranza e mettiamo in dubbio anche quello che dovrebbe essere ormai palesemente considerato come acquisito». (Il corsivo qui è nostro)
Quindi l’invettiva:
«Ecco, allora, che la terra ritorna a essere piatta, che la NASA ha inscenato un teatrino spaziale per farci credere che l’uomo abbia passeggiato sul suolo lunare, che i vaccini diventano vettori per microchip al fine di controllare in senso orwelliano la nostra esistenza, che il virus del COVID non esiste, che i galli, ogni tanto, fanno le uova e che non conta se sono un uomo barbuto, muscoloso e dalla pelle olivastra, ma se mi percepisco come una donna bionda, esile e bisognosa di protezione tutti mi devono raffigurare in tale maniera ed, in primis, i miei documenti d’identità!». (anche qui il corsivo è nostro)
In sintesi: molti lettori di questo sito, pur non considerando che i vaccini contengano chip (con la penuria che c’è, causa Taiwan, poi) vengono accomunati a coloro che non credono allo sbarco sulla luna (cioè, a pochi metri dal terrapiattismo, vien da pensare), e a categorie come quella dei nerboruti levantini che si sentono ragazze nordiche e perfino, questa davvero ci mancava, a coloro che credono che i galli fanno le uova». (Ci sono? Chi sono? Hanno un’associazione? Hanno un sito? Una newslettera a cui iscriversi?).
Vorremmo dire: se non si è capito che è un mondo di sorveglianza più che orwelliana quello che si sta dipanando sotto i nostri occhi, probabilmente c’è da fare una diagnosi consistente di prosciutto oftalmico. Così come non comprendere che proprio i vaccini hanno introdotto un sistema di controllo – tramite chip, sì: quelli dei telefonini – ci lascia basiti. In questo libro auto-edito nel 2023, la parola green pass in effetti non ricorre nemmeno una volta.
Ora: qualcuno ha detto che le frasi su gay, immigrazione e di involuzione della società civile contenute nel libro, più che inopportune, sono di grande superficialità. Si può essere d’accordo: a leggere i passaggi incriminati, pare di vedere le reazioni di qualcuno che ha appena scoperto tali fenomeni, e non abbia davvero idea di quanto essi siano radicati non solo nella società, ma nello stesso Stato che il militare serve.
Il privilegio istituzionale omosessuale è stato letto da alcuni come materia di fatto già codificata con lo stralcio dell’obbligo di fedeltà nella legge Cirinnà: in pratica, a differenza degli eterosessuali che sono sottoposti, anche se «sposati» in Comune, all’obbligo di non tradire, nelle unioni gay le corna sono libere. E questa non è un’opinione politica: è legge della Repubblica Italiana. E questo è solo uno degli esempi possibili.
Il discorso sulla pallavolista di origine nigeriana Egonu (che, aggiungiamo noi, offre in combo anche il coming out fatto sul Corriere nel 2018: è stata con un’altra atleta, per poi però dirigersi su un altro atleta, senza apostrofo, maschio) è anche quello un po’ stucchevole: «anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e le statue che dagli etruschi sono giunti ai giorni nostri». Chi scrive una cosa del genere non ha mai sentito parlare di Piano Kalergi, né probabilmente si è reso conto che lo sforzo di africanizzare l’Europa è visibilmente portato avanti dagli Stati stessi.
Vi è quindi un passaggio sugli «occupatori abusivi ed i ladri di case», i quali sono «più tutelati dei loro legittimi proprietari». Una posizione pure condivisibile (anche se avvocati del settore ci dicono essere, nella maggior parte dei casi, meno irrisolvibile di quanto si creda), ma che ci fa scattare il pensiero definitivo: ma con tutti i problemi apocalittici davanti a noi, e nel piccolo di milioni di casi, con l’angoscia di non arrivare a fine mese delle partite IVA e dei dipendenti non garantiti (cioè, non statali), dobbiamo davvero metterci a pensare a chi ha due o tre case?
Siamo, decisamente, dalle parti dei discorsi della media borghesia conservatrice (quella benestante, benpensante, quella del «Buonsenso», con la maiuscola), in zona Feltri, Libero, etc. – che di fatto hanno abboccato subito.
A questo punto ci viene da ricordare che in Italia, come in altri Paesi, il programma di vaccinazione di massa è stato realizzato dai militari, con il comando dell’indimenticabile generale Figliuolo. Si tratta proprio dello stesso esercito in cui serve il Vannacci. I militari, che esistono grazie alla Costituzione italiana (il Giappone, in teoria, non ne ha: e per costituzione) hanno quindi lasciato tranquilli che essa venisse violata in quantità di articoli. Anzi, ci ricordiamo pure di quando, in un momento magico, il direttore di un giornale dell’oligarcato industrial-finanziario, compenetrato totalmente con l’establishment e la sinistra, chiese una sorta di golpe militare vaccinale.
E ci viene in mente pure che l’Ucraina, in questo momento, è armata con estrema generosità dall’Italia, che si è privata perfino di sistemi antiaerei (i SAMP-T) senza i quali ora siamo vulnerabili e che non si è capito bene con quale velocità saranno rimpiazzati.
Non so come la pensano i vertici militari, tuttavia in molti ritengono che armare l’Ucraina, con lo spettacolo osceno dei video finiti in rete carri e dei cannoni fermi nelle stazioni ferroviarie, abbia un microscopico effetto collaterale: apra alla possibilità di una guerra termonucleare.
Sappiamo che non tutti i decisori dell’esercito sono d’accordo: lo strano caso dei trasporti di carrarmati fermati e multati in autostrada in Campania (!) ci avevano fatto pensare a qualche malumore interno alle forze armate.
Tuttavia, ad eccezione del generale Mini, che è in pensione e la dice tutta, non ci pare di aver visto altri casi in cui un soldato, cioè un uomo che tecnicamente vive per difendere la patria e i compatrioti, abbia alzato la mano per dire: «è una follia, ci stiamo esponendo al rischio di una Terza Guerra Mondiale combattuta con le atomiche».
È possibile eseguire un ordine senza protestare, se si sospetta che esso possa ingenerare il genocidio dello stesso popolo che si deve difendere?
È possibile servire un comando che può portare alla devastazione definitiva della terra che si è giurati di proteggere? Qui si entra nella parte più abissale della riflessione che vogliamo fare, che accomuna i sieri mRNA e le atomiche, e va molto al di là del caso del generale.
Sì, una tale follia è possibile a causa della struttura stessa dello Stato moderno. Nella sua concezione sorta più o meno duecento anni fa, tuttora inflittaci, lo Stato va obbedito a prescindere, in quanto deposito di ideali (ideali, non persone), concetti e contenuti talvolta confusamente raffazzonati.
«Forse ingenuamente ed illudendomi un po’ – scrive nel suo libro il generale Vannacci – ritengo che nelle mie vene scorra una goccia del sangue di Enea, di Romolo, di Giulio Cesare, di Dante, di Fibonacci, di Giovanni dalle Bande Nere e di Lorenzo de Medici, di Leonardo da Vinci, di Michelangelo e di Galileo, di Paolo Ruffini, di Mazzini e di Garibaldi».
La vertigine della lista, diciamo un po’ eterogenea, è notevole, e riattiva nel cinefilo che è in tutti noi all’apologia del Made in Italy contenuta nel polpettone dei Fratelli Taviani Good Morning Babilonia (1987): «queste mani hanno restaurato le cattedrali di Pisa e Lucca, Firenze» diceva, in una scena di kitsch assoluto, un immigrato nostrano nella Hollywood dei primordi, dinanzi agli insulti italofobi di un tizio a caso. «Di chi sei figlio tu? Noi siamo i figli dei figli dei figli di Michelangelo e Leonardo». (Quindi apprendiamo che i due grandi artisti non erano gay, con grande sollievo di taluni)
Bene, ma nell’elenco mistico-patriottico del generale ci sono anche, e soprattutto, Mazzini e Garibaldi. Sì, loro: il terrorista massone morto latitante come un Bin Laden qualsiasi (come si può morire da ricercati, e poi ricevere l’onore della toponomastica ancora persistente, è un mistero che ci spiegheranno un giorno, forse, a Londra, o forse a Livorno) e il ladro di cavalli, massone anche lui, che nonostante l’orecchio mozzato (era la punizione sudamericana per l’abigeato) e la passione per la giovane Anita (quanti anni aveva?), ha fatto carriera, come anche i figli suoi – chiedete, magari, ai correntisti della Banca Romana, lo scandalo Etruria dell’Ottocento, partito praticamente nell’immediatezza dell’Italia Unita.
La Nazione creata dai grembiulisti Mazzini e Garibaldi non era costituita da persone – gli italiani, a detta dello stesso Cavour, erano ancora da farsi – ma da concetti astrusi, nonché dai loro ideali massonici e dai loro traffici.
La Nazione, quindi, non era fatta, come dovrebbe suggerire l’etimo, dei nati. Anzi, alla nuova Nazione, al nuovo Stato, dei nati non sarebbe fregato niente: carne da cannone per guerre inutili prima, poi, inoltrandoci nel XX secolo, ecco il genocidio dei non-nati istituito per legge dallo Stato stesso.
In pratica, lo Stato moderno non difende la vita: esso è una struttura inorganica, una macchina, che agisce secondo il software che le si immette. Talvolta il programma è ancora quello dei massoni di due secoli fa, talaltra si sono innestate linee di comando nuove, e ancora più distruttive.
Ecco che, tra il XX e il XXI secolo, lo Stato moderno è divenuto definitivamente una macchina di morte: aborti, provette, eutanasie, contraccezioni, psicodroghe, predazione degli organi e vaccini ce lo dicevano apertamente da decenni. Ora si è aggiunta, grazie alla follia ucraina, anche la minaccia dell’annientamento dell’atomo.
In tutti questi casi, è sensibile più che mai il fatto che è la Necrocultura a guidare lo Stato e il super-Stato che lo contiene e lo informa, sia esso la UE o la NATO o chissà quale consesso occulto informi le decisioni che ricadono sulle nostre misere esistenze.
Lo Stato moderno è lo Stato della morte.
La domanda è: possibile davvero servirlo, anche quando il suo pungiglione diviene evidente?
Qual è la vera patria da proteggere? È un’insalata di nomi storici di artisti e scienziati e tizi vari, è l’accumulo dei monumenti, è la lingua (che in forme varie era parlata anche a Malta e in Isvizzera, dove Mazzini mai ha pensato annettere nulla, mentre Nizza è stata donata tranquillamente ai francesi, mentre Istria e Dalmazia, pochi anni fa, sono state semplicemente dimenticate), è l’ideale nazionale fatto della pastasciutta, dei musei, della squadra di calcio, del buon vino, della moda (fatta da stilisti gay, spesso), dei residui archeologici, degli gnocchi, delle auto sportive, della TV, del ragù… di cosa?
Peraltro quanto elencato dall’ ingenuo impulso nazionalista, dobbiamo aprire gli occhi, non solo non è eterno: è ora sotto la diretta minaccia della distruzione termonucleare, della cancellazione dal piano dell’esistenza pura e semplice: il fatto, quindi, che per chi si dica nazionalista non sia una priorità – anzi lavori in senso opposto – è un pensiero che dà sgomento.
E quindi, ancora, cos’è la patria? Cos’è che dobbiamo davvero proteggere?
La patria, o ancora meglio la madrepatria, è fatta, già nella parola, di qualcosa di assai immediato e di ben poco ideale: il padre, la madre. La generazione di esseri umani, i nati, costituisce la Nazione.
Materialmente: queste non sono idee, astrazioni sono fatti – sono vite umane.
Qualcuno ha detto che il patriottismo è la difesa della legge naturale. Forse, ma crediamo che sia ancora un’astrazione che non rappresenti la realtà ultima di ciò che dovrebbe proteggere lo Stato.
La vera madrepatria – riascoltate la parola, ancora una volta – non può che essere la vita. Il senso ultimo dello Stato non dovrebbe essere altro se non la protezione e la moltiplicazione della vita umana.
L’unica vera patria è la Vita. L’unico vero patriottismo è quello verso il Dio vivente.
Tale pensiero, speriamo di avervelo fatto capire, è totalmente opposto alla realtà dello Stato moderno, e quindi sconosciuto ai suoi servitori.
Ora possiamo capire come sia possibile che i militari eseguano la vaccinazione genica sperimentale di massa della popolazione che dovrebbero difendere.
Ora possiamo capire come sia possibile che i militari espongano il popolo che dovrebbero proteggere – e perfino la terra, i monumenti, i palazzi, le opere d’arte, i paesaggi – al rischio concreto di annichilazione nucleare.
E quindi, sceglietevi gli eroi antisistema che volete, lasciatevi risucchiare dalla sindrome da cartellone del momento, fate pure scroll su Telegram in cerca di eccitazione, di indignazione dopaminica. Ne avete diritto: la superficialità non è proibita dalla legge, anzi.
Ma rammentatelo sempre: il sistema ed i suoi uomini, in ultima analisi, non lavorano per la vostra vita, né quella dei vostri figli. Mai.
Solo uno Stato nato dalla fine dello Stato moderno, uno Stato rifondato nella sua profondità, basato sulla continuazione dell’essere umano, potrà farlo.
Non sappiamo se lo vedremo mai. Ma è ciò a cui dobbiamo tendere con tutte le forze che ci rimangono.
Roberto Dal Bosco
Immagine di pubblico dominio CC0 via Wikimedia; modificata con taglio e ricolorazione.
Pensiero
Renovatio 21 saluta Giorgio Armani. Dopo di lui, il vuoto che inghiottirà Milano e l’Italia

È morto quello che si può definire il più grande stilista vivente, e al contempo un gigante, imprenditoriale e finanche morale, dell’Italia moderna e della sua immagine. È il caso di dire pure, cercando di dimostrarlo nelle prossime righe, che la sua morte apre gli occhi su un vuoto pericoloso che potrà inghiottirsi la moda, Milano, l’Italia.
Quindi non scriviamo il solito coccodrillo, per quello ci sono gli altri giornali, anche internazionali. Vogliamo salutare Giorgio Armani con alcuni flash personali che testimoniano come la sua semplice grandezza era tale che, anche senza conoscerlo di persona, ha attraversato giocoforza le nostre vite.
Le testimonianze che posso raccogliere sono tante: ho un amico di ottant’anni, praticamente spesi tutti nella moda, che mi racconta che sì, vero, faceva il vetrinista alla Rinascente, lo aveva conosciuto così, fino a che non era arrivato a scoprirlo il biellese Nino Cerruti (1930-2022). Ho in testa altre storie che mi arrivavano da amici di famiglia che lo avevano conosciuto, sempre lavorando nel tessile, agli albori, quando passava per Valdagno. Impossibile verificare: sono tutti morti, e quelle storie sono andate via con loro…
Sostieni Renovatio 21
Un primo flash: ho diciannove anni, e ho messo via i soldi per comprare un completo Armani (di brand minore dell’impero, certo, non «Le Collezioni»), con il quale, non solo nelle occasioni importanti, rifiutare il conformismo coetaneo di t-shirt e scarpe da ginnastica. Ricordo la sensazione di appagamento che dava quel vestito, come cascava bene sulle spalle, sui fianchi, ricordo come mi piaceva indossarlo anche con una maglia a maniche corte sotto, con le braccia accarezzate dal fodero in seta.
L’eleganza era possibile. Era diffusa, distribuita. Un’eleganza che non era ostentosa. Era decisa, precisa. Era reale.
Un secondo flash: decido di prendere un altro vestito Armani per appagare il mio desiderio di arrivare al matrimonio di mia sorella, in centro all’Africa, con un completo bianco, come Klaus Kinski nella giungla amazzonica di Fitzcarraldo. Il piano ebbe un effetto collaterale: l’aereo da Londra tardò enormemente su Johanessburg, facendomi perdere la coincidenza per Livingstone, e inserendo uno stop imprevisto in un hotel della città più violenta del mondo. Quando uscii dalla porta del ritiro bagagli dell’aeroporto sudafricano mi ritrovai di fronte ad una muraglia umana di autoctoni nerissimi (più un albino, epperò geneticamente nero anche lui) che aspettano un turista straniero a caso per spennarlo portandogli la valigia: si videro innanzi l’icona di un colonizzatore in abiti firmati, non ci credettero, e mi inseguirono per tutta l’aviosuperficie per un’oretta buona. (Storia da raccontare un’altra volta)
Vi fu poi la festa notturna delle nozze di mia sorella, dove partecipava una varietà impressionante di personaggi, tra cui uno zoccolo durissimo di allevatori di crocodilus niloticus, una delle attività della zona. Uno in particolare, che si era presentato non esattamente elegantissimo e a cui certo inizialmente non stavo simpatico, cominciò a chiamarmi «Armani», come fosse un insulto. Bizzarro: avevo, sì, un ulteriore abito armaniano, quindi aveva indovinato, al contempo nella sua zoticheria esibita stava di fatto ammettendo che il vertice della monda mondiale era anche per lui, farmer di coccodrilli dello Zambia, Giorgio Armani. (Se non credete che esista, ho una foto di quest’uomo paonazzo a tavola con quella che sarebbe divenuta la moglie di un sindaco di una grande città del Nord Italia, purtroppo mancata mesi fa. Ciao, A.)
Ricordo antico: ho si è no sei anni, i miei genitori mi porta in vacanza a Pantelleria, allora non ancora luogo di jet-set euroamericano ed architetti omosessuali, ma isola selvaggia tra mare blu, segni di attività vulcanica e tombe fenicie che spuntavano in mezzo ai boschi. C’era un posto, chiamato arco dell’elefante, dove una colata lavica copiosa e antichissima si era solidificata gettandosi in mare e creando, appunto, l’immagine di una proboscide. Lì vicino, una nave affondata a pochi metri dalla riva, dalla quale giovani facevano tuffi acrobatici. Per arrivarci si scendeva un pendìo scoseso, tra le terre brulle tipiche dell’isola.
È lì che appariva, d’un tratto, una casetta stupenda. Non era enorme, non era una reggia, eppure sprigionava un tale buon gusto – che mai cadeva nello sforzo – che era leggibile persino a me, bambino piccolo: vedevo che aveva il giardino a prato inglese, cioè aveva l’erba verde a differenza del resto del giallo pantesco, in un’isola dove l’acqua, mi raccontavano, arrivava in nave – e non si poteva bere dal rubinetto. Lui probabilmente, mi diceva mio padre, utilizzava quella del mare, fatta risalire sulla scogliera e ripulita con l’osmosi… un esempio, anche qui, più che di lusso, di gusto e ingegnosità, di organizzazione.
Anni dopo ricordo un’apparizione dell’uomo a pochi metri da me: oramai due decadi fa, erano gli ultimi anni della fabbrica di famiglia, e amici che erano già fornitori del gruppo ci avevano combinato un breve appuntamento con qualcuno delle vendite… avevamo escogitato dei braccialetti eccezionali oro e schiena di coccodrillo (fornito da mia sorella, che allora viveva presso il più grande allevamento di niloticus al mondo, in Zambia).
Dall’incontro con la gentile signora che ci accolse non cavammo nulla, tuttavia ricordo con nitore quando appena fuori dalla sede del gruppo in via Borgonuovo comparve una manipolo di persone (bodyguard? Collaboratori? Troppo veloci per capire) con al centro lui, piccolino, ma con il passo rapidissimo, e questa chioma canuta luminescente da aristocratico ricchissimo… Non trasmetteva, tuttavia, le vibrazioni che davano gli aristocratici e i ricchissimi, anzi: era, in chiarezza, uno che stava facendo delle cose.
A dire il vero, Armani di persona lo aveva già veduto: quando ancora esisteva il cinema in centro a Milano, c’era in corso Vittorio Emanuele, nella galleria dove era anche Palazzo Colla, una sala chiamata Pasquirolo. Lì si poteva intravedere in tranquillità Armani il mercoledì, nel giorno del cinema a prezzo scontato. Più avanti, lo avrei rivisto, sempre senza gorilli e bodyguardie varie, in un cinema sopravvissuto all’olocausto delle sale attorno al Duomo, l’Eliseo: si accompagnava con una donna tra i quaranta e i cinquanta chissà da che Paese, bellissima, elegantissima, che sorrideva come lui.
Al cinema, alla storia del cinema, lui aveva partecipato attivamente, vestendo i personaggi indimenticabili dei maestri cineasti di Nuova York (American Gigolo di Paul Schrader, poi tanto Scorsese, che gli dedicò un documentario introvabile, Made in Milan), eppure eccotelo lì, che andava ritualmente al cinematografo il mercoledì, come tanti, come tutti.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Tutto questo per dire: non solo era una persona concreta, umana, ma era un milanese. E qui si innesta un discorso meno personale, e più serio, se non terrificante.
Armani, piacentino, era in realtà il milanese quintessenziale, l’uomo che amava Milano, la conosceva, la aiutava, non vi fuggiva, mai.
Lo proposero brevemente come sindaco, ma lui – che di fatto andava d’accordo con tutti – non accettò. Il suo senso civico si espresse, se posso dire, con la sponsorizzazione della squadra basket di Milano, dove lo vedevi tifare in prima fila tutte le domeniche di campionato. Capito: non scappava, nel weekend, ma stava con il popolo urlante a tifare per la squadra della città. Facciamo i conti – in diciassette anni come proprietario dell’Olimpia, Armani ha conquistato quindici trofei: sei campionati, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane. Un vincente. Con la città che vince con lui.
Mi rammento poi di quando riaprirono, dopo tanti lavori, il Piccolo Teatro di Milano. Il suo dominus, il celebratissimo Giorgio Strehler, era morto da poco, era probabilmente attorno al 1997. Tra i VIP convenuti al vernissage, la TV intervistò Armani, che disse che gli pareva che ci fosse solo una persona che mancava… comprendevo quindi che Armani conosceva, frequentava pure Strehler – elementi della scena milanese che hanno attraversato tante ere, gli anni di piombo, i socialisti craxiani, la «Milano da bere» tangentopoli, lavorando e sopravvivendovi, e prosperandovi.
La milanesità vissuta integralmente. La comparazione con il presente è terrificante: qualche tempo fa emerse che, durante un podcast, Fedez – personaggio forse egemone della scena «culturale» milanese attuale – non sapeva chi fosse Strehler, quasi non avesse mai preso la metrò, dove il nome del regista è stampigliato sempre vicino alla fermata Lanza (Piccolo Teatro).
Il vuoto per Milano è anche di altro tipo. La moda dopo Armani, cosa sarà? Beh, lo sappiamo. Negli anni, quando la città ha finito per identificarsi sempre più con la fashion week, gli «stilisti» hanno portato, con le loro perversioni di ogni livello, un mondo di degrado e di disperazione – se non di Necrocultura vera e propria – sotto la Madonnina. Si tratta di un argomento su cui ho dovuto ragionare, specie guardando la quantità di amiche che sono state di fatto sterilizzate dal sistema della moda, degenerato in modo invincibile negli ultimi 25 anni. (Ne scriverò più avanti)
Armani, al contrario dei «colleghi» che ora calcano le scene, non ha mai imposto le sue inclinazioni agli altri, non ne ha fatto spettacolo, notizia, rivendicazioni estetica o politica. Viveva con l0understatement di chi lavora davvero, e non perde tempo come i traffici.
Come quando, sempre negli anni Novanta, le forze dell’ordine di Parigi bloccarono una sua sfilata a Saint-Germanin-des-Pres, cuore della capitale francese che aveva perso concretamente lo scettro di regina del modismo: «Armani go home» gridavano frotte di sciovinisti francesi mentre davanti a loro si consumava lo spettacolo di modelle in ghingheri fermate da gendarmi. Non fece un plissé, si rifiutò di dare la colpa alla polizia, che eseguiva ordini dall’alto della Prefettura di Parigi (dove, immaginiamo, abbia la tessera della massoneria anche quello che pulisce i pavimenti).
Aiuta Renovatio 21
La cifra dell’italianità nell’impresa: ecco, gestire tutto in famiglia, circondato da nipoti, è già un capolavoro, e se aggiungiamo la resistenza alla lusinga dei megagruppi transalpini (Arnault-Pinault) capiamo che siamo oltre, siamo davanti ad un esempio da scolpire nel marmo milanese, quello non occupato dalle bombolette dei graffitari leoncavallari o dalle orine dei maranza, se ne è rimasto.
La morte di Giorgio Armani non solo priva il mondo del suo equilibrio, ma va letto come ennesimo episodio dell’imbarbarimento di Milano: che siano ragazzini criminali marocchini o stilisti gay, il vuoto che stiamo vedendo crearsi, in mancanza di esempi e di virtù, minaccia di inghiottirsi tutta la metropoli, e poi, come sempre, il resto d’Italia, ridotta a bolo dell’anarco-tirannia.
La soluzione, abbiamo cercato di dirlo tante volte su Renovatio 21, non può essere che il ritorno ad Ambrogio, il santo che scacciò gli eretici e unì la città – il santo che probabilmente ancora oggi la protegge dalla sua distruzione definitiva, mentre anche gli ultimi pezzi della Milano per bene, la Milano bella, elegante, benevola se ne vanno senza poter essere sostituiti.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Bruno Cordioli via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Bizzarria
Ecco la catena alberghiera dell’ultranazionalismo revisionista giapponese

 Anzi, le stanze dispongono del «bottone buonanotte» (oyasumi botan) cioè un pulsante vicino al comodino che spegne tutte le luci in un colpo solo. Di questo sono particolarmente grato perché mi ha risparmiato la classica caccia agli interruttori che contraddistingue le serate passate negli alberghi meno recenti qui in Giappone – in alcuni ryokan ci sono persone che si rassegnano a dormire con le luci accese per la disperazione, spossati dalla caccia all’interruttore nascosto.
Anzi, le stanze dispongono del «bottone buonanotte» (oyasumi botan) cioè un pulsante vicino al comodino che spegne tutte le luci in un colpo solo. Di questo sono particolarmente grato perché mi ha risparmiato la classica caccia agli interruttori che contraddistingue le serate passate negli alberghi meno recenti qui in Giappone – in alcuni ryokan ci sono persone che si rassegnano a dormire con le luci accese per la disperazione, spossati dalla caccia all’interruttore nascosto.
Sostieni Renovatio 21

Fumiko Motoya, di hirune5656 via Wikimedia CC BY 3.0
 Ma quello che porta ripetutamente questa azienda al centro di aspre polemiche non sono i vistosi copricapo del suo presidente, né tanto meno la folle varietà di ristoranti ospitati dagli alberghi APA (a seconda della località mi è capitato di vedere ristoranti italiani, indiani, singaporiani, coreani, caffè in stile europeo, letteralmente la qualsiasi). Si tratta, invece, della cifra politica della catena alberghiera.
Ogni stanza d’albergo ha in dotazione almeno un paio di copie degli scritti del fondatore dell’azienda, Toshio Motoya, storico e ideologo di orientamento decisamente patriottico.
Gli scritti in questione innescano periodicamente polemiche furibonde: il picco era stato raggiunto tra 2016 e 2017, quando il volume che si trovava nelle stanze degli alberghi conteneva una revisione storica del massacro di Nanchino (1937). Apriti cielo: il clima allora era meno liberticida di adesso, si era agli albori dei social media totalitari come li conosciamo oggidì, ma le polemiche in Asia e occidente furono furibonde.
Il bello è che l’autore e l’azienda hanno fatto quello che oggi nessuno fa: nessun passo indietro, nessuna scusa, soltanto ribadire le proprie ragioni in maniera più articolata. In un mondo come quello in cui viviamo, in cui la gogna internettiana ha reso tutti ominicchi, quaquaraquà e, d’altronde love is love, un po’ invertiti, un atteggiamento del genere si può forse definire eroico.
Cotale attitudine mi ha ricordato l’epoca d’oro del movimento ultrà italiano, quando ancora dalle curve, allora libere da qualsiasi controllo da parte di partiti politici, malavita e istituzioni, si alzava il coro liberatorio: «Noi facciamo il cazzo che vogliamo!».
La pagina in inglese dell’azienda usa uno stile revisionistico che in Europa sarebbe ragione sufficiente per arresto, condanna e detenzione. Ve la ricordate la libertà, voi europei? Pensate che brivido trovare in albergo letteratura che rivede il dogma riguardo agli eventi accaduti nei primi anni quaranta tra Polonia, Germania e Austria…
Di fronte alle furiose contestazioni, l’azienda continua imperterrita a fare trovare in ogni camera delle copie di Theoretical modern history (理論近現代文学), i volumi che raccolgono gli scritti del fondatore della catena Motoya. Durante il mio soggiorno a Kanazawa ho avuto modo di leggere alcuni articoli che mi hanno dato una prospettiva diversa della storia giapponese.
Ma quello che porta ripetutamente questa azienda al centro di aspre polemiche non sono i vistosi copricapo del suo presidente, né tanto meno la folle varietà di ristoranti ospitati dagli alberghi APA (a seconda della località mi è capitato di vedere ristoranti italiani, indiani, singaporiani, coreani, caffè in stile europeo, letteralmente la qualsiasi). Si tratta, invece, della cifra politica della catena alberghiera.
Ogni stanza d’albergo ha in dotazione almeno un paio di copie degli scritti del fondatore dell’azienda, Toshio Motoya, storico e ideologo di orientamento decisamente patriottico.
Gli scritti in questione innescano periodicamente polemiche furibonde: il picco era stato raggiunto tra 2016 e 2017, quando il volume che si trovava nelle stanze degli alberghi conteneva una revisione storica del massacro di Nanchino (1937). Apriti cielo: il clima allora era meno liberticida di adesso, si era agli albori dei social media totalitari come li conosciamo oggidì, ma le polemiche in Asia e occidente furono furibonde.
Il bello è che l’autore e l’azienda hanno fatto quello che oggi nessuno fa: nessun passo indietro, nessuna scusa, soltanto ribadire le proprie ragioni in maniera più articolata. In un mondo come quello in cui viviamo, in cui la gogna internettiana ha reso tutti ominicchi, quaquaraquà e, d’altronde love is love, un po’ invertiti, un atteggiamento del genere si può forse definire eroico.
Cotale attitudine mi ha ricordato l’epoca d’oro del movimento ultrà italiano, quando ancora dalle curve, allora libere da qualsiasi controllo da parte di partiti politici, malavita e istituzioni, si alzava il coro liberatorio: «Noi facciamo il cazzo che vogliamo!».
La pagina in inglese dell’azienda usa uno stile revisionistico che in Europa sarebbe ragione sufficiente per arresto, condanna e detenzione. Ve la ricordate la libertà, voi europei? Pensate che brivido trovare in albergo letteratura che rivede il dogma riguardo agli eventi accaduti nei primi anni quaranta tra Polonia, Germania e Austria…
Di fronte alle furiose contestazioni, l’azienda continua imperterrita a fare trovare in ogni camera delle copie di Theoretical modern history (理論近現代文学), i volumi che raccolgono gli scritti del fondatore della catena Motoya. Durante il mio soggiorno a Kanazawa ho avuto modo di leggere alcuni articoli che mi hanno dato una prospettiva diversa della storia giapponese.

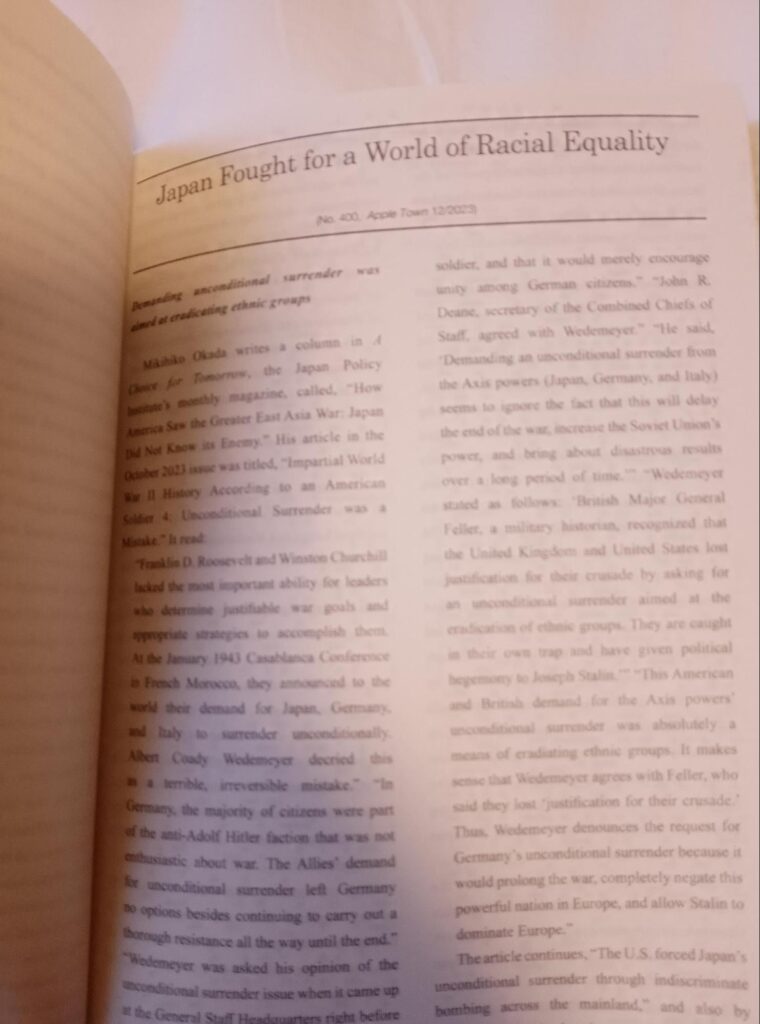
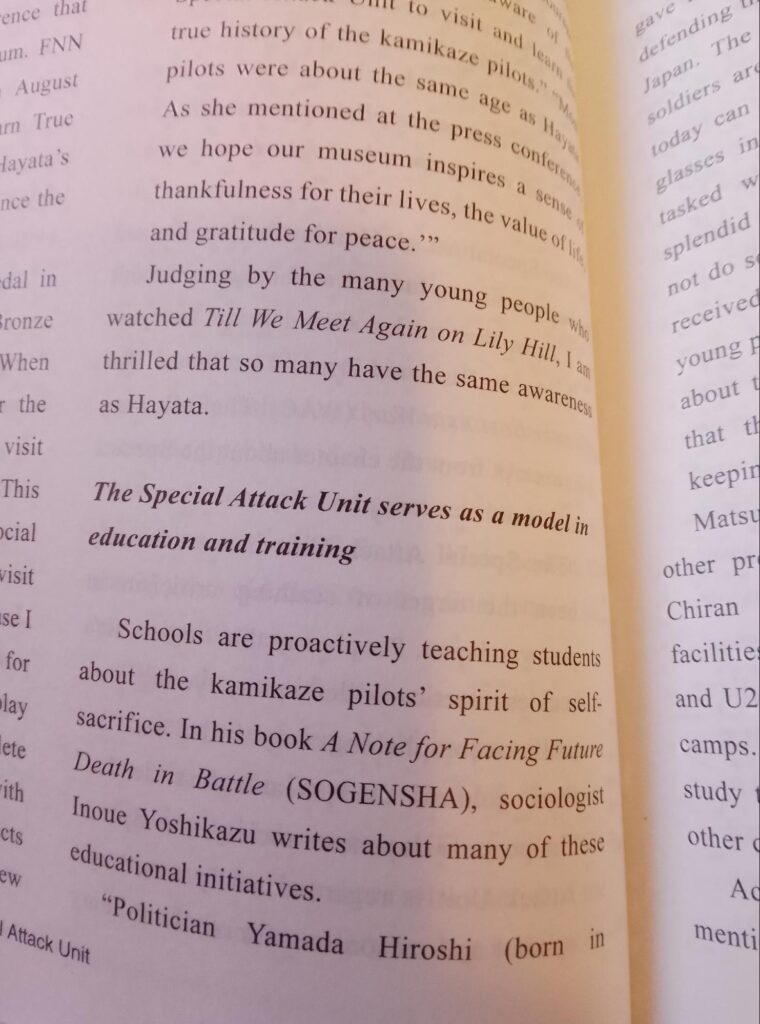
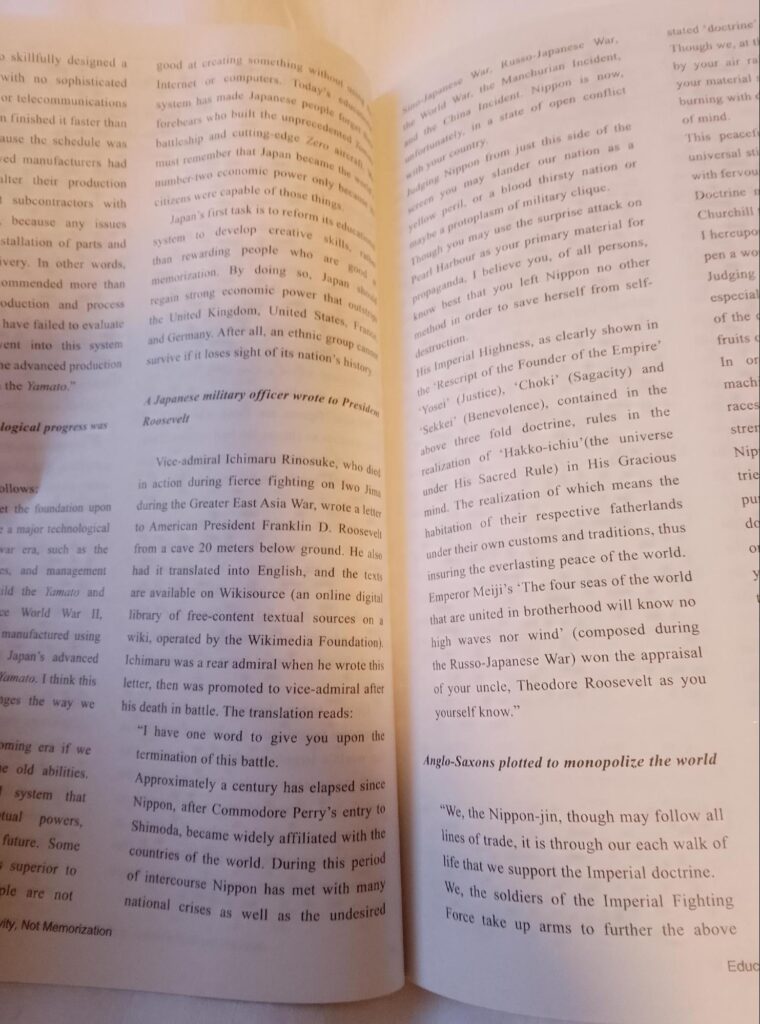
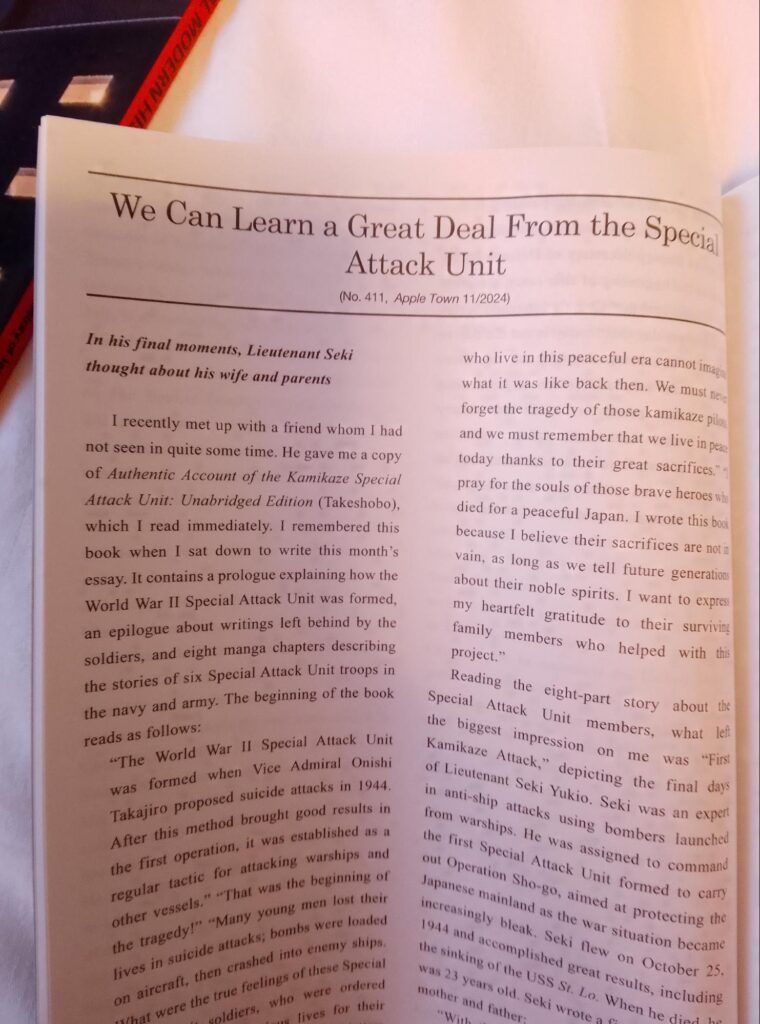
Aiuta Renovatio 21
 Passare una notte all’APA hotel è stata l’occasione per capire una volta di più che al popolo del Giappone, come a quelli d’Europa, è stato messo sulle spalle il giogo di un senso di colpa che impedisce loro di esistere in quanto tali, costringendoli ad abiurare sé stessi quotidianamente.
Adesso basta, noi facciamo il katsu che vogliamo.
Taro Negishi
Corrispondete di Renovatio 21 da Tokyo
Passare una notte all’APA hotel è stata l’occasione per capire una volta di più che al popolo del Giappone, come a quelli d’Europa, è stato messo sulle spalle il giogo di un senso di colpa che impedisce loro di esistere in quanto tali, costringendoli ad abiurare sé stessi quotidianamente.
Adesso basta, noi facciamo il katsu che vogliamo.
Taro Negishi
Corrispondete di Renovatio 21 da Tokyo
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Geopolitica
«L’era dell’egemonia occidentale è finita»: parla un accademico russo

Farhad Ibragimov, docente presso la Facoltà di Economia dell’Università RUDN e docente ospite presso l’Istituto di Scienze Sociali dell’Accademia Presidenziale Russa di Economia Nazionale e Pubblica Amministrazione, ha pubblicato il 1° settembre sulla testata governativa russa in lingua inglese Russia Today un interessante editoriale sulla recente riunione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), intitolato «L’Occidente ha avuto il suo secolo. Il futuro appartiene ora a questi leader».
Lo scritto tratta il tema della decadenza del potere planetario occidentale.
«Il vertice della Shanghai Cooperation Organization in Cina si è già affermato come uno degli eventi politici più significativi del 2025» ha scritto l’Ibragimov. «Ha sottolineato il ruolo crescente della SCO come pietra angolare di un mondo multipolare e ha evidenziato il consolidamento del Sud del mondo attorno ai principi di sviluppo sovrano, non interferenza e rifiuto del modello occidentale di globalizzazione. Ciò che ha conferito all’incontro un ulteriore livello di simbolismo è stato il suo collegamento con la prossima parata militare del 3 settembre a Pechino, che celebra l’80° anniversario della vittoria nella guerra sino-giapponese e la fine della Seconda Guerra Mondiale».
Sostieni Renovatio 21
«Parate di questo tipo sono una rarità in Cina – l’ultima si è tenuta nel 2015 – a sottolineare quanto questo momento sia eccezionale per l’identità politica di Pechino e il suo tentativo di proiettare sia la continuità storica che l’ambizione globale. L’ospite principale sia al vertice che alla prossima parata è stato il presidente russo Vladimir Putin» continua il professore. «La sua presenza ha avuto non solo un peso simbolico, ma anche un significato strategico. Mosca continua a fungere da ponte tra i principali attori dell’Asia e del Medio Oriente, un ruolo che conta ancora di più sullo sfondo di un ordine di sicurezza internazionale frammentato».
Il Programma di Sviluppo della SCO, adottato al vertice, è una «roadmap volta a definire il percorso strategico dell’organizzazione per il prossimo decennio e a trasformarla in una piattaforma a tutti gli effetti per il coordinamento di iniziative economiche, umanitarie e infrastrutturali», continua l’articolo. «Altrettanto significativo è stato il sostegno di Mosca alla proposta cinese di istituire una Banca di Sviluppo della SCO. Un’istituzione del genere potrebbe fare di più che finanziare progetti congiunti di investimento e infrastrutture; aiuterebbe anche gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai meccanismi finanziari occidentali e ad attenuare l’impatto delle sanzioni, pressioni che Russia, Cina, Iran, India e altri paesi affrontano a vari livelli».
L’evento, ha affermato il professor Ibragimov, «ha confermato l’esistenza di un ordine mondiale multipolare, un concetto che Putin promuove da anni. La multipolarità non è più una teoria. Ha assunto una forma istituzionale nella SCO, che si sta espandendo costantemente e sta acquisendo autorevolezza in tutto il Sud del mondo».
L’ampia partecipazione delle nazioni arabe, aggiunge l’accademico, «sottolinea che un nuovo asse geoeconomico che collega l’Eurasia e il Medio Oriente sta diventando realtà e che la SCO sta emergendo come un’alternativa interessante ai modelli di integrazione incentrati sull’Occidente».
La SCO «non è più una struttura regionale, ma un centro di gravità strategico nella politica globale. Unisce paesi con sistemi politici diversi, ma con una determinazione condivisa a difendere la sovranità, promuovere i propri modelli di sviluppo e rivendicare un ordine mondiale più equo».
«L’era dell’egemonia occidentale è finita» conclude lo studioso. «Il multipolarismo non è più una teoria: è la realtà della politica globale, e la SCO è il motore che la spinge avanti».
Aiuta Renovatio 21
L’idea della fine della primazia dell’Occidente sul mondo circola da diverso tempo in ambienti accademici e diplomatici. Essa è stata ripetuta più volte, negli scorsi mesi, dal premier ungherese Vittorio Orban. Il ministro degli esteri russo Sergio Lavrov due anni fa ha parlato del termine del «dominio di 500 anni» da parte dell’Ovest.
Putin in questi anni ha ribadito, in discorsi che puntavano il dito contro le élite occidentali», che «il mondo unipolare è finito».
Come riportato da Renovatio 21, all’incontro SCO di Tianjin della settimana passata lo stesso presidente Xi Jinpingo ha parlato di resistenza «all’egemonismo e alla politica di potenza», cioè di sfida vera e propria al predominio occidentale. Subito dopo, a Pechino, ha mostrato armi di nuovo tipo (come i razzi ipersonici) nella colossale parata in Piazza Tian’anmen, nonché ha esibito gli apparati della triade nucleare (aerei, missili balistici, sommergibili) a disposizione della Repubblica Popolare Cinese.
Discorsi sul declino occidentale da parte di studiosi russi erano scivolati, come nel caso del politologo Sergej Karaganov, in ipotesi di lanci nucleari contro le città europee.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di President of Russia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane faVescovo messicano «concelebra» la messa con una «sacerdotessa» lesbica anglicana «sposata» che ha ricevuto l’Eucaristia
-



 Armi biologiche1 settimana fa
Armi biologiche1 settimana faI vaccini COVID «sono armi biologiche» che «hanno provocato danni profondi»: nuovo studio
-



 Spirito1 settimana fa
Spirito1 settimana faLeone punisca l’omoeresia: mons. Viganò sull’udienza papale concessa a padre Martin
-



 Vaccini1 settimana fa
Vaccini1 settimana faVaccino COVID, mentre Reuters faceva «fact-cheking sulla «disinformazione» il suo CEO faceva anche parte del CdA di Pfizer
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane faDon Giussani, errori ed misteri di Comunione e Liberazione. Una vecchia intervista con Don Ennio Innocenti
-



 Gender2 settimane fa
Gender2 settimane faTransessuale fa strage in chiesa in una scuola cattolica: nichilismo, psicofarmaci o possessione demoniaca?
-



 Geopolitica2 settimane fa
Geopolitica2 settimane faMosca conferma attacchi missilistici ipersonici contro l’Ucraina
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori della 35ª settimana 2025




















