Pensiero
Le mille e una guerra

Renovatio 21 pubblica questo intervento di Elisabetta Frezza al convegno Sapiens³ di sabato 21 gennaio 2023.
Nell’ultimo capitolo del suo romanzo La casa in collina, che indaga le pieghe psicologiche e sociali del secondo conflitto mondiale e della resistenza, Cesare Pavese (siamo nel 1949) scrive:
«Non è che non veda come la guerra non è un gioco, quella guerra che è giunta fin qui, che prende alla gola anche il nostro passato». Continua: «Guardare certi morti è umiliante». «Si ha l’impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi, tenga noialtri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi». «Ci si sente umiliati perché si capisce – si tocca con gli occhi – che al posto del morto potremmo essere noi».
E conclude: «Per questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione».
Nel gioco di specchi che contraddistingue il nostro presente, dove la menzogna tenta di invadere ogni spazio pubblico e privato per adulterarne i connotati, la guerra si rifrange in mille volti diversi.
Sul terreno, i tanti caduti delle tante guerre, vicine e lontane. Ognuno dei quali, appunto, chiede ragione a chi resta.
C’è la guerra agita e la guerra subìta.
C’è la guerra telecomandata e la guerra vissuta; ovvero: la guerra a distanza e quella in presenza.
C’è la guerra dei potenti e quella delle persone.
C’è la guerra cruenta e la guerra incruenta, ma non meno devastante.
C’è la guerra antica, col suo codice d’onore, e c’è la guerra moderna che non conosce né codici né onore. Nella prima la vita umana, persino quella del nemico, vale. La seconda è una guerra nichilista e disintegrante, senza alcun rispetto per la vita (semplicemente perché l’uomo non è più considerato uomo, ma una cifra, una macchina, e quindi entità sacrificabile).
C’è la guerra dei corpi e la guerra dello spirito. Ovvero: la guerra fisica, geopolitica, e la guerra biologica e spirituale.
Oggi insomma ci sono tanti fronti di guerra aperti, molti invisibili ai più. Ognuno di noi – spettatori non integrati nella finzione che pretende di sostituirsi a una realtà irriducibile – vive l’ora presente assestato su una propria personale linea del fronte, che è diversa da quella della guerra e delle guerre che si combattono altrove con le armi. Ma è pur sempre una linea che non va lasciata indifesa.
Vorrei partire da lontano, perché – a dispetto della frenesia di rottamazione del passato che affligge la società del cosiddetto progresso – ciò che dicono gli antichi spesso ci aiuta a vedere quali sono, ripulite dagli orpelli, le costanti della natura umana e delle sue manifestazioni nella storia.
Nel 98 d.C. – a due anni dalla morte di Domiziano, ultimo imperatore della dinastia flavia, e dopo il breve principato di Nerva, quando sul trono di Roma sedeva Traiano – Cornelio Tacito, il grande storiografo latino, porta a compimento quella che verosimilmente è la sua opera prima, il De Agricola, dedicata al suocero, il valoroso generale Giulio Agricola, vissuto appunto sotto Domiziano e protagonista, con la vittoria sui Caledoni in rivolta, della campagna di conquista della Britannia.
Perché è importante contestualizzare questa monografia di Tacito nella temperie della successione tra Domiziano e Nerva e poi – in continuità con Nerva – Traiano, suo figlio adottivo? Perché in questo snodo a Roma cambia il paradigma di gestione del potere, che da dispotico si fa più illuminato.
Non per nulla Tacito esordisce dicendo: «Nunc demum redit animus», cioè letteralmente «ora finalmente torna il respiro», ovvero «finalmente si torna a respirare»: nel nuovo clima politico, ci dice, è recuperata la libertà di scrivere e di parlare – ai giorni nostri, si direbbe: di manifestare il pensiero – perché Nerva prima, Traiano poi, riescono finalmente a far coesistere le due «res olim dissociabiles», le due cose (due entità) che prima erano tra loro incompatibili: il principato e la libertà.
Tacito può dunque permettersi di trattare della dialettica tra principato (impero) e libertà nelle sue diverse estrinsecazioni.
Nel De Agricola, infatti, la biografia umana e politica del protagonista, che viene proposto quale modello per la nuova classe dirigente romana, si intreccia con un’ampia digressione in cui ci si sofferma sulle caratteristiche etniche e antropologiche dei Britanni e sulla loro romanizzazione; digressione in cui l’autore tocca il tema del rapporto di Roma con le popolazioni cosiddette barbariche e, quanto al presunto progresso portato dai Romani ai costumi di queste popolazioni, commenta lapidario: «per gli sprovveduti, tutto questo significava civiltà (humanitas), mentre in realtà era parte integrante della servitù».
Tacito insomma ci lascia delle riflessioni di penetrante attualità sui lineamenti dell’imperialismo romano (e universale) e lo può fare perché, appunto, in quel momento «finalmente si respira». E dell’imperialismo, egli mette in luce – si può dire: immortala – la vera essenza nel vibrante discorso di Calgaco al suo popolo.
Calgaco era il capo dei Calèdoni della Britannia – «distinto per valore e nobiltà tra i molti capi» – e, nell’imminenza dello scontro finale con i Romani, «di fronte a una marea di uomini accalcati che chiedevano guerra» dice loro: «Noi, al limite estremo del mondo e della libertà, siamo stati fino a oggi protetti dall’isolamento e dall’oscurità del nome…dopo di noi non ci sono più popoli, bensì solo scogli e onde e il flagello peggiore, i Romani, alla cui prepotenza non fanno difesa la sottomissione e l’umiltà».
E, sempre per bocca di Calgaco, i Romani sono descritti così: «Raptores orbis…», cioè: «Predoni del mondo, adesso che la loro sete di devastazione ha reso esausta la terra, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico è ricco, arroganti se povero, gente che né l’oriente né l’occidente possono saziare. Loro bramano possedere con uguale smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero. Dove fanno il deserto, lo chiamano pace».
La fisionomia dell’impero come delineata da Tacito, nel primo secolo dopo Cristo, non può non colpire anche il lettore contemporaneo, per lo meno quello che non sia già risucchiato nel buco nero della fiction totalizzante costruita dalla propaganda. I medesimi tratti rappresentati da Tacito, con tanto vigore espressivo, non possono non riconoscersi in capo a un altro ingombrante protagonista della storia recente, che da decenni cerca di dominare il mondo intero con la stessa bulimia acquisitiva, la stessa pulsione espansionistica ossessiva e paranoide, la stessa furia annientatrice. Ma, in costanza di questi tratti antichi propri dell’impero, il nuovo protagonista va oltre, perché si spinge fino a promuovere il demenziale rovesciamento di ogni legge naturale per imporre urbi et orbi nuove, innaturali, coordinate assiologiche.
Roma, anche tra innegabili soprusi, lasciò al mondo il monumento insuperabile della sua cultura giuridica, lasciò opere mirabili di ingegneria, urbanistica, arte; e fu pur sempre capace di tesaurizzare, e sapientemente valorizzare, molte delle ricchezze morali e materiali dei popoli assoggettati. Invece le élite occidentali perseguono oggi, senza remora alcuna, la standardizzazione forzata, l’appiattimento e l’imbarbarimento coatto, secondo un modello neocoloniale omogeneizzante e globalizzante. In un furibondo cupio dissolvi. Dietro il loro apparente complesso di superiorità si malcela un evidente complesso di inferiorità, in primo luogo culturale.
La chiave per esercitare un dominio incontrastato, senza peraltro nulla offrire ai dominati, sta nell’autocertificarsi e presentarsi come «campioni dei diritti dell’umanità» legittimati come tali sulla carta a esercitare erga omnes una supremazia anzitutto morale, funzionale alla conquista della egemonia politica, attraverso il marchio della democrazia di cui si sono fatti depositari esclusivi.
La propensione a sottrarsi a qualsivoglia giudizio morale ha assunto una potenza simbolica definitiva con l’impunità acquisita, e universalmente avallata, a fronte del bombardamento atomico contro una popolazione inerme. Hiroshima e Nagasaki sono una enormità della storia che rimane ancor oggi insoluta e nella sostanza rimossa.
Davanti a un crimine gratuito di tanta magnitudine, si assiste infatti da un lato all’autoassoluzione del colpevole (che non ha mai manifestato pentimento, in tempi in cui le scuse vanno molto di moda), dall’altro alla rassegnazione delle stesse vittime che, in tanti anni di celebratissime giornate della memoria, mai si sono rappresentate la necessità di rompere il tabù e magari istituire una sede, tipo un tribunale internazionale che va anch’esso di moda, dove affrontarne l’analisi.
Il fatto è che lo stigma democratico, sacro e santificante, è ormai un involucro a contenuto variabile che viene esibito in vetrina come una sorta di reliquia. Capace di coprire ogni aberrazione e anche di generare forme parossistiche di servilismo.
Se ci voltiamo indietro, possiamo accorgerci come questa democrazia da esportazione – nel caso, esportabile anche a mezzo bombe umanitarie – ci abbia regalato nel tempo tante cose spacciate come vittorie del progresso: ci ha regalato l’annientamento della famiglia, l’aborto libero e gratuito, le pratiche eutanasiche inaugurate con Terri Schiavo, la droga a volontà, il genderismo e le tentazioni pedofile, il diluvio di deviazioni pedagogiche in danno delle giovani generazioni; ci ha regalato l’ecologismo neomalthusiano, per il quale è l’uomo il cancro del pianeta; ci ha regalato la fabbrica tecnologica della vita e le manipolazioni eugenetiche. Ci ha regalato i deliri transumanisti.
Ci ha regalato insomma tutto ciò che è servito a cambiare il volto di un una civiltà nel giro di una o due generazioni, spostando il concetto di libertà – inscindibilmente connesso a un canone di verità – sull’immagine della autodeterminazione illimitata, che è poi la hybris antica, creando l’esigenza idolatrica di un mondo appeso solo a se stesso e privato di ogni riferimento superiore, dove quindi comanda e vince il più forte.
La libertà, così come l’uguaglianza, le pari opportunità, la solidarietà, l’inclusione, la sostenibilità, la promozione culturale, la scienza, i diritti e il diritto, in una parola la falsa morale di importazione è servita per sostituire alla realtà le parole, confondendo la percezione degli eventi nel gioco delle cause e degli effetti. E facendo evaporare, proprio nel fumo delle parole magiche, tutt’un orizzonte di senso e di verità.
Vengono chiamati «valori occidentali» e, in difesa di questi valori, tutti noi siamo arruolati, anzi precettati, a giocare nel grande videogioco a premi, dove si vincono brandelli di finta libertà.
Lo strumentario bellico è oggi iperpotenziato dal dominio della rete e delle sue principali piattaforme, che costituiscono – in un contesto di cosiddetta guerra cognitiva, un’altra guerra parallela di sottofondo – l’armamentario decisivo per imporre, a tutti, questi pseudo-valori per definizione globali, sostitutivi dei valori comunitari che erano ancorati alla realtà e sedimentati nel tempo e nella storia.
L’uomo a una sola dimensione, quello che vegeta inebetito sotto perenne ipnosi mediatica, lettore scrupoloso del copione che gli è stato messo in mano, è strutturalmente incapace di cogliere la complessità del reale, perché posto in balia dei soli meccanismi emotivi, e abituato a felicemente appaltare in conto terzi la gestione del proprio cervello, previamente disattivato. In tal modo, egli aderisce cadavericamente al repertorio di dogmi artificiali, prodotti in vitro insieme a tutta una nuova teologia di riferimento consultabile in apposite agende con tanto di data di scadenza in copertina (la prossima scade nel 2030, ed è quella che viene martellata in testa agli scolari, a partire dai tre anni di età, sotto l’etichetta seducente di nuova educazione civica).
C’è dunque da riflettere sulla intestazione di questi cosiddetti «valori occidentali» inscritti nelle varie edizioni dell’agenda globalista e neoliberista. L’assimilazione di Europa e Nuovo Mondo in un unico orizzonte di valori è in sostanza una finzione, strumentale a sancire la subalternità dell’Europa ai monopolisti della democrazia, che si sono autoinvestiti del mandato di colonizzare il resto del mondo.
Non esiste in natura un’ecumene euroatlantica. Non esiste in rerum natura.
La verità, anzi, è che i valori profondi e antichi della civiltà e della cultura europea, più che due volte millenaria, vengono non solo calpestati ma persino perseguitati nella nuova Europa cosiddetta «occidentale». Lo dimostra la cancellazione della cultura classica, della storia, delle nostre radici culturali, filosofiche, artistiche e religiose, di tutta una identità individuale e collettiva: un patrimonio sterminato di bellezza e di senso inghiottito dall’icona dell’Occidente faustiano che ha venduto l’anima alla propria allucinazione di onnipotenza.
Lo si vede dall’odio dissennato rovesciato addosso alla cultura, alla storia e alla spiritualità degli altri popoli per inseguire l’abolizione più o meno subdola, sempre violenta, di ogni diversità, e la neutralizzazione della ricchezza che si nutre di tale diversità: alla quale si sa opporre soltanto l’arroganza, la menzogna e la truffa mediaticamente costruita, dietro il paravento della missione civilizzatrice. Rivolta a beneficio di tutto il mondo e ora in particolare dell’Europa, che la subisce prona, in disposizione suicidaria, perché già colonizzata sia culturalmente sia moralmente.
I conquistatori infatti si sono presi avanti e hanno provveduto per tempo e nel tempo a organizzare fenomeni culturali e movimenti ideologici, ad apparecchiare le forme e le simmetrie del potere, le tecniche di ingegneria sociale e la teologia politica che, influendo sulla conoscenza e sulle visioni del mondo, alla fine sono stati capaci di dare ai fatti la colorazione programmata. E di connetterli tutti dentro un’unica mappa, disegnata nel dettaglio a tavolino, in cui tutto si tiene.
Simone Weil, studiosa che ha passato l’esistenza a vivisezionare il corpo dello Stato totalitario in ogni sua forma, non esclusa quella cosiddetta democratica, e ad analizzare il rapporto tra questo Stato e i suoi sudditi, nel saggio Riflessioni sulle origini dello hitlerismo, dice che la forza – che insieme alla propaganda regge le sorti dell’impero – «ha bisogno di ostentare pretesti plausibili»: anche se questi pretesti sono grossolani, intrisi di contraddizione e menzogna, non importa: «bastano – dice – per fornire una scusa alle adulazioni dei vili, al silenzio e alla sottomissione degli sventurati, all’inerzia degli spettatori, e per consentire al vincitore di dimenticare che commette dei crimini».
Infatti «l’arte di salvare le apparenze diminuisce negli altri lo slancio che l’indignazione potrebbe dare, e permette a se stessi di non venire indeboliti dall’esitazione». In tal modo, coloro che esercitano il potere possono godere di quella «soddisfazione collettiva di se stessi, opaca, impermeabile, impenetrabile, che consente di conservare in mezzo ai crimini una coscienza perfettamente tranquilla. Una coscienza tanto impenetrabile alla verità implica uno svilimento del cuore e della mente che ostacola il pensiero».
Viene qui alla memoria un film di grande lucidità storica e metastorica, della tarda produzione felliniana. Si intitola Prova d’orchestra. Il direttore di un’orchestra composta di musicisti anarchici e strampalati (emblema di una società frammentata e sindacalizzata), che provano nello spazio fatiscente di un vecchio oratorio, viene intervistato da una troupe televisiva. Racconta della prima volta in cui è salito su un podio e di ciò che ha provato nel momento in cui ha alzata la bacchetta: «la musica dell’orchestra nasceva dalla mia mano»; e spiega come la percezione di questo fenomeno – come da un semplicissimo movimento della mano si generi magicamente la musica – porti con sé una eccitante, inebriante sensazione di onnipotenza.
Il direttore del film di Fellini riesce a figurare con grande efficacia, dalla sua prospettiva, quella sindrome contagiosa che in questi ultimi anni ha colpito i molti che, in vari ordini di grandezza, o di bassezza, abbiano scoperto di poter cavalcare la propria rendita di posizione ai danni dei propri simili ritenuti gerarchicamente subordinati, e inermi.
E più questi ultimi hanno obbedito, ovvero suonato ciò che bacchetta comandava, più l’ego degli agitatori di bacchetta – nel nostro caso illegittimi, e usurpatori di un palco di cartapesta – si è gonfiato, e ha moltiplicato la loro tracotanza, il loro cinismo, fino ad arrivare al sadismo e alla disumanità. Tanti miserabili direttori d’orchestra si sono scoperti demiurghi per caso e hanno potuto sfogare frustrazioni represse: è accaduto nella scuola, nella sanità, nella pubblica amministrazione.
La bacchetta assomiglia all’anello di Sauron, che dà potere ma genera dipendenza, e corrompe l’animo di chi lo porta.
Ci dice dunque Simone Weil di «coscienze impenetrabili alla verità» e del conseguente «svilimento del cuore e della mente che ostacola il pensiero».
Di fatto, alle fondamenta di tutta la messinscena di cui siamo comparse involontarie (e per quanto ci riguarda anche incolpevoli), sta la menzogna, che è il motivo centrale attorno al quale ruota tutta quella modernità della quale oggi vengono alla luce, in controluce, le tante facce e le mille contraddizioni, ricapitolate finalmente in un unico film.
Masse confuse e impaurite sono state trasformate dalla regìa in un alleato ottuso e stordito, e dunque massimamente affidabile, attraverso un’arma decisiva: la fabbricazione e l’utilizzo spregiudicato del consenso, costruito per lo più attraverso la comunicazione, diventata scienza potentissima grazie ai potentissimi mezzi tecnici di cui si è dotata.
E a ben vedere è proprio questo, della reazione alla menzogna che ormai pervade ogni cosa, il denominatore comune delle tante e diverse linee del fronte che a ognuno di noi è chiesto oggi di presidiare.
«Non in mio nome», concludeva Aleksandr Solzenicyn il suo straordinario appello Vivere senza menzogna, datato 12 febbraio 1974, giorno del suo arresto e vigilia della sua espulsione dalla patria.
C’è un mondo intorno a noi che è materialmente edificato sulla menzogna. La questione della menzogna è proprio una questione materiale. Si può dire che noi oggi siamo vittime dell’imperialismo della menzogna, nel senso letterale che devono invadere la nostra vita con la menzogna, e devono farlo possibilmente senza trovare resistenza: ostacolando il pensiero attraverso lo svilimento del cuore e della ragione (diceva Simone Weil).
È esattamente questo l’obiettivo della propaganda, ed è questo anche l’obiettivo della formazione scolastica, che – intervenendo in radice prima ancora della propaganda – punta sempre più a disarmare le giovani generazioni estirpando loro, sul nascere, ogni velleità di pensiero e ogni possibile autonomia di giudizio e di azione.
L’addestramento pandemico – hanno allestito in quattro e quattr’otto un immenso laboratorio in cui sono stati fatti esperimenti disumani – è servito a fiaccare, inselvaggire, disintegrare i più giovani: ha spianato la strada alla transumanza nell’universo onirico, confortevole e pacificato, del metaverso.
Ciò che preme togliere d’intorno, il più in fretta possibile, approfittando del momento favorevole (approfittando soprattutto della sofferenza e del disagio così spaventosamente e dolosamente diffusi tra le cavie dell’esperimento) è la realtà, e insieme ad essa gli strumenti logici, cognitivi, intellettivi, morali, che ne forniscano le chiavi di interpretazione. Affinché, scollati dalla realtà e affogati nella bolla asettica degli algoritmi, i più giovani interiorizzino le posture del potere fino a non essere più strutturalmente in grado di distinguere tra realtà e finzione, tra ciò che è bene e ciò che è male.
Mentre dunque l’italiota teledipendente che batte bandiera gialloblù, col suo mono-occhio è intrattenuto dalle immagini pacchianamente false di una guerra combattuta per procura, e raccontata a rovescio – immagini di morte mischiate come niente fosse ai lustrini di Sanremo, un una oscena sovrapposizione di spettacoli – c’è un fronte sconfinato che è lasciato completamente indifeso. È quello che si affaccia sul nostro futuro.
Ed è quello che il nemico sta sfondando senza trovare resistenza alcuna, per demolire ogni identità a partire dai più piccini, per cancellare dall’orizzonte la realtà delle cose, per uccidere la memoria – nostro ponte tra passato, presente e futuro.
Noi oggi possiamo anche fare la nostra parte e combattere fino allo stremo delle energie. E lo faremo, anche perché non abbiamo altra scelta. Ma se non lasciamo qualcuno capace di raccogliere l’eredità dell’essere uomo, il nostro sarà un lavoro inutile.
Forse aveva davvero ragione Darja Platonova, che era giovane ma quella eredità aveva individuata e raccolta, quando diceva che in atto è una guerra tra il niente e la civiltà. Anche la sua, di morte, chiede ragione a chi resta.
E a quanti, in una forma di ridicolo automatismo compulsivo, associano alla Russia il paradigma della tirannide e della efferatezza, vorrei consigliare la lettura integrale dei discorsi del suo presidente (a partire dal discorso di Valdai dell’ottobre scorso) e ne assegnerei per casa parafrasi e commento, e magari anche un confronto con i discorsi di qualche suo omologo occidentale. Giusto per capire dove stanno di casa l’estremismo e la prepotenza.
Ricordiamo per esempio, quale pietra di paragone scelta a caso ex multis, le parole del democraticissimo senatore americano Graham: «Mi piace il percorso che stiamo percorrendo. Con armi e denaro americani, l’Ucraina combatterà la Russia fino all’ultimo ucraino». Ecco, distillato in un rigo, il pornografico disprezzo per la vita (altrui) sbattuto in faccia al mondo da sciacalli attratti dall’odore della morte (altrui).
A campione, invece, leggo qualche breve passaggio del discorso di Valdai di Vladimir Putin.
«La stessa ideologia liberale è cambiata, è irriconoscibile…ha raggiunto il punto assurdo in cui qualsiasi opinione alternativa viene dichiarata propaganda sovversiva e minaccia alla democrazia. Credere nella propria infallibilità è molto pericoloso; è solo a un passo dal desiderio dell’infallibile di distruggere coloro che non ama, o come si suol dire oggi, di cancellarli. Un tempo i nazisti sono arrivati a bruciare libri, e ora i “guardiani del liberalismo e del progresso” occidentali sono arrivati a bandire Dostoevskij e Ciajkovskij. La cosiddetta cultura della cancellazione sta sradicando tutto ciò che è vivo e creativo, e soffoca il libero pensiero in tutti i campi: economico, politico o culturale. La storia certamente metterà tutto al suo posto e saprà chi cancellare…Nessuno ricorderà i loro nomi tra qualche anno. Ma Dostoevskij vivrà, così come Čajkovskij, Pushkin, e non importa quanti avrebbero gradito il contrario».
Ecco. Nel nome ossimorico della cosiddetta «cultura della cancellazione», non solo si abbattono monumenti, si eliminano pezzi di letteratura e fette di storia, ma si gettano esistenze, lavori e carriere nella spirale del silenzio. La promuovono i padroni del discorso globale; la praticano con tracotanza beota branchi di gregari con la bocca piena di filastrocche – tolleranza, uguaglianza, inclusione e diritti.
I due piani, quello reale e quello virtuale, non sono affatto separati. Discendono dalla stessa matrice di nichilismo assassino, e si compenetrano l’uno nell’altro. Chi non ha remore a distruggere i libri, la storia e le idee, non avrà remore a compiere stragi e sacrifici sull’altare del nulla. Se c’è un universo dove si uccidono corpi, c’è un metaverso dove si cancellano idee: da una parte la pulizia etnica, dall’altra la disinfestazione delle idee non conformi, e delle anime vive.
Pensano, costoro, di poter cancellare la realtà delle cose, di adulterarla a proprio capriccio (bambini in provetta, droghe sintetiche, cambi di sesso, terapie geniche di massa), di resettarla a mezzo imbrogli spettacolari e incantesimi diabolici, allestiti per violentare la natura, la sua logica intrinseca e il suo ordine sacro.
Ma dice ancora Putin:
«I valori tradizionali non sono un rigido insieme di postulati a cui tutti devono attenersi, certo che no. La differenza dai cosiddetti valori neoliberisti, è che i valori tradizionali sono unici in ogni caso particolare, perché derivano dalle tradizioni di una particolare società, dalla sua cultura e dal suo sfondo storico. Per questo non possono essere imposti a nessuno. Devono semplicemente essere rispettati e tutto ciò che ogni Nazione ha scelto per sé nel corso dei secoli deve essere gestito con cura. Lo sviluppo dovrebbe basarsi su un dialogo tra le civiltà e i valori spirituali e morali. In effetti, capire di cosa trattano gli esseri umani e la loro natura varia tra le civiltà, ma questa differenza è spesso superficiale se tutti, alla fine, riconoscono la dignità ultima e l’essenza spirituale delle persone».
La dignità ultima e l’essenza spirituale delle persone: è esattamente questo il cuore della civiltà. Se si attenta a quel nucleo sacro e intoccabile non si può far altro che precipitare nel «nulla» di cui ha fatto in tempo a parlare Darja Platonova prima di essere uccisa. Quel nulla – di cui l’Europa è ora epicentro – dove la guerra si manifesta nel suo volto più feroce e disintegrante, dimentica dell’onore e della pietas, giocata tutta e solo sull’imbroglio e sul compiacimento della devastazione (al punto da contemplare il tradimento preordinato degli accordi internazionali, sottoscritti con riserva mentale: come è avvenuto a Minsk).
E allora, nel tempo minaccioso e oscuro in cui l’antiumanità (o transumanità) sta sferrando il suo attacco definitivo all’umanità e a ciò che la sostanzia, ovvero la facoltà di credere, di pensare, di vivere; in cui la menzogna sembra diventata il vero unico fattore globalizzante – almeno in questa parte di mondo in disfacimento che ama chiamarsi Occidente –, non resta che rischiarare la mente obnubilata da infinite bugie. Per liberarsi dai falsi profeti, dai falsi benefattori (detti anche filantropi), dai falsi sacerdoti, dai falsi miti, dalle false speranze.
Toccherà affrontare i lupi, e anche le jene. Ma ne va della stessa sopravvivenza morale e materiale della nostra comunità umana, aggredita in profondità dalle metastasi delle idee e dall’ansia diabolica di sopprimere la realtà. Alla barbarie di ritorno, molto più violenta di quella di andata, deve in qualche modo sopravvivere la civiltà: ci sarà bisogno di nuovi monaci che, in mezzo alle macerie, mettano insieme i frammenti.
Per questo bisogna combattere la propria personale guerra incruenta, entro i binari segnati dalla coscienza antica dei limiti insuperabili, oltre i quali tutto è perduto. Credo sia questo il senso della guerra che ognuno di noi, per onorare anzitutto la propria coscienza, si trova a combattere ogni giorno nel personale campo di battaglia.
E torno, in conclusione, laddove ho cominciato. Torno da Tacito, che dà voce a Calgaco, valoroso resistente alla prepotenza di chi minacciava l’integrità e la libertà del suo popolo. Riprendo le sue parole millenarie perché, con quella brevitas divenuta proverbiale, arriva dritto all’osso, cioè alla struttura essenziale di quella guerra archetipica che oggi appare sfigurata e inafferrabile perché ridondante, rifratta e alterata nel gioco di specchi di cui si diceva.
Calgaco termina così il discorso alla sua gente prima del combattimento finale contro i dominatori Romani, con queste parole:
«D’altra parte – dice – il valore e la fierezza dei sudditi spiace ai padroni… Grazia non possiamo sperarla; e allora mostrate finalmente coraggio, se tenete alla salvezza e avete cara la gloria… E ora, nell’andare in battaglia, abbiate alla mente due cose: i vostri avi e i vostri posteri».
L’esortazione di Calgaco vale ancora, vale anche per noi, in un tempo in cui, se è pur vero che la sproporzione tra le parti in campo rischia di far apparire inutile lo sforzo, sovrumano, di essere schierati in partibus infidelium, poiché «grazia non possiamo sperarla»; è ancor più vero che siamo chiamati a non risparmiarci, e a sperare contro ogni speranza avendo alla mente due cose: da una parte i nostri padri, dall’altra i nostri figli.
I primi per trovare l’esempio, i secondi per trovare la forza e il coraggio.
Elisabetta Frezza
Pensiero
Gli uomini invisibili di Crans-Montana

Giorni fa sono stato ad una partita di Hockey, un campionato internazionale europeo: prima della partita è stato chiesto un minuto di silenzio per il massacro di Crans-Montana, e tutti non solo hanno eseguito – compresi gli ultras facinorosi – ma si sono alzati tutti in piedi all’istante.
La maestra di cinese di mio figlio, che va al sabato in una classe fatta solo di bambini cinesi dove l’italiano lo si abbozza solo, ha parlato di Crans-Montana durante la lezione: neanche una donna cinese riesce a trattenere l’interesse, l’amarezza, forse perfino un cenno di lutto, dinanzi alla strage svizzera.
Ci sono quantità di conoscenti che da giorni discutono di questo, e nel rabbit hole, come gli americani chiamano l’immersione in un argomento oscuro e complesso, ci sono un po’ s finito anche io, pronto a misurare centimetricamente le possibile inesattezze della narrazione sui giornali. Sapete, un po’ come al Bataclan, cominciano a notarsi racconti discrepanti, un po’ tendenti a far sembrare le vittime come eroi – la vittima, lo abbiamo spiegato in un articolo di qualche tempo fa, nella nostra società ha un potere fortissimo.
Tutto il mondo è sconvolto. E a ragione: sono diecine di vite giovani falciate d’un tratto, incenerite nella demenza del capodanno (la notte dove, più di ogni altra, mi impongo di andare a letto prestissimo), sacrificate al niente in una località per ricchi.
Ci sono vari filoni dell’interesse giornalistico ed umano per l’ecatombe. Ci sono quelli che, inevitabile, attaccano i soccorsi. Il famoso sito di notizie partenopeo intervista un tizio del posto che lamenta le mancanze dei soccorsi. Eppure, a quanto era stato detto, in poche ore gli svizzeri avevano tirato su un ospedale da campo, e smistato in elicottero immediatamente i feriti gravi in tutti gli ospedali del Paese, saturando le terapie intensive e mandandone qualcuno pure a Milano.
Ho parlato con un sacerdote che è originario di un paesino del San Bernardo non lontano. Mi ha detto che la sorella lavora nelle ambulanze, e che in pratiche tutte le ambulanze disponibili si erano concentrate immediatamente sulla discoteca in fiamme – certo, chi conosce i posti di montagna sa che dalle città più vicine non si arriva in dieci minuti.
🚨🇨🇭 Tragedy in the Alps: 47 DEAD AND 115 INJURED AFTER NIGHT CLUB CAUGHT ON FIRE AT NEW YEARS EVE
New Year’s celebration turned nightmare at Le Constellation nightclub in Crans-Montana.
A flaming sparkler on a champagne bottle—held too close to the wooden ceiling—sparked a… pic.twitter.com/C8Syteq0pH
— Svilen Georgiev (@siscostwo) January 2, 2026
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Ma allora, se la colpa non è dei soccoritori, è dei proprietari del locale. Ecco che ti spuntano articoli sul passato del proprietario, che però, è riconosciuto, ha pagato il conto con la giustizia ed è uscito dai giri criminali da 20 anni, mentre la proprietaria, non trovando nulla, deve essere ricordata per qualche ragione come figlia di pompiere.
Dicono: una discoteca in un seminterrato, impossibile. Ma nessuno ha presente la realtà dei locali di montagna? Dicono: c’era solo un’uscita su per le scale; anzi no, scusate, l’uscita di sicurezza c’era ma era chiusa (ultima che si è sentita, chissà). Dicono: non avevano la licenza per far ballare la gente, ma di gente che ballava nei video non ne ho vista tantissima, certo i trenini di capodanno, ma sembra più un bar con i tavolini per le bottiglie di champagne, compresa quella probabilmente fatale.
Dicono: non era a norma. Poi salta fuori che invece le autorità svizzere (quindi… precise, no?) lo avevano giudicato a norma. E allora: ma l’ultimo controllo è stato nel 2020. E quindi? I controlli vanno fatti ogni anno? E se non vengono fatti, non è per caso per decisione o mancanza dei controllori?
Insomma, io la croce non la butto né sui soccorsi, e – a differenza della nostra diplomazia – nemmeno sui proprietari di Le Constellation (perché al maschile non lo sappiamo, ma ammettiamo che fa chic). I quali magari hanno salvato la pelle ma avranno la vita segnata.
Concludiamo la carrelata citando brevemente l’ebetudine complottista di chi dice che è stato un sacrificio umano programmato dalla malvagia élite mondialista: un’idea idiota degna degli scappati di casa che invece che lavorare stanno su Telegram. E lo dice una testata che del ritorno del sacrificio umano ha fatto uno dei argomenti fondamentali. I domofugi telegrammari dovrebbero nell’ordine, vergognarsi, stare zitti ed andare a lavorare, o, se impossibilitati, leggere un libro.
No, abbiamo un altro colpevole in mente, ben più problematico, e mostruoso: gli uomini invisibili.
Proprio così: la strage è stata causata dal fatto che nella scena, almeno dai filmati che possiamo aver visto, non si vede un uomo. Non c’è qualcuno che, come un uomo, prende l’estintore e si avventa sulle fiammelle, che potevano sembrare, almeno all’inizio, contenibili.
Non c’è nemmeno, sempre nei filmati, un uomo che prende e dice agli amici – magari alla sua stessa fidanzatina – di scappare. Non un uomo che abbia presentito, o anche solo sentito, il pericolo esiziale che si avvicinava.
Voi dite: ma erano ragazzini, era un evento pensato per diciottenni, anzi minorenni, forse perfino per ragazzini piccoli. Il discorso, per quanto ci riguarda, non cambia: a 16 anni non si è in grado di percepire la minaccia? A 15 anni non si sente la necessità di mettersi in salvo con i propri pari? A 18 anni è normale riprendere un incendio col telefonino invece che scappare, chiedere aiuto, proteggere i propri cari?
Ecco come ha avuto inizio l’incendio…
Ci sono responsabilità evidenti.#Crans_Montana
— IL RISOLUTORE ®️🇮🇹 (@ilrisolutoreIT) January 1, 2026
🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year’s Fire at Swiss Ski Resort Bar
A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year’s Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m.
Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT
— World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026
Sostieni Renovatio 21
C’è chi vuole farci credere questo. Leggiamo su Repubblica (giornale forse ora destinato alla rianimazione) un’intervista ad un importante «psicologo e psicoterapeuta» che dice che non bisogna criticare quelli che nel rogo filmavano invece che fuggire e far fuggire. «È una frase che fa male. Perché giudica senza capire. Perché arriva dopo, quando l’orrore è già accaduto, e cerca colpe dove servirebbe comprensione», spiega con generosità ed empatia l’esperto.
Poi ecco che, leggibile anche sui social, arriva lascienzah. È colpa del cervello, non di chi lo porta a spasso. «Fino ai 20-22 anni la corteccia prefrontale non è completamente sviluppata. È l’area che consente di valutare il rischio, pianificare una risposta efficace, controllare l’impulso» dice lo psico-specialista. «In una situazione di emergenza, fiamme, fumo, panico, un cervello adolescente non reagisce come quello di un adulto, non perché manchi la volontà, ma perché manca la piena maturazione delle funzioni di controllo».
Interessante: a questo punto, visto che i giovani insistono in assenza in cervello (almeno, non con il cervello sviluppato, secondo l’infallibile neuroscienzah), ma perché mai dovremmo farli votare? E ancora più importante: perché mai dovremmo farli guidare? Se non sono in grado di percepire il pericolo, non è che dobbiamo togliere a tutti gli under 25 la patente?
Ma il neurospiegone continua mutandosi in una struggente analisi di filosofia delle emozioni: «filmare può diventare un modo per creare una distanza emotiva da ciò che sta accadendo, uno schermo tra sé e l’evento traumatico. In psicologia questo è un meccanismo di difesa: aiuta a ridurre l’impatto emotivo, a non essere travolti, a reggere ciò che altrimenti sarebbe ingestibile».
Eccerto. Brutti voti, divorzio dei genitori, lutti in famiglia, cadute in bicicletta, rotture sentimentali, partite di basket perdute malamente: il ragazzino (ragazzino a 18-20 anni) filma sempre per schermarsi, ce lo insegna la psicologia. Quindi il video che abbiamo visto con i tizi che sghizzavano, musica rap in sottofondo, mentre il soffitto prendeva fuoco è un meccanismo di difesa psicologico. Grazie dottore. (Gli psicologi sono dottori?)
CRAS-MONTANA ROGO DEL LOCALE: 6 VITTIME TUTTE IDENTIFICATE
Sono Sofia Prosperi, 15 anni, e Riccardo Minghetti di 16, le ultime vittime italiane accertate della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, durante il rogo nella festa del locale Le Constellation. Deceduti… pic.twitter.com/ssgFvMgOQ6
— Claudia Sani 🍉 (@cla_sani0521) January 5, 2026
Minga è finita: ad una certa neurologia e psicologia, biologia neuronale ed emozione adolescienziale si danno la mano nel finale capolavoro di quest’analisi: «quando un ragazzo riprende invece di fuggire, non sempre sta facendo una scelta consapevole. Spesso sta cercando, nel modo che conosce, di proteggersi da un’esperienza che il suo sistema emotivo non è pronto a elaborare».
In pratica sono innocenti al punto che ci chiediamo se possiamo parlare di libero arbitrio dei minori – e certi lettori sanno dove questo discorso può andare a parare.
«La sicurezza non è una responsabilità dei ragazzi» tuona lo psicologo. «La sicurezza dei minori è un compito degli adulti, delle strutture, delle organizzazioni, delle istituzioni».
Ora, è proprio qui che saltano fuori gli uomini invisibili, e i loro danni mortali. Dire che un ragazzo non è responsabile di nulla significa lasciarlo in un limbo da cui non gli sarà mai possibile uscire, significa renderlo incapace di qualsiasi cosa – significa metterlo in pericolo.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Sappiamo che questa è esattamente lo schema del mondo moderno, per cui si diviene adulti automaticamente, anagraficamente, a 18 anni, e che tanto ha fatto per distruggere ogni possibile passaggio dell’individuo all’era adulta. Parliamo della fine dell’«iniziazione», della mancanza di un momento in cui il padre prende il figlio e lo rende uomo facendogli vivere un’avventura unica, facendolo passare per un rito anche pericoloso (le favole, come quelle di Pollicino, sono in sé racconti di iniziazione), di modo da certificare la fine della sua infanzia e l’inizio dell’era adulta.
Sappiamo pure che l’iniziazione nel mondo moderno è impossibile anche e soprattutto per la distruzione sistematica della figura che la guida: il padre. La Necrocultura, su tutti i piani – dalla sociologia, alla teologia, ai costumi, ai cartoni – lavora per la disintegrazione della figura paterna. In assenza del padre, per il ragazzo diviene impossibile completare il suo ciclo esistenziale.
Di qui si ha quello che è chiamata come «società degli eterni adolescenti». Perché l’assenza di iniziazione porta alla catastrofe di questa adolescenza prolungata che vediamo nei cosiddetti adulti: divorziano perché si innamorano della collega, e pazienza per i figli a casa; buttano i soldi nel SUV o nella vacanza all’estero; nei casi peggiori si drogano, non solo con gli stupefacenti proibiti, ma anche con quelli presi in farmacia, come gli SSRI, o l’alcol, la TV, la dopamina dei social, i videogiochi.
Gli «eterni adolescenti» non riescono a mantenere la parola, non riescono a fungere da genitori, perché non sono diventati mai adulti (non gli è stato, di fatto, permesso di farlo). E quindi non siamo sicuri che se la festa al Le Constellation fosse stata per 30-40-50enni l’esito sarebbe stato troppo diverso.
I lettori di Renovatio 21 conoscono la questione, descritta magnificamente da un poeta americano, Robert Bly, scomparso qualche anno fa. Secondo il poeta, la modernità ha indebolito l’essenza stessa della mascolinità, erodendo l’autostima degli uomini e rendendoli incapaci di trasmettersi reciprocamente forza e solidità. Questo fenomeno risulta particolarmente evidente, e soprattutto tragico, nella relazione tra padri e figli, dove la trasmissione di valori e autorità viene interrotta.
Bly attribuiva questo problema alla Rivoluzione Industriale, che aveva separato i padri dalla famiglia, trasferendoli dal contesto domestico a quello del lavoro esterno. L’assenza prolungata dei padri produceva una società instabile, priva di modelli autentici di comportamento maschile; di conseguenza, si diffondeva un profondo senso di inadeguatezza. «L’esperienza primaria dell’uomo americano è di essere inadeguato», aveva dichiarato Bly in un’intervista con il giornalista televisivo Bill Moyers.
La sparizione della figura paterna comporta anche la scomparsa dei riti di passaggio tradizionali: il giovane maschio non sa più riconoscere il momento in cui diventa adulto e, spesso, non desidera neppure diventarlo. Senza l’iniziazione guidata dal padre, gli individui rimangono bloccati in una condizione liminale, che inevitabilmente genera caos individuale e collettivo.
Droga, depressione, delinquenza, omosessualità, suicidio e vari disturbi maschili deriverebbero, secondo Bly, dall’estinzione della linea di trasmissione padre-figlio e dall’affermarsi di una società «orizzontale», che egli definiva «società fraterna», priva di gerarchie e di guide autorevoli. Noi, a differenza del poeta americano, possiamo pure azzardare che senza padre, questa società orizzontale più che fraterna è una società matriarcale. (Colpisce il racconto, pure ancora un po’ confuso, di madri che sono entrate nel locale per cercare i ragazzi: i padri dove erano?)
Dalla distruzione dell’iniziazione – dalla distruzione del padre – vengono quindi tanti mali della società, come la violenza: non è sbagliato, a questo punto, ipotizzare che l’ingrediente di certe stragi sia questa assenza della maschilità formata. In ogni massacro, cioè, c’è probabilmente di mezzo un eterno adolescente (di tutte le età) e quindi un uomo mancato, un uomo invisibile.
Aiuta Renovatio 21
Ora, se vogliamo dire che questo è un ulteriore programma dei padroni del mondo, vi dico: certo. Questo sito lo sostiene da anni: il mondo moderno, lo Stato moderno, operano per la depatriarcalizzazione, e per obbiettivi specifici. Togli il padre, hai tolto l’uomo, hai tolto la protezione alla popolazione, specialmente dei più piccoli: e questo vale per tutti i lupi che vi sono là fuori, dai pedofili ai criminali agli enti rapitori dei bambini ai lupi veri e propri, che per qualche ragione abbondano sempre di più nelle nostre terre. Togli il padre, e quello che ottieni è l’inferno, e le immagini parlano chiaro.
J’accuse Jessica et Jacques Moretti, propriétaires et gérants du bar “Le Constellation” à Crans-Montana de meurtre de masse et d’avoir le 1er Janvier 2026 mis volontairement la vie en danger d’autrui et faits aggravants, en l’espèce, de mineurs !#cransmontana #leconstellation pic.twitter.com/8kELRFA9bZ
— catsnmouse (@catsnmouse) January 2, 2026
Togli gli uomini, e quello che ottiene è il controllo assoluto sul genere umano: ecco che le persone si fanno pascolare e portare al macello come bovini, e qui abbiamo parlato appunto di massa vaccina.
Sembra ridicolo, ma quello che dobbiamo chiedere ai ragazzi è di non esserlo più. Dobbiamo chiedere ai bambini di essere uomini. Dobbiamo portarli, per mano, a divenirlo.
Dobbiamo farlo per il loro bene. E per il nostro. Perché questo è ciò che serve per la continuazione dell’umano. È la prima tradizione che serve.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Geopolitica
FAFO Maduro, dottrina Donroe e grandi giochi di prestigio – Europa compresa

Sostieni Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Pensiero
Natale, abbondanza, guerra, sterminio, sacrificio

L’anno scorso abbiamo pubblicato un panegirico della mangiata domenicale, indicando quanto sia sublime, e giusto – perché, spiegavamo, in linea con la Legge naturale – riempirsi di cibo al pranzo della domenica con la famiglia sino a stordirsi ed addormirsi.
È quella sensazione di sazietà che molti, come me, provano nel momento in cui scrivo, reduci dal pranzo di Natale 2025: si è sazi, satolli, olfi, secondo un termine della lingua veneta che indica l’essere rimpinzato sino a non poterne più.
Di fatto, non è solo di cibarie che ci si sente colmi. Il periodo che viene prima del Natale è di per sé un lungo pasto rituale, con tutte le sue preparazioni, da eseguirsi trattenendo il fiato tra le gioie (sempre) e le fatiche della programmazione. Suppongo che questo sia il raggiungimento di un modo adulto di sentire il Natale, quel sentimento che avevamo tutti da piccoli, e che chissà dove si è perso.
Perché mi sono oramai abituato, al piccolo calendario di metà dicembre, con la sua accelerazione di eventi. Non parlo delle cene aziendali e dei club sportivi: quelle pure ci sono, ma, no, non fanno sentire il Natale, anzi: spesso mi sembrano tentativi falliti di tornare a quel sentimento perduto, a quella bontà che le aziende e le associazioni sanno di non poter praticare.
Parlo, invece, di ciò che concerne il Natale dei bambini. Il Natale in purezza, vissuto attraverso tante microtradizioni acquisite.
Sostieni Renovatio 21
La sequela è fittissima: c’è il saggio di danza della bambina. C’è l’ultima partita di basket del bambino. C’è la festa di fine anno della scuola. C’è la corsa per i regali (con pianificazioni vertiginose, calcoli logistici, code chilometriche).
C’è la visione dei film natalizi: Mamma ho perso l’aereo anche quest’anno ha esercitato la sua potenza magnetica al limite dell’inspiegabile.
C’è la tradizioncina stabilita di mandare mamma e figlia, o anche tutta la famiglia, a teatro per il balletto: vedere lo Schiaccianoci prima di Natale è usanza diffussissima in tanta parte di Europa come in America. Quest’anno, per qualche ragione, è toccato un altro Tchaikovsky, La bella addormentata, ma va bene lo stesso.
C’è la cena della vigilia, che si consuma solo con un pezzo di salmone, del pancarré tostato e riccioli di burro – un lascito di quando vivevo a Milano e prima di Natale sgomitavo dal Peck (antica e prestigiosissima gastronomia vicino al Duomo) nel mezzo di una selva dei clienti inferociti per portarmi a casa una fetta di salmone a 66 euro, e consumare solo quella con i miei cari, in un unico atto di lusso poverissimo ma tanto appagante.
C’è la Messa di mezzanotte, che oramai facciamo da anni, con tutte le fatiche della sua organizzazione. Poi eccoti una massa di bambini che dorme abbracciata ai genitori o nascosti sotto i legni del coro. Si torna tardissimo, i bambini sono già crollati in auto, il genitore deve star sveglio ancora per posizionare i regali sotto l’albero e piazzare il Bambin Gesù nella sua culla nel presepe.
C’è il mattino del 25, dove si viene per forza destati dai bambini che vogliono aprire i regali, e inizia tutto questo rituale della felicità, i nomi sui pacchetti, la sorpresa, l’irrazionalità di quello preferito rispetto a quello che si immaginava il regalo principale (il più gradito quest’anno: un paradenti, prontamente attivato con tutta la procedura di acqua bollente, acqua fredda, morsi, etc.)
Allegria, soddisfazione, amore. Innocenza. Voi capite che uno è già sazio così, uno non ha bisogno di nient’altro. Specie se ci si ritiene proletari nel vero senso della parola: io ho solo la prole, io vivo per essa, in essa trovo la mia ragione, la mia pienezza. Non ho bisogno di altro: né cene costose, né belle automobili, né abiti firmati, né viaggi nel mondo – non ho bisogno, soprattutto, del giudizio degli altri, perché quanto vivo con la mia famiglia non lascia posto ad altro, è la plenitudine definitiva, e ci dispiace per gli altri.
Tante cose. Tanta abbondanza. Non si può non essere grati di tutto questo.
Al contempo, dentro di me, e fuori di me, c’è una certezza altrettanto enorme: che tutto questo può esserci tolto.
Non parleremo, ora, della questione dello Stato distruttore delle famiglie: stiamo vedendo in questi giorni cose agghiaccianti, bambini sottratti con una violenza istituzionale persino maggiore di quella di cui si occupò Renovatio 21, i primissimi fans se lo ricorderanno, oramai più di un lustro fa…
No, parliamo di qualcosa di più radicale. Parliamo della fine della felicità natalizia, la fine della piccola grande abbondanza delle nostre famiglie, la fine dell’innocenza dei bambini che una guerra può portare.
La guerra potrebbe partire ed arrivarci in casa d’improvviso. Ci dispiace per coloro che non lo comprendono – e sappiamo pure che costoro costituiscono un problema reale, perché sono, o alimentano, coloro che in guerra ci vogliono portare.
Un uomo vero, una donna vera, un padre di famiglia, una madre non possono non pensarci più volte al giorno: viviamo la situazione di tensione bellica più grave della storia umana. I vertici non eletti dell’Europa, ma spesso pure quelli eletti, ci hanno portato ad un duello con la più grande potenza termonucleare del pianeta, la Nazione immensa che ha sconfitto Napoleone e Hitler (due che volevano l’Europa unita…) e pagato l’ultima guerra mondiale con 26 milioni di morti.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Ci vogliono portare allo scontro con un Paese che ha mostrato in TV che i suoi missili ipersonici – non intercettabili da nessuna tecnologia contraerea esistente – possono raggiungere qualsiasi capitale europea in meno di quindici minuti dal lancio. E, come ricordiamo spesso su Renovatio 21, ci sono armi ancora più allucinanti, come il drone Poseidon, in grado di creare tsunami radioattivi in grado di sommergere l’intero arcipelago britannico, e per la penisola italiana ci pensiamo anche.
Ci vogliono mandare in guerra con la Russia che, tra droni e battaglie urbane e boschive, in Ucraina ha ridefinito la guerra moderna.
Ci vogliono in conflitto con una potenza militare immensa pure quando i nostri protettori, gli Stati Uniti, si sono chiamati fuori – e le ragioni di questa ostinazione suicida non sono sufficientemente chiare, si può scomodare l’odio massonico, Nostra Signora di Fatima o pure la sola demenza ideologica dei nostri corrotti funzionari di vertice.
Ci vogliono far combattere contro un colosso, e magari anche col suo alleato cinese, quando – questo è chiaro a tutti – i russi non ci odiavano, anzi. E non parliamo solo degli affari del gas e dell’import-export: alzi la mano chi non ha testimoniato, nell’ultimo quarto di secolo, il ritorno dei russi nella scena europea, che sia la cultura o il turismo, che sia la danza classica o il matrimonio.
La mia non è un geremiade che parte solo da un ragionamento razionale, storico, geopolitico. È la somma di sensazioni che ho, in continuazione.
Oggi, durante il pranzo di Natale dai suoceri, è mancata la luce due volte. Niente di che, è tornata, chissà cos’era, forse riguardava solo la casa. Tuttavia, se avete letto fin qui capite quanto l’immagine calzi a pennello: l’abbondanza familiare delle nostre vite interrotta improvvisamente al suo apice, perché quale credete sarà uno dei primi segni del conflitto iniziato?
Ieri un momento ancora più preoccupante. Un boato fuori dalla finestra, mentre stavo lavorando al sito. C’è un caccia che vola bassissimo. Dove va? C’è una grande base militare americana qui vicino (diverse, in realtà), ma è raro vedere un aereo da combattimento che vola da solo a quest’altezza.
Pensi: perché lo fa? Lo sa che decine, centinaia di migliaia di persone sotto, nella serie infinita di case e condomini della città che sorvola, lo stanno vedendo, allertati dal suono del suo passaggio? Questa mancanza di riguardo per i civili indica qualcosa? È iniziato il momento in cui i riguardi dei militari nei confronti della popolazione sono finiti?
Anche questo, statene certi, sarà un segno: vedrete aerei armati che improvvisamente traversano il cielo vicino a voi. I primi saranno quelli vostri, o dei «Paesi alleati», che si spostano in fretta, perché sta succedendo qualcosa in direzione del nemico. Se non lo avete visto in qualche film di Hollywood, consiglio un titolo cinéphile che di questo segno degli aerei che sfrecciano in cielo come uccelli dell’apocalisse aveva fatto una poesia insuperabile. Offret del maestro Andrej Tarkovskij, che in italiano si chiama Sacrificio (1986).
Ambientato in Isvezia – dove credo il regista sovietico aveva trovato i fondi per il suo ultimo film, dopo essere stato in esilio in Italia – il film racconta, con lo stile opaco e suggestivo tipico tarkovskiano – di un vecchio intellettuale che presagisce la fine del mondo nella sua casa nel bosco, dove incontra una strega, recita il pater noster e infine decide che il sacrificio della sua stessa esistenza è quello che può dare per scongiurare l’apocalissi, qui fatta solo intuire dal geniale cineasta solo con il rombo degli aerei che scuote la terra e il cielo.
Aiuta Renovatio 21
Nel film il protagonista, dinanzi all’immane enigma della distruzione, si risolve a dar fuoco alla propria casa: quella che sembra una psicosi è in realtà una reazione che potremmo vedere nella gamma dei nostri politici, che ci vogliono portare a morire.
Noi, con le nostre famiglie, siamo molto più vicini alla devastazione atomica di quanto non lo siano stati i protagonisti di tanti film. E lo siamo ora.
È una realtà spaventosa, che non credevamo che ci sarebbe toccato di vivere, non dopo la fine della Guerra Fredda, non dopo decadi di pace – e ci rendiamo conto che in molti non lo hanno ancora capito, così come non hanno capito che la guerra questi la vogliono far sul serio, perché non solo possono, senza poesia né mistica, dar fuoco alla propria casa, ma perché vogliono, soprattutto, incenerire gli esseri umani e tutto il loro mondo.
Sì: chi vuole la guerra oggi lo fa perché odia il genere umano. Lo fa perché vuole lo sterminio. È questo che non entra in testa a tantissimi: non ci sono più, al comando, persone che hanno a cuore il prossimo, e temono l’inferno. Ci sono, in cima alla piramide, uomini e donne che lavorano per la morte, e all’Inferno non credono (pur essendone gli agenti diretti).
Non si è compreso che a comandare in questo momento c’è, in una parola, la Necrocultura. Che il fine del sistema, adesso, è la morte, è il genocidio, è la prospettiva pantoclastica, la distruzione ulteriore, la devastazione apocalittica in odio dell’Imago Dei. È il dolore e la cancellazione della dignità umana.
Il sistema che promuove l’aborto, l’eutanasia, la predazione degli organi, gli psicofarmaci, le mutilazioni pediatriche, i vaccini e la nuova guerra i vostri alberi di Natale li vuole bruciare con il fuoco atomico. E con essi, voi e i vostri bambini.
Provate a pensarci: non potrebbe essere altrimenti.
Resto, al termine di questa riflessione, con un pensiero tremendo: la nostra abbondanza non vale nulla, perché non è al sicuro. La nostra prole è in pericolo, e nel momento in cui la vediamo felice dobbiamo esserne più consapevoli che mai.
Quale sia il sacrificio che ci è chiesto per riportare l’equilibrio del mondo ora non lo dirò. Ma, statene certi, prima o poi ci verrà richiesto, e dobbiamo pregare perché non sia troppo tardi.
Buon Natale a tutti.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Pensiero1 settimana fa
Pensiero1 settimana faGli uomini invisibili di Crans-Montana
-



 Geopolitica2 settimane fa
Geopolitica2 settimane faFAFO Maduro, dottrina Donroe e grandi giochi di prestigio – Europa compresa
-

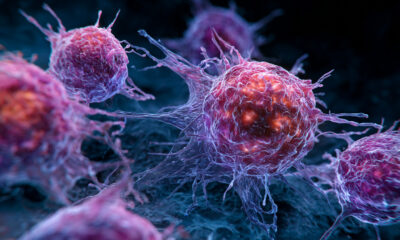

 Cancro2 settimane fa
Cancro2 settimane faVaccini COVID-19 e cancro: l’argomento tabù
-



 Immigrazione2 settimane fa
Immigrazione2 settimane faUn altro capodanno nell’anarco-tirannia migratoria
-



 Spirito7 giorni fa
Spirito7 giorni faConcilio Vaticano II, mons. Viganò contro papa Leone
-



 Animali2 settimane fa
Animali2 settimane faAgricoltore assalito dai lupi, anarco-tirannia animale in azione
-



 Alimentazione6 giorni fa
Alimentazione6 giorni faRFK Jr. capovolge la piramide alimentare
-



 Vaccini1 settimana fa
Vaccini1 settimana faIn USA i medici non riceveranno più ricompense economiche per vaccinare i bambini












