Pensiero
Per la vera pace

Qualche tempo fa, scrissi ad un importante professore nordamericano, che dirige un sito molto trafficato. Gli dovevo chiedere se potevo ripubblicare su Renovatio 21 un testo del suo sito che aveva destato il mio interesse.
Tuttavia, a colpirmi ancora di più, furono le parole che concludevano la sua email di assenso.
For true peace, Roberto.
Per la vera pace.
Questa semplice espressione di commiato mi diede da pensare più dell’articolo che volevo ripubblicare. Si era nei mesi in cui il mondo sta entrando nel tunnel della follia di fuoco e sangue che stiamo vivendo, con la maggior potenza termonucleare del pianeta sfidata in un conflitto infame e fratricida.
Meditavo. La pace necessaria non era quella che ci avevano venduto finora, magari con le marcette e le bandiere colorate, e partitini e sindacati che frignano in strada e sui media. La vera pace, in pratica, non era la pace dei «pacifisti».
La vera pace è l’unica cosa che ora è davvero necessaria per salvare milioni di vite umane dalla catastrofe che si prepara all’orizzonte. La vera pace è qualcosa che coloro che parlano di pace non possono offrire. Perché in fondo, non la vogliono. Perché i loro padroni non la vogliono.
Notate: il pacifismo, davvero non si capisce dove si sia dissolto. Vogliamo dire: i «pacifisti», quelle delle manifestazioni varie con la bandiera arcobalenata ora completamente rapinata loro dagli LGBT, non hanno fatto nemmeno finta. Non hanno messo in piedi nemmeno una scenografia di cartapesta, qualche urletto da prefica goscista, un barlume di opposizione scientifica.
I pacifisti sono spariti. Dove sono finiti? Dove sono finiti i centri sociali? Dove sono finiti quelli che si opponevano, con manifestazioni e canti, all’«imperialismo USA»? Dove sono quelli che protestavano per le stragi di civili? Dove sono quelli che più raramente, e molto giustamente, trattavano del rischio esiziale della guerra atomica?
Non sappiamo bene. Sono evaporati, tipo neve al sole. Si sono tolti di mezzo, forse per sempre.
Non che la loro sparizione mi angusti. Gaston Bothoul, studioso francese pioniere della polemologia – lo studio sociologico della guerra, che egli vedeva come necessario e crudele antidoto alla supposta sovrappopolazione del pianeta (ovviamente, smentita dai fatti) – scrisse un libro sul pacifismo, notando come esso ha sempre fallito, avendo pure tra le sue declinazioni quel «pacifismo piagnucoloso» che tutti noi conosciamo, e mai un «pacifismo funzionale» in grado di portare avanti concretamente un ideale di pace fra le Nazioni.
Per una volta, c’è da essere d’accordo con uno spopolatore. Il pacifismo ha fallito. La sua dissoluzione, sotto i nostri occhi, non turba nessuno: rivela semplicemente la mascherata del progressismo globale, la sua facciata di cartone, la vuotezza e la sterilità degli urlatori prezzolati che lo sostenevano.
Eppure, oggi più che mai, è impossibile non sentire il valore della pace. La vera pace. Perché non si tratta di bombe che esplodono lontano, in un Medio Oriente che era più un luogo dello spirito che uno spazio reale. No: le bombe esplodono sulle nostre vite. Sulle famiglie di persone che conosciamo. Sulla nostra economia. Nei nostri supermercati. Nelle nostre case fredde perché devastate dalla pazzia delle sanzioni di guerra. Altro che «pacifismo funzionale»: la pace è un bisogno oggettivo per le nostre società, ora. Ma non ditelo a Giorgia Meloni: nel discorso più importante della sua vita, ha detto, da neopremier della Nazione, che avrebbe continuato il sostegno al valoroso popolo ucraino, cioè avrebbe continuato la guerra. Dichiarazioni nel medesimo senso le fa Crosetto, il suo ministro della Difesa.
La «pace funzionale» non interessa loro, sembra. Neanche quella da mandare giù come una cucchiaiata amara di medicinale. Tale mancanza di rispetto dell’interesse della popolazione umana è incomprensibile solo chi non ha capito il livello di disintegrazione raggiunto dalla nostra sovranità nazionale.
Tuttavia, c’è qualcosa di più che vorrei scrivere qui. La guerra ha diversi effetti. Ci sono gli eserciti, le economie, i giochi di poteri, la «continuazione della politica con altri mezzi». Poi c’è l’impatto sull’animo umano. C’è il male che la guerra fa alle persone, c’è l’orrore morale infinito, e la sofferenza, e il pianto, che fuori dalla pace distruggono il cuore degli esseri umani, uccidendo le persone a loro care nell’«inutile strage» programmata da coloro che comandano e che, in fin dei conti, odiano la vita.
Per questo mi è tornata in mente, in questi mesi di guerra, la figura di Vera Brittain (1893-1970). Una vera pacifista, e soprattutto, una donna devastata dal dolore che infligge l’assenza della pace.
La sua era stata un’infanzia stupenda. Spensierata, libera, felice. Poteva correre per i prati della campagna inglese attorno ai mulini della sua famiglia, con un unico, grande compagno di giochi: Edward Brittain, suo fratello. Con lui aveva vissuto gli anni fantastici della prima giovinezza, con lui aveva conosciuto il sorriso dorato della vita.
Quando venne il momento, sbalordì i suoi genitori per l’ostinazione con cui voleva andare a studiare ad Oxford. L’ebbe vinta, si iscrisse al corso di laurea in letteratura inglese. Ritrovò l’amato fratello Edward, che adesso aveva una cerchia di amici davvero divertenti: c’era Victor, c’era Geoffrey, e poi c’era… Roland.
Roland Leighton, era questo ragazzo pieno di vita che studiava i classici al Merton College di Oxford. Veniva da una famiglia di scrittori e artisti, era compito ed elegante, aveva il fuoco della vita che ardeva dentro in modo evidente. Vera si innamorò perdutamente, e perdutamente fu ricambiata.
Roland scriveva poesie, ed è impossibile non vedere come ogni verso fosse colmo dell’amore per Vera.
«Il sole sulla lunga strada bianca
Che fioccava giù per la collina,
La peonia di velluto che si aggrappava
Attorno al davanzale
Ti aspettano ancora.
Ancora una volta l’ombroso stagno deve rompersi
in riflessi ai tuoi piedi,
E quando gli uccelli cantano nella tua selva,
Non sanno che puoi incontrare
Un altro straniero, o mia dolce.
E se egli non è così vecchio
Come il ragazzo che hai conosciuto
E meno orgoglioso, e degno
Dovrai lasciarlo andare»
Di lì a poco, Roland chiese la mano di Vera.
Questa gioia aveva un nemico. Essa, come tutte le cose, dovette affrontare la nube nera che si addensava sopra il vecchio mondo; un mostro sanguinario che stava inghiottendo la vita e l’amore di tanti, tanti altri su tutta la superficie d’Europa: la guerra.
Era il 1914: il Comandante in Capo dell’Esercito inglese, Lord Horatio Kitchener, impose la coscrizione obbligatoria e creò 33 nuove divisioni pronte a combattere i tedeschi su suolo continentale. Roland fu arruolato e mandato al fronte francese. Anche Victor, Geoffrey e il fratello Edward andarono a combattere. Una situazione del tutto simile la potete vedere ben raccontata nel film biografico Tolkien, con studenti ragazzini buttati a morire o impazzire nel fuoco e nel fango delle trincee, laddove il futuro autore del Signore degli Anelli aveva forse avuto le prime visioni di draghi e terre devastate.
Vera interruppe gli studi per andare anche lei verso la guerra, come infermiera V.A.D., il distaccamento volontario di aiuto. Non era un lavoro semplice, né sicuro: i soldati che tornavano impestati di gas (la grande conquista tecnologica della I Guerra Mondiale) non raramente infettavano il personale medico che doveva curarli.
Vera non si perse d’animo mai, perché ogni giorno scriveva al suo amato Roland. Poi una notte, mentre ispezionava il filo spinato, Roland fu centrato all’addome da un cecchino austriaco. Il mostro, il drago aveva mangiato per sempre il sogno di questi ragazzi.
«Sembrava che non fosse rimasto più nulla al mondo, perché sentivo che Roland aveva portato con sé tutto il mio futuro e Edward tutto il mio passato» scrisse anni dopo la poetessa pacifista.
Nonostante il dolore, Vera continuò a servire la causa del suo Paese, prendendosi cura personalmente del fratello Edward tornato a Londra ferito. Anche Victor e Geoffrey, gli altri amici del cuore, erano morti… Edward una volta guarito fu rimandato al fronte, questa volta sull’altopiano di Asiago. I britannici volevano così rafforzare il fronte alleato meridionale dopo la disfatta di Caporetto, e contenere così l’incubo di uno sfondamento delle forze austro-tedesche.
Il 15 giugno 1918 una pallottola austriaca uccise anche Edward. A Vera non era rimasto più niente. Aveva solo i ricordi. Tanti, bellissimi, dolorosi. Nel 1922 intraprese il lungo viaggio che la portò al camposanto di Granezza, tra Lusiana ed Asiago, dove pianse sulla tomba di Edward. Dalla morte del fratello, dicono i biografi, non si riprese mai del tutto.
Carica di memorie, conclusasi la guerra trovò la forza di scrivere in un libro che divenne una sorta di manifesto proto-pacifista: Testamento della giovinezza (1933).
Potete trovare in esso la poesia «Perhaps» («Forse») dedicata a «R.A.L», che altri non è che il suo sposo promesso Roland, sacrificato al drago del fronte occidentale.
Forse un giorno il sole tornerà a splendere,
E vedrò che ancora i cieli sono azzurri,
E sentirò un altro giorno che non vivo invano,
Anche se priva di te.
Forse i prati dorati ai miei piedi,
Faranno sembrare allegre le ore di sole della primavera,
E troverò dolci i bianchi fiori di maggio,
Anche se sei morto.
Forse i boschi estivi brilleranno luminosi,
E le rose cremisi ancora una volta saranno chiare,
E il raccolto autunnale dei campi sarà una ricca delizia,
Anche se tu non ci qui.
Ma sebbene il tempo gentile possa rinnovare molte gioie,
C’è una gioia più grande che non conoscerò
Di nuovo, perché il mio cuore per la tua perdita
È stato rotto, molto tempo fa.
Vera divenne una sorta di eroina degli ideali di pace, ma fu spesso dileggiata dall’Inghilterra che stava muovendo guerra alla Germania hitleriana. Lamentò l’orrore del saturation bombing, cioè dei bombardamenti a tappeto britannici sulle città tedesche (memento Dresda) e fu quindi ; a guerra finita tutti finirono di accusarla di tradimento quando videro che nella lista nazista delle persone da arrestare appena conquistata la Gran Bretagna c’era anche lei.
La vita dopo la guerra continuò. Il crescente movimento pacifista pendeva dalle sue labbra. Ebbe il successo letterario, un marito, una figlia che sarebbe diventata ministro. Non ebbe indietro gli anni della felicità.
Poco prima di morire chiese a sua figlia di disperdere le sue ceneri sull’Altopiano, dove era caduto suo fratello. «Per più di cinquanta anni il mio cuore è stato nel cimitero di quel villaggio in Italia», disse.
Scrisse un altro libro di versi struggenti, Because you died («Perché sei morto»).
Poiché sei morto, non mi riposerò più,
Ma vagherò per sempre per il solitario mondo,
Cercando l’ombra di un sogno diventato vano
Perché sei morto.
Passerò brevi e oziose ore accanto
Ai tanti amori minori che ancora restano,
Ma in nessuno troverò il mio trionfo e il mio orgoglio;
E la lenta macchia corrosiva di Disillusione
Si insinuerà in ogni ricerca ma appena provato,
Perché ogni sforzo ora non darà nessun guadagno
Perché sei morto.
Mi è impossibile rimanere insensibile davanti a queste parole. Mi è impossibile pensare che tanti cuori in questo stesso momento, in russo o in ucraino, stanno componendo il medesimo dolore, la disillusione, la perdita.
Fermate la guerra, fatelo per porre fine, prima che alla devastazione di dighe e città, alla distruzione dell’anima umana. Fatelo per il pianto di tante donne russe e ucraine divenute anche loro come Vera. Che, peraltro, è un nome femminile anche in russo e significa «Fede».
Cosa serva per fermare la nuova «inutile strage», non lo sappiamo. Sappiamo che i vertici di Londra sono impegnati per impedire la pace, e, oggi come ai tempi di Roland, a buttare altre migliaia di vite nella fornace della guerra. Sappiamo che qualche proposta, anche poco credibile, è arrivata perfino dall’occupante il Soglio di Pietro. Quel che accadrà dopo le elezioni americane che si stanno consumando in questo preciso momento, non lo sappiamo, e non osiamo nemmeno ipotizzarlo.
Tuttavia, qualsiasi cosa succeda, deve essere chiaro che abbiamo un imperativo, che è quello di avviare la pace. Quella cosa che non corrompe il mondo, che non porta via per sempre i nostri cari, sacrificandoli al niente.
La vera pace. Per tutte le Vera di Russia e Ucraina, d’Europa e del pianeta.
Roberto Dal Bosco
Pensiero
Gli uomini invisibili di Crans-Montana

Giorni fa sono stato ad una partita di Hockey, un campionato internazionale europeo: prima della partita è stato chiesto un minuto di silenzio per il massacro di Crans-Montana, e tutti non solo hanno eseguito – compresi gli ultras facinorosi – ma si sono alzati tutti in piedi all’istante.
La maestra di cinese di mio figlio, che va al sabato in una classe fatta solo di bambini cinesi dove l’italiano lo si abbozza solo, ha parlato di Crans-Montana durante la lezione: neanche una donna cinese riesce a trattenere l’interesse, l’amarezza, forse perfino un cenno di lutto, dinanzi alla strage svizzera.
Ci sono quantità di conoscenti che da giorni discutono di questo, e nel rabbit hole, come gli americani chiamano l’immersione in un argomento oscuro e complesso, ci sono un po’ s finito anche io, pronto a misurare centimetricamente le possibile inesattezze della narrazione sui giornali. Sapete, un po’ come al Bataclan, cominciano a notarsi racconti discrepanti, un po’ tendenti a far sembrare le vittime come eroi – la vittima, lo abbiamo spiegato in un articolo di qualche tempo fa, nella nostra società ha un potere fortissimo.
Tutto il mondo è sconvolto. E a ragione: sono diecine di vite giovani falciate d’un tratto, incenerite nella demenza del capodanno (la notte dove, più di ogni altra, mi impongo di andare a letto prestissimo), sacrificate al niente in una località per ricchi.
Ci sono vari filoni dell’interesse giornalistico ed umano per l’ecatombe. Ci sono quelli che, inevitabile, attaccano i soccorsi. Il famoso sito di notizie partenopeo intervista un tizio del posto che lamenta le mancanze dei soccorsi. Eppure, a quanto era stato detto, in poche ore gli svizzeri avevano tirato su un ospedale da campo, e smistato in elicottero immediatamente i feriti gravi in tutti gli ospedali del Paese, saturando le terapie intensive e mandandone qualcuno pure a Milano.
Ho parlato con un sacerdote che è originario di un paesino del San Bernardo non lontano. Mi ha detto che la sorella lavora nelle ambulanze, e che in pratiche tutte le ambulanze disponibili si erano concentrate immediatamente sulla discoteca in fiamme – certo, chi conosce i posti di montagna sa che dalle città più vicine non si arriva in dieci minuti.
🚨🇨🇭 Tragedy in the Alps: 47 DEAD AND 115 INJURED AFTER NIGHT CLUB CAUGHT ON FIRE AT NEW YEARS EVE
New Year’s celebration turned nightmare at Le Constellation nightclub in Crans-Montana.
A flaming sparkler on a champagne bottle—held too close to the wooden ceiling—sparked a… pic.twitter.com/C8Syteq0pH
— Svilen Georgiev (@siscostwo) January 2, 2026
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Ma allora, se la colpa non è dei soccoritori, è dei proprietari del locale. Ecco che ti spuntano articoli sul passato del proprietario, che però, è riconosciuto, ha pagato il conto con la giustizia ed è uscito dai giri criminali da 20 anni, mentre la proprietaria, non trovando nulla, deve essere ricordata per qualche ragione come figlia di pompiere.
Dicono: una discoteca in un seminterrato, impossibile. Ma nessuno ha presente la realtà dei locali di montagna? Dicono: c’era solo un’uscita su per le scale; anzi no, scusate, l’uscita di sicurezza c’era ma era chiusa (ultima che si è sentita, chissà). Dicono: non avevano la licenza per far ballare la gente, ma di gente che ballava nei video non ne ho vista tantissima, certo i trenini di capodanno, ma sembra più un bar con i tavolini per le bottiglie di champagne, compresa quella probabilmente fatale.
Dicono: non era a norma. Poi salta fuori che invece le autorità svizzere (quindi… precise, no?) lo avevano giudicato a norma. E allora: ma l’ultimo controllo è stato nel 2020. E quindi? I controlli vanno fatti ogni anno? E se non vengono fatti, non è per caso per decisione o mancanza dei controllori?
Insomma, io la croce non la butto né sui soccorsi, e – a differenza della nostra diplomazia – nemmeno sui proprietari di Le Constellation (perché al maschile non lo sappiamo, ma ammettiamo che fa chic). I quali magari hanno salvato la pelle ma avranno la vita segnata.
Concludiamo la carrelata citando brevemente l’ebetudine complottista di chi dice che è stato un sacrificio umano programmato dalla malvagia élite mondialista: un’idea idiota degna degli scappati di casa che invece che lavorare stanno su Telegram. E lo dice una testata che del ritorno del sacrificio umano ha fatto uno dei argomenti fondamentali. I domofugi telegrammari dovrebbero nell’ordine, vergognarsi, stare zitti ed andare a lavorare, o, se impossibilitati, leggere un libro.
No, abbiamo un altro colpevole in mente, ben più problematico, e mostruoso: gli uomini invisibili.
Proprio così: la strage è stata causata dal fatto che nella scena, almeno dai filmati che possiamo aver visto, non si vede un uomo. Non c’è qualcuno che, come un uomo, prende l’estintore e si avventa sulle fiammelle, che potevano sembrare, almeno all’inizio, contenibili.
Non c’è nemmeno, sempre nei filmati, un uomo che prende e dice agli amici – magari alla sua stessa fidanzatina – di scappare. Non un uomo che abbia presentito, o anche solo sentito, il pericolo esiziale che si avvicinava.
Voi dite: ma erano ragazzini, era un evento pensato per diciottenni, anzi minorenni, forse perfino per ragazzini piccoli. Il discorso, per quanto ci riguarda, non cambia: a 16 anni non si è in grado di percepire la minaccia? A 15 anni non si sente la necessità di mettersi in salvo con i propri pari? A 18 anni è normale riprendere un incendio col telefonino invece che scappare, chiedere aiuto, proteggere i propri cari?
Ecco come ha avuto inizio l’incendio…
Ci sono responsabilità evidenti.#Crans_Montana
— IL RISOLUTORE ®️🇮🇹 (@ilrisolutoreIT) January 1, 2026
🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year’s Fire at Swiss Ski Resort Bar
A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year’s Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m.
Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT
— World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026
Sostieni Renovatio 21
C’è chi vuole farci credere questo. Leggiamo su Repubblica (giornale forse ora destinato alla rianimazione) un’intervista ad un importante «psicologo e psicoterapeuta» che dice che non bisogna criticare quelli che nel rogo filmavano invece che fuggire e far fuggire. «È una frase che fa male. Perché giudica senza capire. Perché arriva dopo, quando l’orrore è già accaduto, e cerca colpe dove servirebbe comprensione», spiega con generosità ed empatia l’esperto.
Poi ecco che, leggibile anche sui social, arriva lascienzah. È colpa del cervello, non di chi lo porta a spasso. «Fino ai 20-22 anni la corteccia prefrontale non è completamente sviluppata. È l’area che consente di valutare il rischio, pianificare una risposta efficace, controllare l’impulso» dice lo psico-specialista. «In una situazione di emergenza, fiamme, fumo, panico, un cervello adolescente non reagisce come quello di un adulto, non perché manchi la volontà, ma perché manca la piena maturazione delle funzioni di controllo».
Interessante: a questo punto, visto che i giovani insistono in assenza in cervello (almeno, non con il cervello sviluppato, secondo l’infallibile neuroscienzah), ma perché mai dovremmo farli votare? E ancora più importante: perché mai dovremmo farli guidare? Se non sono in grado di percepire il pericolo, non è che dobbiamo togliere a tutti gli under 25 la patente?
Ma il neurospiegone continua mutandosi in una struggente analisi di filosofia delle emozioni: «filmare può diventare un modo per creare una distanza emotiva da ciò che sta accadendo, uno schermo tra sé e l’evento traumatico. In psicologia questo è un meccanismo di difesa: aiuta a ridurre l’impatto emotivo, a non essere travolti, a reggere ciò che altrimenti sarebbe ingestibile».
Eccerto. Brutti voti, divorzio dei genitori, lutti in famiglia, cadute in bicicletta, rotture sentimentali, partite di basket perdute malamente: il ragazzino (ragazzino a 18-20 anni) filma sempre per schermarsi, ce lo insegna la psicologia. Quindi il video che abbiamo visto con i tizi che sghizzavano, musica rap in sottofondo, mentre il soffitto prendeva fuoco è un meccanismo di difesa psicologico. Grazie dottore. (Gli psicologi sono dottori?)
CRAS-MONTANA ROGO DEL LOCALE: 6 VITTIME TUTTE IDENTIFICATE
Sono Sofia Prosperi, 15 anni, e Riccardo Minghetti di 16, le ultime vittime italiane accertate della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, durante il rogo nella festa del locale Le Constellation. Deceduti… pic.twitter.com/ssgFvMgOQ6
— Claudia Sani 🍉 (@cla_sani0521) January 5, 2026
Minga è finita: ad una certa neurologia e psicologia, biologia neuronale ed emozione adolescienziale si danno la mano nel finale capolavoro di quest’analisi: «quando un ragazzo riprende invece di fuggire, non sempre sta facendo una scelta consapevole. Spesso sta cercando, nel modo che conosce, di proteggersi da un’esperienza che il suo sistema emotivo non è pronto a elaborare».
In pratica sono innocenti al punto che ci chiediamo se possiamo parlare di libero arbitrio dei minori – e certi lettori sanno dove questo discorso può andare a parare.
«La sicurezza non è una responsabilità dei ragazzi» tuona lo psicologo. «La sicurezza dei minori è un compito degli adulti, delle strutture, delle organizzazioni, delle istituzioni».
Ora, è proprio qui che saltano fuori gli uomini invisibili, e i loro danni mortali. Dire che un ragazzo non è responsabile di nulla significa lasciarlo in un limbo da cui non gli sarà mai possibile uscire, significa renderlo incapace di qualsiasi cosa – significa metterlo in pericolo.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Sappiamo che questa è esattamente lo schema del mondo moderno, per cui si diviene adulti automaticamente, anagraficamente, a 18 anni, e che tanto ha fatto per distruggere ogni possibile passaggio dell’individuo all’era adulta. Parliamo della fine dell’«iniziazione», della mancanza di un momento in cui il padre prende il figlio e lo rende uomo facendogli vivere un’avventura unica, facendolo passare per un rito anche pericoloso (le favole, come quelle di Pollicino, sono in sé racconti di iniziazione), di modo da certificare la fine della sua infanzia e l’inizio dell’era adulta.
Sappiamo pure che l’iniziazione nel mondo moderno è impossibile anche e soprattutto per la distruzione sistematica della figura che la guida: il padre. La Necrocultura, su tutti i piani – dalla sociologia, alla teologia, ai costumi, ai cartoni – lavora per la disintegrazione della figura paterna. In assenza del padre, per il ragazzo diviene impossibile completare il suo ciclo esistenziale.
Di qui si ha quello che è chiamata come «società degli eterni adolescenti». Perché l’assenza di iniziazione porta alla catastrofe di questa adolescenza prolungata che vediamo nei cosiddetti adulti: divorziano perché si innamorano della collega, e pazienza per i figli a casa; buttano i soldi nel SUV o nella vacanza all’estero; nei casi peggiori si drogano, non solo con gli stupefacenti proibiti, ma anche con quelli presi in farmacia, come gli SSRI, o l’alcol, la TV, la dopamina dei social, i videogiochi.
Gli «eterni adolescenti» non riescono a mantenere la parola, non riescono a fungere da genitori, perché non sono diventati mai adulti (non gli è stato, di fatto, permesso di farlo). E quindi non siamo sicuri che se la festa al Le Constellation fosse stata per 30-40-50enni l’esito sarebbe stato troppo diverso.
I lettori di Renovatio 21 conoscono la questione, descritta magnificamente da un poeta americano, Robert Bly, scomparso qualche anno fa. Secondo il poeta, la modernità ha indebolito l’essenza stessa della mascolinità, erodendo l’autostima degli uomini e rendendoli incapaci di trasmettersi reciprocamente forza e solidità. Questo fenomeno risulta particolarmente evidente, e soprattutto tragico, nella relazione tra padri e figli, dove la trasmissione di valori e autorità viene interrotta.
Bly attribuiva questo problema alla Rivoluzione Industriale, che aveva separato i padri dalla famiglia, trasferendoli dal contesto domestico a quello del lavoro esterno. L’assenza prolungata dei padri produceva una società instabile, priva di modelli autentici di comportamento maschile; di conseguenza, si diffondeva un profondo senso di inadeguatezza. «L’esperienza primaria dell’uomo americano è di essere inadeguato», aveva dichiarato Bly in un’intervista con il giornalista televisivo Bill Moyers.
La sparizione della figura paterna comporta anche la scomparsa dei riti di passaggio tradizionali: il giovane maschio non sa più riconoscere il momento in cui diventa adulto e, spesso, non desidera neppure diventarlo. Senza l’iniziazione guidata dal padre, gli individui rimangono bloccati in una condizione liminale, che inevitabilmente genera caos individuale e collettivo.
Droga, depressione, delinquenza, omosessualità, suicidio e vari disturbi maschili deriverebbero, secondo Bly, dall’estinzione della linea di trasmissione padre-figlio e dall’affermarsi di una società «orizzontale», che egli definiva «società fraterna», priva di gerarchie e di guide autorevoli. Noi, a differenza del poeta americano, possiamo pure azzardare che senza padre, questa società orizzontale più che fraterna è una società matriarcale. (Colpisce il racconto, pure ancora un po’ confuso, di madri che sono entrate nel locale per cercare i ragazzi: i padri dove erano?)
Dalla distruzione dell’iniziazione – dalla distruzione del padre – vengono quindi tanti mali della società, come la violenza: non è sbagliato, a questo punto, ipotizzare che l’ingrediente di certe stragi sia questa assenza della maschilità formata. In ogni massacro, cioè, c’è probabilmente di mezzo un eterno adolescente (di tutte le età) e quindi un uomo mancato, un uomo invisibile.
Aiuta Renovatio 21
Ora, se vogliamo dire che questo è un ulteriore programma dei padroni del mondo, vi dico: certo. Questo sito lo sostiene da anni: il mondo moderno, lo Stato moderno, operano per la depatriarcalizzazione, e per obbiettivi specifici. Togli il padre, hai tolto l’uomo, hai tolto la protezione alla popolazione, specialmente dei più piccoli: e questo vale per tutti i lupi che vi sono là fuori, dai pedofili ai criminali agli enti rapitori dei bambini ai lupi veri e propri, che per qualche ragione abbondano sempre di più nelle nostre terre. Togli il padre, e quello che ottieni è l’inferno, e le immagini parlano chiaro.
J’accuse Jessica et Jacques Moretti, propriétaires et gérants du bar “Le Constellation” à Crans-Montana de meurtre de masse et d’avoir le 1er Janvier 2026 mis volontairement la vie en danger d’autrui et faits aggravants, en l’espèce, de mineurs !#cransmontana #leconstellation pic.twitter.com/8kELRFA9bZ
— catsnmouse (@catsnmouse) January 2, 2026
Togli gli uomini, e quello che ottiene è il controllo assoluto sul genere umano: ecco che le persone si fanno pascolare e portare al macello come bovini, e qui abbiamo parlato appunto di massa vaccina.
Sembra ridicolo, ma quello che dobbiamo chiedere ai ragazzi è di non esserlo più. Dobbiamo chiedere ai bambini di essere uomini. Dobbiamo portarli, per mano, a divenirlo.
Dobbiamo farlo per il loro bene. E per il nostro. Perché questo è ciò che serve per la continuazione dell’umano. È la prima tradizione che serve.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Geopolitica
FAFO Maduro, dottrina Donroe e grandi giochi di prestigio – Europa compresa

Sostieni Renovatio 21
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Pensiero
Natale, abbondanza, guerra, sterminio, sacrificio

L’anno scorso abbiamo pubblicato un panegirico della mangiata domenicale, indicando quanto sia sublime, e giusto – perché, spiegavamo, in linea con la Legge naturale – riempirsi di cibo al pranzo della domenica con la famiglia sino a stordirsi ed addormirsi.
È quella sensazione di sazietà che molti, come me, provano nel momento in cui scrivo, reduci dal pranzo di Natale 2025: si è sazi, satolli, olfi, secondo un termine della lingua veneta che indica l’essere rimpinzato sino a non poterne più.
Di fatto, non è solo di cibarie che ci si sente colmi. Il periodo che viene prima del Natale è di per sé un lungo pasto rituale, con tutte le sue preparazioni, da eseguirsi trattenendo il fiato tra le gioie (sempre) e le fatiche della programmazione. Suppongo che questo sia il raggiungimento di un modo adulto di sentire il Natale, quel sentimento che avevamo tutti da piccoli, e che chissà dove si è perso.
Perché mi sono oramai abituato, al piccolo calendario di metà dicembre, con la sua accelerazione di eventi. Non parlo delle cene aziendali e dei club sportivi: quelle pure ci sono, ma, no, non fanno sentire il Natale, anzi: spesso mi sembrano tentativi falliti di tornare a quel sentimento perduto, a quella bontà che le aziende e le associazioni sanno di non poter praticare.
Parlo, invece, di ciò che concerne il Natale dei bambini. Il Natale in purezza, vissuto attraverso tante microtradizioni acquisite.
Sostieni Renovatio 21
La sequela è fittissima: c’è il saggio di danza della bambina. C’è l’ultima partita di basket del bambino. C’è la festa di fine anno della scuola. C’è la corsa per i regali (con pianificazioni vertiginose, calcoli logistici, code chilometriche).
C’è la visione dei film natalizi: Mamma ho perso l’aereo anche quest’anno ha esercitato la sua potenza magnetica al limite dell’inspiegabile.
C’è la tradizioncina stabilita di mandare mamma e figlia, o anche tutta la famiglia, a teatro per il balletto: vedere lo Schiaccianoci prima di Natale è usanza diffussissima in tanta parte di Europa come in America. Quest’anno, per qualche ragione, è toccato un altro Tchaikovsky, La bella addormentata, ma va bene lo stesso.
C’è la cena della vigilia, che si consuma solo con un pezzo di salmone, del pancarré tostato e riccioli di burro – un lascito di quando vivevo a Milano e prima di Natale sgomitavo dal Peck (antica e prestigiosissima gastronomia vicino al Duomo) nel mezzo di una selva dei clienti inferociti per portarmi a casa una fetta di salmone a 66 euro, e consumare solo quella con i miei cari, in un unico atto di lusso poverissimo ma tanto appagante.
C’è la Messa di mezzanotte, che oramai facciamo da anni, con tutte le fatiche della sua organizzazione. Poi eccoti una massa di bambini che dorme abbracciata ai genitori o nascosti sotto i legni del coro. Si torna tardissimo, i bambini sono già crollati in auto, il genitore deve star sveglio ancora per posizionare i regali sotto l’albero e piazzare il Bambin Gesù nella sua culla nel presepe.
C’è il mattino del 25, dove si viene per forza destati dai bambini che vogliono aprire i regali, e inizia tutto questo rituale della felicità, i nomi sui pacchetti, la sorpresa, l’irrazionalità di quello preferito rispetto a quello che si immaginava il regalo principale (il più gradito quest’anno: un paradenti, prontamente attivato con tutta la procedura di acqua bollente, acqua fredda, morsi, etc.)
Allegria, soddisfazione, amore. Innocenza. Voi capite che uno è già sazio così, uno non ha bisogno di nient’altro. Specie se ci si ritiene proletari nel vero senso della parola: io ho solo la prole, io vivo per essa, in essa trovo la mia ragione, la mia pienezza. Non ho bisogno di altro: né cene costose, né belle automobili, né abiti firmati, né viaggi nel mondo – non ho bisogno, soprattutto, del giudizio degli altri, perché quanto vivo con la mia famiglia non lascia posto ad altro, è la plenitudine definitiva, e ci dispiace per gli altri.
Tante cose. Tanta abbondanza. Non si può non essere grati di tutto questo.
Al contempo, dentro di me, e fuori di me, c’è una certezza altrettanto enorme: che tutto questo può esserci tolto.
Non parleremo, ora, della questione dello Stato distruttore delle famiglie: stiamo vedendo in questi giorni cose agghiaccianti, bambini sottratti con una violenza istituzionale persino maggiore di quella di cui si occupò Renovatio 21, i primissimi fans se lo ricorderanno, oramai più di un lustro fa…
No, parliamo di qualcosa di più radicale. Parliamo della fine della felicità natalizia, la fine della piccola grande abbondanza delle nostre famiglie, la fine dell’innocenza dei bambini che una guerra può portare.
La guerra potrebbe partire ed arrivarci in casa d’improvviso. Ci dispiace per coloro che non lo comprendono – e sappiamo pure che costoro costituiscono un problema reale, perché sono, o alimentano, coloro che in guerra ci vogliono portare.
Un uomo vero, una donna vera, un padre di famiglia, una madre non possono non pensarci più volte al giorno: viviamo la situazione di tensione bellica più grave della storia umana. I vertici non eletti dell’Europa, ma spesso pure quelli eletti, ci hanno portato ad un duello con la più grande potenza termonucleare del pianeta, la Nazione immensa che ha sconfitto Napoleone e Hitler (due che volevano l’Europa unita…) e pagato l’ultima guerra mondiale con 26 milioni di morti.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Ci vogliono portare allo scontro con un Paese che ha mostrato in TV che i suoi missili ipersonici – non intercettabili da nessuna tecnologia contraerea esistente – possono raggiungere qualsiasi capitale europea in meno di quindici minuti dal lancio. E, come ricordiamo spesso su Renovatio 21, ci sono armi ancora più allucinanti, come il drone Poseidon, in grado di creare tsunami radioattivi in grado di sommergere l’intero arcipelago britannico, e per la penisola italiana ci pensiamo anche.
Ci vogliono mandare in guerra con la Russia che, tra droni e battaglie urbane e boschive, in Ucraina ha ridefinito la guerra moderna.
Ci vogliono in conflitto con una potenza militare immensa pure quando i nostri protettori, gli Stati Uniti, si sono chiamati fuori – e le ragioni di questa ostinazione suicida non sono sufficientemente chiare, si può scomodare l’odio massonico, Nostra Signora di Fatima o pure la sola demenza ideologica dei nostri corrotti funzionari di vertice.
Ci vogliono far combattere contro un colosso, e magari anche col suo alleato cinese, quando – questo è chiaro a tutti – i russi non ci odiavano, anzi. E non parliamo solo degli affari del gas e dell’import-export: alzi la mano chi non ha testimoniato, nell’ultimo quarto di secolo, il ritorno dei russi nella scena europea, che sia la cultura o il turismo, che sia la danza classica o il matrimonio.
La mia non è un geremiade che parte solo da un ragionamento razionale, storico, geopolitico. È la somma di sensazioni che ho, in continuazione.
Oggi, durante il pranzo di Natale dai suoceri, è mancata la luce due volte. Niente di che, è tornata, chissà cos’era, forse riguardava solo la casa. Tuttavia, se avete letto fin qui capite quanto l’immagine calzi a pennello: l’abbondanza familiare delle nostre vite interrotta improvvisamente al suo apice, perché quale credete sarà uno dei primi segni del conflitto iniziato?
Ieri un momento ancora più preoccupante. Un boato fuori dalla finestra, mentre stavo lavorando al sito. C’è un caccia che vola bassissimo. Dove va? C’è una grande base militare americana qui vicino (diverse, in realtà), ma è raro vedere un aereo da combattimento che vola da solo a quest’altezza.
Pensi: perché lo fa? Lo sa che decine, centinaia di migliaia di persone sotto, nella serie infinita di case e condomini della città che sorvola, lo stanno vedendo, allertati dal suono del suo passaggio? Questa mancanza di riguardo per i civili indica qualcosa? È iniziato il momento in cui i riguardi dei militari nei confronti della popolazione sono finiti?
Anche questo, statene certi, sarà un segno: vedrete aerei armati che improvvisamente traversano il cielo vicino a voi. I primi saranno quelli vostri, o dei «Paesi alleati», che si spostano in fretta, perché sta succedendo qualcosa in direzione del nemico. Se non lo avete visto in qualche film di Hollywood, consiglio un titolo cinéphile che di questo segno degli aerei che sfrecciano in cielo come uccelli dell’apocalisse aveva fatto una poesia insuperabile. Offret del maestro Andrej Tarkovskij, che in italiano si chiama Sacrificio (1986).
Ambientato in Isvezia – dove credo il regista sovietico aveva trovato i fondi per il suo ultimo film, dopo essere stato in esilio in Italia – il film racconta, con lo stile opaco e suggestivo tipico tarkovskiano – di un vecchio intellettuale che presagisce la fine del mondo nella sua casa nel bosco, dove incontra una strega, recita il pater noster e infine decide che il sacrificio della sua stessa esistenza è quello che può dare per scongiurare l’apocalissi, qui fatta solo intuire dal geniale cineasta solo con il rombo degli aerei che scuote la terra e il cielo.
Aiuta Renovatio 21
Nel film il protagonista, dinanzi all’immane enigma della distruzione, si risolve a dar fuoco alla propria casa: quella che sembra una psicosi è in realtà una reazione che potremmo vedere nella gamma dei nostri politici, che ci vogliono portare a morire.
Noi, con le nostre famiglie, siamo molto più vicini alla devastazione atomica di quanto non lo siano stati i protagonisti di tanti film. E lo siamo ora.
È una realtà spaventosa, che non credevamo che ci sarebbe toccato di vivere, non dopo la fine della Guerra Fredda, non dopo decadi di pace – e ci rendiamo conto che in molti non lo hanno ancora capito, così come non hanno capito che la guerra questi la vogliono far sul serio, perché non solo possono, senza poesia né mistica, dar fuoco alla propria casa, ma perché vogliono, soprattutto, incenerire gli esseri umani e tutto il loro mondo.
Sì: chi vuole la guerra oggi lo fa perché odia il genere umano. Lo fa perché vuole lo sterminio. È questo che non entra in testa a tantissimi: non ci sono più, al comando, persone che hanno a cuore il prossimo, e temono l’inferno. Ci sono, in cima alla piramide, uomini e donne che lavorano per la morte, e all’Inferno non credono (pur essendone gli agenti diretti).
Non si è compreso che a comandare in questo momento c’è, in una parola, la Necrocultura. Che il fine del sistema, adesso, è la morte, è il genocidio, è la prospettiva pantoclastica, la distruzione ulteriore, la devastazione apocalittica in odio dell’Imago Dei. È il dolore e la cancellazione della dignità umana.
Il sistema che promuove l’aborto, l’eutanasia, la predazione degli organi, gli psicofarmaci, le mutilazioni pediatriche, i vaccini e la nuova guerra i vostri alberi di Natale li vuole bruciare con il fuoco atomico. E con essi, voi e i vostri bambini.
Provate a pensarci: non potrebbe essere altrimenti.
Resto, al termine di questa riflessione, con un pensiero tremendo: la nostra abbondanza non vale nulla, perché non è al sicuro. La nostra prole è in pericolo, e nel momento in cui la vediamo felice dobbiamo esserne più consapevoli che mai.
Quale sia il sacrificio che ci è chiesto per riportare l’equilibrio del mondo ora non lo dirò. Ma, statene certi, prima o poi ci verrà richiesto, e dobbiamo pregare perché non sia troppo tardi.
Buon Natale a tutti.
Roberto Dal Bosco
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Pensiero7 giorni fa
Pensiero7 giorni faGli uomini invisibili di Crans-Montana
-



 Geopolitica1 settimana fa
Geopolitica1 settimana faFAFO Maduro, dottrina Donroe e grandi giochi di prestigio – Europa compresa
-

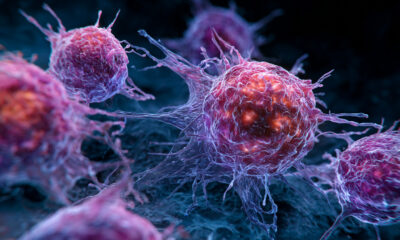

 Cancro2 settimane fa
Cancro2 settimane faVaccini COVID-19 e cancro: l’argomento tabù
-



 Immigrazione2 settimane fa
Immigrazione2 settimane faUn altro capodanno nell’anarco-tirannia migratoria
-



 Stragi2 settimane fa
Stragi2 settimane faDisco-inferno: strage di Capodanno nella prestigiosa stazione sciistica svizzera – video
-



 Spirito5 giorni fa
Spirito5 giorni faConcilio Vaticano II, mons. Viganò contro papa Leone
-



 Alimentazione4 giorni fa
Alimentazione4 giorni faRFK Jr. capovolge la piramide alimentare
-



 Animali1 settimana fa
Animali1 settimana faAgricoltore assalito dai lupi, anarco-tirannia animale in azione



















