Spirito
Capire la Chiesa: il rito mozarabico

La liturgia mozarabica è un’antica liturgia latina spagnola. Fu codificata dai concili e dai Padri di questa Chiesa già nel IV secolo e raggiunse il suo periodo d’oro nel VII secolo sotto il regno visigoto. Cercando di sopravvivere sotto il dominio musulmano, finì per quasi scomparire dalla Spagna a favore della liturgia romana, per poi rinascere secoli dopo.
Mozarabico, un nome discutibile
Il termine mozarabico (Muzarabes, mostarabes), sia esso derivato da musta’rab o mixto-arabo, significa «arabizzato» e designa la popolazione cristiana che, dopo l’invasione della Spagna nel 712, fu sottomessa al giogo degli arabi. Applicato alla liturgia spagnola, è inappropriato, poiché la liturgia che designa è anteriore alla conquista.
In effetti, questa liturgia fu per un certo periodo anche quella dei cristiani non soggetti agli arabi, e non ha nulla in sé di specificamente mozarabo; anzi, si può dire che i mozarabi si accontentassero di mutuare dall’antica liturgia ispanica o da altre liturgie. Tuttavia, questo nome ha prevalso ed è utilizzato dalla maggior parte degli autori.
Anche i nomi di rito visigotico, rito di Toledo, rito isidoriano, rito ispanico, gotico o spagnolo, proposti per sostituirlo, non sono del tutto esatti. In ogni caso, questo termine designa una liturgia che fu propria della Spagna fin da quando se ne può ricostruire la storia e che fu mantenuta fino al XII secolo.
Anche dopo la sua soppressione di fatto, continuò a essere praticato in alcune rare chiese, per poi essere ripristinato ufficialmente nel XVI secolo nelle chiese di Toledo, dove è praticato ancora oggi, dopo l’applicazione di una riforma seguita al Concilio Vaticano II.
Sostieni Renovatio 21
Traguardi storici
La liturgia mozarabica è basata sul latino. Il rito è simile ad altre liturgie latine: italica (Roma, Aquileia, Milano), africana, gallicana e celtica. Presenta molte analogie con l’antico rito gallico. Sono presenti anche numerosi elementi bizantini.
Questa liturgia forma un insieme coerente che presenta caratteristiche nazionali ben definite. I 18 concili di Toledo, celebrati dal 400 al 702, e i Padri spagnoli del VI e VII secolo contribuirono a darle la sua organizzazione e, soprattutto, la sua fisionomia.
I santi Leandro e Isidoro di Siviglia, Giuliano e Ildefonso di Toledo svolsero per questo rito lo stesso ruolo che i santi papi Damaso, Leone Magno, Gelasio e Gregorio Magno ebbero per il rito romano. Sotto il regno dei Visigoti, convertiti alla fede cattolica, questi Padri organizzarono questo rito. Quest’opera congiunta dei grandi dottori spagnoli produsse una delle liturgie più originali esistenti.
L’invasione musulmana
Dopo la conquista musulmana del 711, i cristiani rimasti nella penisola poterono, in virtù dello status di dhimmi che l’Islam imponeva alla «Gente del Libro», conservare le proprie proprietà e praticare liberamente la propria religione, in cambio di una tassa pro-capite, la djizya, versata al sovrano regnante.
Numerosi nelle città di Toledo, Cordova, Siviglia e Mérida, questi cristiani, sottoposti all’autorità musulmana e in seguito chiamati mozarabici, godevano di una certa autonomia. Sebbene fosse loro proibito costruire nuove chiese, riuscirono a mantenere la gerarchia ecclesiastica. I loro vescovi venivano convocati in sinodi regolari sotto l’autorità del Metropolita di Toledo.
Per quasi quattro secoli, i mozarabici furono isolati dal resto del cristianesimo, e così la loro liturgia, come le loro arti, si irrigidì e cessò di evolversi. Questo spiega perché questo rito riuscì a preservare molti arcaismi liturgici. Ma dall’XI secolo in poi, i regni di Navarra e Aragona adottarono la Regola di San Benedetto e il nuovo Rito Romano.
In quel periodo, l’Ordine di Cluny inviò i suoi monaci a costruire monasteri lungo tutto il Cammino di Santiago. Si trattò di una rivoluzione culturale, che sarebbe stata più difficile nelle province appena conquistate, dove musulmani e mozarabichi negoziarono la loro sottomissione come corpi costituiti.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Un giudizio tramite il fuoco
Ben presto, i regni di Navarra e Aragona abbandonarono la liturgia mozarabica in favore di quella romana. Re Alfonso VI di León e Castiglia (1040-1109), figura chiave della Riconquista, cercò di introdurre il rito romano nei suoi stati al posto delle usanze mozarabiche.
Di fronte al sincero affetto del suo popolo, ritardò l’atto formale di soppressione. Ma nel 1080 promulgò l’abbandono del rito romano. Nel 1085, Toledo fu riconquistata, ma i toledani protestarono la loro fedeltà all’antica liturgia di Sant’Isidoro e San Giuliano.
La Cronaca di Najera riporta l’autodafé che ebbe luogo in quel periodo. Un messale romano e uno mozarabico furono gettati nel fuoco; quello che bruciò sarebbe stato condannato a scomparire da Toledo. Il mozarabico rimase nel fuoco ma non bruciò; quello romano balzò fuori, senza consumarsi. Il segno fu interpretato come la risposta di Dio affinché i due riti potessero coesistere.
La popolazione poté continuare a celebrare la liturgia mozarabica in sei parrocchie di Toledo. Ma al di fuori di questa città, il rito scomparve quasi ovunque nei territori gradualmente riconquistati. Al di fuori delle sei parrocchie di Toledo, solo pochi luoghi molto rari mantennero la celebrazione del rito, il più notevole dei quali è la Basilica di San Isidoro di León, che era una necropoli reale.
Il restauro del cardinale Cisneros
Francisco Jiménez, Cardinale de Cisneros (1436-1517), fu una figura di spicco del Rinascimento spagnolo. Francescano austero e ascetico, fu scelto come confessore da Isabella la Cattolica, che lo nominò Arcivescovo di Toledo e Primate di Spagna.
Il cardinale Cisneros divenne in seguito un politico di spicco, ricoprendo in diverse occasioni la carica di reggente di Castiglia e rafforzando il trono del giovane Carlo V. Come capo della diocesi di Toledo, era preoccupato per il declino delle tradizioni mozarabe nella sua città.
Raccolse quindi una grande quantità di manoscritti mozarabici da tutto il regno e fece stampare per la prima volta il messale mozarabico (1500) e il breviario (1502). Il rito mozarabico, così fissato dalla stampa, fu salvato. Il rito mozarabico restaurato da Cisneros fu pienamente riconosciuto dalla Chiesa.
I fedeli che lo seguivano godevano di diritti speciali e formavano una comunità canonica, sia civile che liturgica. Nonostante i tentativi di sopprimerla, essa fu mantenuta: attualmente ci sono 2.000 fedeli appartenenti al rito mozarabico per nascita e battesimo in questo rito, o per matrimonio.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Particolarità del rito mozarabico
I] Prima della Messa
1. La Messa inizia con l’Introito, detto officium: esso è tratto dai Libri Sacri o dagli atti del santo di cui si celebra la festa.
2. Gloria in excelcis e colletta. Il Gloria è incorniciato dal Per omnia secula seculorum. Dopo il Per omnia finale, il sacerdote recita una preghiera. La colletta, chiamata qui oratio, è spesso rivolta direttamente a Cristo. Non ha né la sobrietà, né la precisione, né il ritmo della colletta romana.
3. Letture. C’è una lettura dall’Antico Testamento, una da San Paolo, la terza è il Vangelo. La prima si chiama Profezia , la seconda l’ Epistola o l’ Apostolo , la terza il Vangelo. La Profezia si omette la domenica; in Quaresima e nei giorni di digiuno, ci sono quattro letture.
4. Psallendo. Dopo la profezia si canta il cantico dei tre fanciulli (Libro di Daniele) con il primo versetto del salmo Confitemini. Questa era anche l’usanza nella liturgia gallicana. Il psallendo che segue è un responsorio che il cantore cantava da un pulpito.
5. Tratto. Gli antichi libri mozarabici contengono un trattato, il Tractus, che veniva cantato dall’ambone. Differiva dal trattato romano in quanto il trattato gregoriano segue il graduale e sostituisce l’alleluia , mentre il trattato mozarabico sostituisce lo psallendo.
6. Preghiere diaconali. Oggi è il sacerdote a preparare il calice, ma in passato era il diacono a farlo e doveva recitare le preghiere diaconali: sono una reliquia del passato, ancora conservata nelle liturgie orientali, ma di cui la liturgia romana ha conservato solo rare vestigia.
7. Epistola. Dopo il canto del psallendo e le preghiere diaconali, il sacerdote ordina il silenzio: Silentium facite, e il lettore legge l’epistola che comunemente veniva chiamata, come in Gallia, Italia, Africa e altri paesi, l’Apostolo .
8. Vangelo. Il Vangelo fu subito riservato al diacono. Lo stesso avvenne in Gallia.
9. La Lauda. Segue il Vangelo. È composta dall’Alleluia e da un versetto, generalmente tratto da un salmo. È cantata dal cantore.
Aiuta Renovatio 21
II] La Messa dei fedeli.
1. Offertorio. Il sacrificium che segue queste preghiere risponde all’offertorio. Mentre il coro canta il sacrificium, (il vescovo) i sacerdoti e i diaconi ricevono le oblazioni del popolo, il pane e il vino. Al segnale, il canto del sacrificium si interrompe e il sacerdote (o il vescovo) recita l’Accedam ad te.
2. Missa. Il sacerdote recita una preghiera chiamata Missa. Poi menziona i sacerdoti che offrono, il Papa, i sacerdoti e gli altri sacerdoti. Segue la commemorazione degli apostoli e dei martiri. L’elenco dei nomi dei vivi è seguito da quello dei defunti.
3. La preghiera post nomina. La memoria dei defunti non è separata dalla memoria dei vivi, come nella Messa romana. Inoltre, i dittici in Spagna contenevano i nomi dei santi dell’Antico Testamento, patriarchi e profeti.
4. La preghiera per la pace e il bacio di pace. Il bacio di pace, riferito al momento della comunione nella liturgia romana, precede in Spagna, come in Gallia e in Oriente, la consacrazione .
5. Il sacrificio o canone. Inizia con l’inlatio o illatio che rappresenta il prefazio. L’ ill atio mozarabico termina con il sanctus e il sanctus in Spagna come in Gallia, a differenza di Roma, è seguito da una preghiera il cui titolo è sempre Post sanctus.
6. Il Sanctus. L’illatio si conclude con il passaggio al Sanctus, che nella Messa mozarabica non è invariabile come nella liturgia romana e nella maggior parte delle altre liturgie.
7. Post Sanctus e Consacrazione. Il titolo Post Sanctus si riferisce a una preghiera che è una parafrasi del Sanctus. È una transizione tra il Sanctus e la consacrazione, che si ritrova anche nelle liturgie greche e orientali. In passato esisteva una forma speciale di consacrazione, sostituita dalla formula romana nel XVI secolo.
8. Preghiera Post-Pridie. La preghiera Post- Pridie che segue la consacrazione corrisponde a quella che nei libri gallicani viene chiamata Post-secreta o Post-mysterium. Varia e a volte è molto lunga. È una di quelle preghiere in cui la ricchezza dei Padri spagnoli ha dato libero sfogo.
9. Credo. Gli spagnoli furono i primi in Occidente a introdurre la recita del Credo nella Messa. Gli spagnoli, come i greci e gli orientali, collocandolo alla fine del canone prima del Pater, alterano un po’ l’equilibrio generale di questa parte della Messa.
10. Frazione. La frazione è complessa. Il sacerdote divide l’ostia in nove parti, disposte a forma di croce, e a ogni frammento viene dato un nome: Incarnazione, Natività, Circoncisione, Epifania, Passione, Morte, Resurrezione, Gloria e Regno. La frazione è accompagnata da un canto.
11. Pater. Si recita nella Messa mozarabica, come nella maggior parte delle liturgie. Si conclude con un’embolizzazione (come nel rito romano), intitolata Liberati (Libera nos nel rito romano).
12. Commistione. Dopo l’embolizzazione, il sacerdote prende sulla patena il frammento dell’ostia corrispondente alla gloria e lo mescola al vino del calice con la formula: Sancta sanctis, «Ciò che è santo per i santi», che proviene dalle liturgie orientali.
13. Benedizione. Il rito della benedizione, in Spagna come in Gallia, si svolge dopo il Pater. Il diacono ammonisce il popolo e il sacerdote benedice con una formula variabile.
14. Comunione. La Comunione è preceduta dalla preghiera. Quindi il sacerdote riceve la comunione e consuma tutti i frammenti secondo un ordine specifico prima di ricevere il Preziosissimo Sangue. Quindi i fedeli ricevono la comunione sotto entrambe le specie, separatamente: il sacerdote distribuisce l’ostia e il diacono amministra la comunione dal calice.
Durante la comunione si canta l’Ad accedentes (Gustate e vedete quanto è buono il Signore). La cerimonia è seguita da una post-comunione e da una completoria che varia a seconda del tempo.
15. La fine della Messa viene annunciata come segue: il sacerdote saluta il popolo con il Dominus sit, quindi il diacono annuncia: «La nostra celebrazione è terminata. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, accolga in pace i nostri desideri e le nostre preghiere», prima di congedare i fedeli.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Antoine Taveneaux via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Spirito
Concistoro: i cardinali relegano la liturgia in secondo piano

Il crogiolo delle priorità
Il cuore del concistoro poggiava su un voto cruciale. Quattro temi erano stati proposti dal Papa: l’evangelizzazione, la riforma della Curia, la sinodalità e la liturgia. A causa di presunti «limiti di tempo», ai cardinali è stato chiesto di sceglierne solo due, a maggioranza. Il risultato è rivelatore. La sinodalità e la missione sono state approvate a stragrande maggioranza, relegando la liturgia – così come la riforma della Curia – a un ruolo secondario. Questa decisione è estremamente significativa. Infatti, mentre i mezzi dell’azione missionaria possono essere dibattuti, è a dir poco preoccupante vedere la preghiera pubblica della Chiesa, la lex orandi intimamente legata alla lex credendi, considerata una priorità secondaria.Aiuta Renovatio 21
Un silenzio significativo
Questo silenzio sulla liturgia non è passato inosservato. Ancor prima dell’apertura del concistoro, diversi organi di stampa, tra cui l’agenzia di stampa Zenit e la stampa italiana, hanno indicato che un considerevole gruppo di cardinali desiderava specificamente porre questo tema al centro delle discussioni. Per loro, l’attuale crisi liturgica è inseparabile dalla crisi di fede. Avevano auspicato una seria riflessione sulle tensioni causate dalle restrizioni imposte da Traditionis Custodes, nonché un gesto di pacificazione nei confronti dei fedeli legati alla liturgia tradizionale. Non è successo nulla del genere. Il «respiro» della Chiesa – la sua preghiera – sembra essere stato sacrificato sull’altare della sinodalità. Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ha tentato di minimizzare la portata di questa esclusione, affermando che nessun argomento era stato definitivamente escluso e che il papa era stato «informato dell’urgenza percepita» di alcune questioni. Da chi? Secondo quali criteri? La formulazione rimane volutamente vaga. È stato anche specificato che gli argomenti non selezionati potevano essere «affrontati nell’ambito dei temi scelti», un modo elegante, direbbero alcuni, per diluire i problemi anziché affrontarli. Una strategia di elusione? Per alcuni osservatori, questa decisione deriva da un calcolo tattico. Eletto meno di un anno fa, Leone XIV starebbe cercando di evitare uno scontro diretto su una questione liturgica diventata altamente controversa, dove due visioni inconciliabili della Chiesa si scontrano frontalmente. Mettendo l’accento sulla missione e sulla sinodalità, egli cerca di costruire unità d’azione prima di riaprire questioni più delicate. Ma questa strategia comporta un rischio importante: quello di rinviare indefinitamente la cura di una ferita aperta. La liturgia non è un argomento qualsiasi; è il cuore pulsante della vita della Chiesa. Finché la questione liturgica rimarrà irrisolta, qualsiasi tentativo di «pace ecclesiale duratura» rimarrà illusorio. Questo concistoro avrà quindi lasciato irrisolte questioni fondamentali. La riforma amministrativa della Curia e, soprattutto, il ripristino di una liturgia fedele alla tradizione bimillenaria della Chiesa sono questioni che il pontificato di Leone XIV dovrà affrontare prima o poi se vorrà davvero garantire l’unità e la vitalità della Chiesa cattolica. Articolo previamente apparso su FSSPX.NewsIscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Spirito
Il cardinale Müller: il «cristianesimo culturale» crea idoli. Poi attacca Thiel e Harari

Il cardinale Gerhard Müller ha affermato che la Chiesa cattolica è «l’unica autorità morale credibile», contrapponendola alla pura volontà di potenza dei tecnocrati. Lo riporta LifeSite.
In un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt, il cardinale Müller ha affermato: «nel mondo odierno, se si guarda al mondo nel suo insieme, il papa e la sua Chiesa sono le uniche autorità morali credibili: i principi morali vengono proclamati per se stessi e non sono contaminati dal potere e dall’influenza».
Il porporato germanico contrapposto il ruolo della Chiesa nel proclamare la verità a quello dei tecnocrati assetati di potere, menzionando specificamente il magnate della tecnologia Peter Thiel e lo scrittore ateo Yuval Noah Harari, entrambi omosessuali.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
«La nuova teoria di classe presuppone che i ricchi e i potenti abbiano un diritto alla vita maggiore rispetto alla stragrande maggioranza delle ‘persone inutili’, come le chiama Yuval Noah Harari», ha affermato il cardinale. «Dovrebbero semplicemente essere tenuti a tacere con droghe e programmi di intrattenimento».
«Credo che ci troviamo di fronte a una sfida importante perché molti di coloro che stanno realizzando grandi cose nella tecnologia stanno sviluppando idee disumane e dimostrando di essere filosoficamente disinformati. La tecnologia deve sempre essere al servizio delle persone, non il contrario».
«Queste persone credono che il progresso tecnologico porti al progresso morale. Tuttavia, il progresso morale dipende sempre dall’individuo e non può essere controllato collettivamente», ha affermato il prelato. «La tecnologia può aiutare, ma è legata all’etica. Posso usare un coltello per tagliare una mela o per uccidere un’altra persona. Qualsiasi mezzo tecnico può essere usato in modo improprio».
«In un mondo dominato da tecnocrati che si considerano i pochi eletti, chi definisce cosa è bene e cosa è male?», ha chiesto il cardinale tedesco. «Certamente non persone come Peter Thiel. E Trump può avere buone intenzioni, ma non è uno che riflette a fondo sulle cose».
Il cardinale Müller ha criticato anche lo Stato laico moderno, che si dichiara neutrale ma in realtà impone la sua moderna pseudo-religione sotto le mentite spoglie della «scienza».
«Uno Stato che si dichiara neutrale dal punto di vista religioso non ha né la legittimità né la competenza per interferire in questioni etiche e religiose», ha affermato. «Tuttavia, la politica trasgredisce questo principio e definisce la propria visione del mondo come scienza».
«Anche la teoria razziale si proclamava scientifica, così come l’eugenetica scientifica. Queste erano tutte pseudoscienze, così come l’ideologia LGBTQ».
Aiuta Renovatio 21
«Quest’ultima non ha nulla a che fare con la scienza perché contraddice il fatto biologico che gli esseri umani sono maschi o femmine, anche se possono esserci individui con disturbi dello sviluppo», ha affermato il cardinale. «Non si può semplicemente inventare qualcosa. Non esiste il genere sociale».
Il cardinale Müller ha avvertito che avere solo un «cristianesimo culturale» non è sufficiente e renderà impossibile alle nazioni cristiane difendersi dalle ideologie malvagie.
«Ciò significa che non si può resistere a nulla, non si può affrontare alcuna sfida, come l’arrivo di un’altra religione completamente diversa dalla nostra”, ha affermato. «Lo abbiamo visto nel nazionalsocialismo e nel comunismo”.
«Dostoevskij diceva: Se Dio non esiste, allora tutto è permesso. Senza Dio non c’è moralità. Un cristianesimo puramente culturale non fa che creare idoli».
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Spirito
Concilio Vaticano II, mons. Viganò contro papa Leone

Chi si aspettava un qualche esame di coscienza da parte di Leone dopo sessant’anni di immani disastri, è servito: Prevost ci invita a riscoprire l’indole profetica del Concilio Vaticano II – «aurora di un giorno di luce per tutta la Chiesa» – e ad attuarne con maggiore… https://t.co/HreWBrWeA8
— Arcivescovo Carlo Maria Viganò (@CarloMVigano) January 8, 2026
Aiuta Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Geopolitica1 settimana fa
Geopolitica1 settimana faFAFO Maduro, dottrina Donroe e grandi giochi di prestigio – Europa compresa
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori dell’anno 2025 – prima parte
-



 Storia2 settimane fa
Storia2 settimane faDa quanto tempo l’industria controlla la regolamentazione dei vaccini?
-

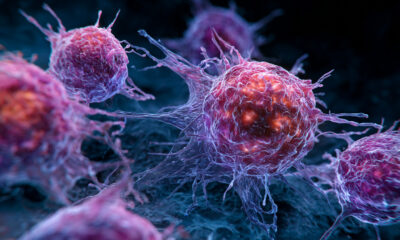

 Cancro1 settimana fa
Cancro1 settimana faVaccini COVID-19 e cancro: l’argomento tabù
-



 Immigrazione1 settimana fa
Immigrazione1 settimana faUn altro capodanno nell’anarco-tirannia migratoria
-



 Pensiero4 giorni fa
Pensiero4 giorni faGli uomini invisibili di Crans-Montana
-



 Salute2 settimane fa
Salute2 settimane faI malori dell’anno 2025 – seconda parte
-



 Stragi1 settimana fa
Stragi1 settimana faDisco-inferno: strage di Capodanno nella prestigiosa stazione sciistica svizzera – video












